INGEBORG BACHMANN – Letteratura come utopia. Lezioni di Francoforte – Adelphi
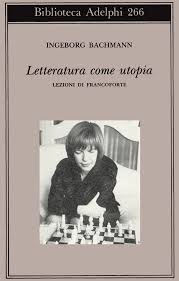 “Ferito di realtà e in cerca di realtà, consegna la propria esistenza alla lingua” (Paul Celan)
“Ferito di realtà e in cerca di realtà, consegna la propria esistenza alla lingua” (Paul Celan)
Il testo raccoglie le cinque lezioni tenute dalla Bachmann nell’inverno 1959/60, con le quali fu inaugurata la cattedra di Poetica presso la Johann Wolfgang Universitat di Francoforte sul Meno. Il ciclo fu intitolato “Problemi di poetica contemporanea”.
A lezione da Inge. Appunti
I Lezione: Domande e pseudodomande
Dalla cattedra da cui sta parlando, Ingeborg Bachmann dichiara che non le sarà possibile insegnare nulla, bensì, forse, risvegliare qualcosa: “pensare insieme la disperazione e la speranza con cui alcuni mettono in discussione se stessi e la nuova letteratura”. C’è una sola e grave domanda su cui ogni scrittore deve prendere posizione, ed è quella che riguarda la giustificazione della sua esistenza: “Su che cosa scrivere, per chi, e a che cosa dare voce al cospetto degli uomini, in questo mondo?”.
Ogni scrittore che osa assegnarsi da solo un compito lo sente sempre come arbitrario e ambiguo, si sente in debito nei confronti della verità; “non dovrebbe egli diffidare di ogni propria parola, di ogni propria finalità, perfino di se stesso?”. Quando si comincia a parlare di fine della poesia, non si deve dimenticare che una delle premesse di tutto questo va cercata negli stessi poeti, “nel dolore che essi hanno patito per la propria insufficienza e nei loro sensi di colpa”. Oggi alla precarietà dell’esistenza poetica si aggiungono l’insicurezza di ogni tipo di relazione, la dissoluzione delle categorie di spazio e di tempo, la necessità di ridefinire la realtà che la scienza ha ridotto ad un coacervo di formule e, infine, la difficoltà di istituire un rapporto di fiducia tra io, linguaggio e cose. “Io sono convinta che dove non vengono sollevate le eterne, sempre nuove domande che non risparmiano nessuno sul perché e sul fine ultimo delle cose, e le altre che a queste si legano, compresa, se volete, la questione della colpa, e dove nell’autore stesso non esista il dubbio, il sospetto, e cioè la vera problematica, là, io credo, non può nascere nuova poesia”. La questione del linguaggio – prioritaria nella Bachmann – inizia a porsi esattamente a questo punto. Non ha senso tentare di rinnovare la lingua in sé, come se essa fosse in grado, da sola, di far emergere conoscenze ed esperienze: al contrario, “la realtà acquista un linguaggio nuovo ogni qualvolta si verifica uno scatto morale, conoscitivo. Tutti adoperano la lingua e credono di conoscerla, lo scrittore non può adoperarla perché lo spaventa e non gli appare qualcosa di ovvio. “Per ciò che lo scrittore vuole, per ciò che vuole dalla lingua, essa non ha ancora le carte in regola; e quindi all’interno dei confini che gli sono dati, lo scrittore dovrà fissare i segni della lingua, dovrà riportarla in vita seguendo un rituale, dovrà darle un ritmo che mai essa trova se non in un’opera d’arte letteraria. E qui la lingua ci concederà di prendere in considerazione la sua bellezza, di sentire questa bellezza, ma obbedirà a una trasformazione che non intende sollecitare, né in prima né in ultima istanza, il piacere estetico, ma piuttosto una nuova capacità di comprensione del reale”. Come riuscire a distinguere l’autenticità di un fenomeno poetico? Sicuramente non cercando nelle opere i segni distintivi della qualità, perché la qualità è variabile, discutibile e addirittura contestabile. Il poeta esiste realmente in quanto ha una direzione, segue una traiettoria per la vita e per la morte, il cui accesso è vietato a ogni cosa o parola casuale. Un poeta è inevitabile per il coerente manifestarsi degli stessi problemi e di un unico e irripetibile universo di parole, figure e conflitti. Il poeta si riconosce perché, disperato, è costretto ad appropriarsi del mondo intero pur sentendosi colpevole per l’arroganza di volerlo definire”. E il suo compito gli si rivela nel momento in cui capisce di non avere altra scelta, di non poter sfuggire a se stesso”. Nel nostro tempo esiste un dramma per il poeta che è diventato palese: ha davanti agli occhi tutta l’infelicità dell’uomo e del mondo e con la sua opera non fa che sanzionarla. Ma oggi la gente sembra non aver bisogno di poesia, “ha bisogno di cinema e rotocalchi come ha bisogno di panna montata”, mentre la poesia dovrebbe stridere tra i denti come sabbia e risvegliare la fame piuttosto che placarla, “una poesia che dovrà essere affilata di conoscenza e amara di nostalgia se vorrà scuotere l’uomo dal suo sonno. Dormiamo, infatti, dormiamo per paura di dover percepire il mondo intorno a noi”.
II Lezione: Sulle poesie
Non sarà una dissertazione, ma un vagabondaggio “per chinarci su una qualche parola, o magari raccoglierne un’altra alla quale, all’inizio, non abbiamo dato peso”. Parlare della lirica contemporanea si rivela difficile per una serie dimotivi: chi scrive poesie in proprio, come chi sta parlando, ha in proposito un sapere più limitato di quanto si pensi; noi tutti veniamo a conoscenza di quanto avviene in altri paesi solo dopo molto tempo; quando la poesia possiede una nuova capacità di comprensione, essa resta celata tra le pieghe della lingua di origine e la traduzione può facilmente snaturarla; nel campo della poesia lirica fiorisce, come in nessun altro ambito letterario, la gramigna del dilettantismo e in nessun luogo è più difficile stabilire per il lettore se questo o quell’autore valga qualcosa oppure no. Per tutti questi motivi non verranno qui presentati in bell’ordine, etichettati e catalogati, tutti i poeti nuovi, esistono per questo saggi e antologie, ma si intraprenderà dunque un vagabondaggio nei territori della nuova poesia. Innanzitutto, non chiediamoci “che cosa ha voluto dirci il poeta?”, ma piuttosto: “Quali mai potrebbero essere le nostre osservazioni, che cosa potrebbe nascere dalla lettura di una poesia”. Oggi non possiamo più immaginare il poeta come profeta, o artista o mago, i veri poeti oggi non hanno niente di compiaciuto e di arrogante nel modo di concepire se stessi, come non si può parlare per la poesia di sacro canto o di missione. I “puri empirei dell’arte” non sono sopravvissuti. L’Espressionismo, il Surrealismo, il Futurismo hanno condotto le loro rivolte estetiche ed hanno portato a conquiste nel campo della lingua e della realtà che sono valide ancora oggi, anche se “da un certo punto di vista appaiono ai nostri occhi orribilmente screditate”. Tutte queste correnti hanno condotto all’estremo il principio de “l’art pour l’art”. Si deve ora porre la questione della responsabilità nell’arte. “Noi siamo forse diventati sensibilissimi e vigili e ostili sino all’eccesso verso l’ubriacatura verbale da un lato e il conservatorismo linguistico piccolo-borghese dall’altro, verso una malattia di maniera come verso una sanità altrettanto di maniera, non siamo quasi pronti, ormai, a non farci più sedurre da nessuno? Il nostro unico e ultimo desiderio non è forse quello di stabilire un nuovo rapporto di diritti tra uomo e linguaggio?”. “Che cosa è dunque la letteratura che abbiamo alle spalle: parole ritagliate dalle pareti del cuore e tragici silenzi, e maggesi di parole abusate, pantani di silenzio maleodorante e vile […] ma dove ha inizio il coinvolgimento che ci lega a una verità nuova?”. Ci sono oggi poesie che ci rendono infelici e se esistono poeti capaci di tanto, ciò accade perché anche in noi esiste uno strappo conoscitivo per impulso del quale siamo in grado di ripercorrere in tutta la sua pregnanza il loro strappo conoscitivo. Le rivoluzioni in letteratura, cioè l’acquisizione ad essa di nuovi territori, non vanno cercate nelle sperimentazioni formali, perché ciò può avvenire solo in conseguenza di un nuovo modo di pensare. La sperimentazione linguistica può essere solo bricolage e artificio, un gioco di destrezza, se ci lasciamo abbagliare non riusciremo più a distinguere chi “viene rapito dalla lingua e dalla verità, dove il non imitabile ha divorato ciò che è imitabile”. E’ anche vero che la radicalità di ogni forma di estetismo ci ha lasciato una sola certezza vincolante: i buoni sentimenti non bastano da soli a fare una buona poesia. Non cerchiamo poesie godibili, ma dense di conoscenza, “come se dovessero fare qualcosa per lenire la disperazione in un’età di estrema miseria linguistica derivata da un estremo smarrimento. E così facendo esse ricevono una nuova dignità alla quale non osano nemmeno aspirare”. Le parole depongono maschere e veli, nessuna parola ne evoca un’altra né la rende ebbra. “Sono poesie scomode, sono scandagli, attendibili, così attendibili nel dare il nome alle cose che non ci resta altro da dire se non: fin qui e non oltre”.
III Lezione: L’Io che scrive
Argomento: l’Io e la sua presenza nella letteratura. Che cos’è l’Io? Un astro di cui posizione e orbita non sono mai state del tutto individuate e il cui nucleo è composto di sostanze ancora sconosciute. Potrebbe essere formato da miriadi di particelle, oppure potrebbe essere un nulla, una sostanza sognata, una identità sognata. “Ma esistono gli scienziati e i poeti che si rifiutano di abbandonare l’impresa, e vogliono individuare, studiare, indagare e fondare l’Io, e rischiano quindi in continuazione di uscire di senno”. Ci si abitua a considerare l’Io un’ovvietà, una parola logora e usurata, salvo poi, improvvisamente, pronunciarla con un senso di affanno, di stupore, di orrore, di dubbio e di incertezza. In letteratura esistono molti Io e nessun accordo sull’Io. Nella letteratura degli ultimi decenni ogni giorno l’Io si fa più scatenato e ammaliante. “Come se in suo onore si fosse organizzata una carnevalata durante la quale, nei suoi abiti buffoneschi, l’Io potesse dichiararsi o dissimulare, mutarsi o svelarsi in quanto tale, questo Io che è al tempo stesso qualcuno e nessuno”. I lettori molto giovani, leggendo, vedono solo e semplicemente un Io, quello dello scrittore, con il quale, al massimo, immedesimarsi. Ma poi tutti abbiamo vissto un’esperienza nuova, abbiamo notato le interferenze tra autore e Io, “e infine abbiamo riconosciuto tutti i possibili Io che compaiono nella letteratura, l’Io fittizio, l’Io mascherato, l’Io ridotto, l’Io lirico assoluto, l’Io come figura del pensiero, come figura dell’azione, un Io immateriale o un Io che si è fatto materia”. L’Io più semplice lo troviamo nei romanzi autobiografici nei quali l’autore attua “un tentativo selvaggio e spericolato di eludere la concezione dell’Io” e scrive come se lui fosse credibile, come se la sua esistenza scevra da ogni finzione avesse per noi qualche interesse, come se fosse possibile portare in un libro la propria persona, la propria vita, senza mediazione alcuna”. In ogni altro tipo di romanzo e nella poesia si manifesta invece il desiderio di distruggere o di esautorare l’Io, o invece di rifondarlo. Il modello ormai classico del moderno racconto in prima persona è già un artificio che non manca mai di produrre il suo effetto perché continua a risvegliare la nostra curiosità e il piacere di giocare a rimpiattino con un Io che deve nascondersi per meglio potersi svelare. Ma è nel XX secolo che nella letteratura compare il disagio nei confronti del proprio Io. Ne “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo la domanda che domina tutto il libro è sempre e soltanto una: “Chi sono io?”. Quello che noi riteniamo essere il volto di Zeno Cosini è ora un’illusione ora una maschera, e poi, ad un tratto, di nuovo il suo vero volto. “Questo Io non sa neppure con chiarezza qual è il suo vero spessore, le sue qualità, e infatti di lì a non molto tempo giungerà un altro scrittore e metterà esplicitamente, nero su bianco, il suo “Uomo senza qualità”. Tra l’Io del XIX secolo e l’Io di un libro come “La coscienza di Zeno” si spalanca un abisso. L’Io non è più nella storia, ma è la storia a essere nell’Io. Se l’Io è dissolto, nemmeno il racconto è più garantito, ma l’Io si è fatto più ricco proprio grazie alla perdita di certezze. Il romanzo di Marcel Proust “Alla ricerca del tempo perduto” coronerà l’opera. Perché Proust non affida all’Io il ruolo di protagonista in quanto persona o in quanto portatore dell’azione, ma lo spinge alla ricerca in ragione dell’unica qualità che possiede, quella della memoria. “L’Io proustiano è molte cose insieme, ma per se stesso, come strumento, non è un enigma. E’ tranquillo, ha fiducia nelle proprie capacità: nella sua ricerca del tempo perduto assume il ruolo di vettore di una conoscenza che certo non produce risultati parziali, bensì riedifica la totalità della nostra esperienza e quindi assume la valenza di una summa”. Nel romanzo tedesco “Fiume senza sponde” di Hans Henny Jahnn, l’Io enigmatico non conduce alle profondità del tempo, ma nel labirinto dell’esistenza e nelle mostruosità dell’anima. Qui l’Io non è una grandezza fissa, ma muta senza posa, di esso non si può dire come e chi fosse in passato, “essendo un Io che scorre e si perde in un mare agitato dal quale emerge ogni volta rinnovato. E’ un Io che soffre perché non possiede una ben precisa personalità, perché è ridotto a strumento di un cieco divenire, senza legami o rapporti nei quali potersi definire. Arriviamo a Samuel Beckett e al suo ultimo romanzo “L’Innominabile”: un monologo senza inizio né fine, dell’Io alla ricerca disperata di sé. In lui sono venuti meno personalità, identità, storia, mondo circostante e passato e il suo anelito al silenzio minaccia di annientarlo. Si è arrivati ad una vera e propria liquidazione dei contenuti, ma la coazione a parlare permane e la rassegnazione è impossibile, così l’Io oltraggiato e umiliato, derubato di ogni contenuto, continuerà a dire parole, fin quando ce ne sono. Perché non è forse vero che la letteratura continuerà sempre in situazioni nuove e con parole nuove a dare voce all’Io? “Il miracolo dell’Io è appunto questo: dovunque parli, l’Io vive; non può morire – per quanto schiantato, o oppresso dal dubbio, non più credibile e amputato – questo Io privo di garanzie!”.
IV Lezione: Il rapporto con i nomi
Il nome è già in sé sufficiente per essere nel mondo. “Non esiste nulla di più misterioso dello splendore dei nomi e del nostro attaccamento a tali nomi, e nemmeno la non conoscenza delle opere che li illustrano impedisce a Lulu e a Ondina, a Emma Bovary e Anna Karenina, a Don Chisciotte, a Rastignac, a Enrico il Verde e a Hans Castorp di condurre una esistenza trionfale”. Per questo la questione del nome per gli scrittori è molto importante, i nomi dei personaggi, ma anche dei luoghi e delle strade che la letteratura disegna sulla sua straordinaria carta geografica che solo in pochi punti coincide con quella dei geografi. I veri luoghi in cui siamo stati davvero sono forse i luoghi letterari e la fedeltà a questi nomi, di luoghi e di personaggi sembra a volte l’unica fedeltà di cui gli esseri umani sono capaci. Il nostro rapporto con loro è diventato inesorabile, tanto che non riusciamo a dimenticarli. “Siamo esseri tramandabili e dobbiamo tramandare il meglio. Così a quanto pare è stato stabilito”. Nella letteratura più recente sono accadute però delle cose che fanno riflettere: un consapevole indebolimento dei nomi e una incapacità di attribuire nomi. Oggi non è più così facile dare un nome alle cose, è ormai scossa la fiducia nella innocente possibilità di dare nomi e anche gli autori che continuano a farlo raramente riescono a consegnarci un nome che sia qualcosa di più di una piastrina di riconoscimento, un nome da tenere a mente e con il quale cominciare ad avere un rapporto. Thomas Mann è l’ultimo grande inventore di nomi, un mago dei nomi. “Ma i suoi nomi posano come ironici drappeggi sulle sue figure comiche e tragiche, come una serie di ben meditate accentuazioni”. Anche in James Joyce a prima vista i nomi sembrano stabili, ma poi anche loro vengono colpiti dal sommovimento del linguaggio, dalla sua aggressiva dissoluzione. “In Joyce i nomi possono essere distorti per significato e suono, possono essere fatti impazzire, essere scritti scorrettamente o messi fuori posto, ma sempre in modo tale che rimanga un’allusione al nome originario”. Dunque rifiuto del nome, ironia e giochi di nomi, con o senza significato, stravolgimento dei nomi, ma c’è di peggio: in “L’urlo e il furore” di Faulkner i nomi sono simili a trappole, sono scritti ogni volta in modo diverso e il lettore deve riconoscere i personaggi da altre loro caratteristiche, come l’alone che li circonda, o dalla costellazione di stati d’animo in cui sono iscritti, o da brevi citazioni che li introducono. Più che ai nomi, è importante prestare attenzione al contesto nel quale il nome viene citato. “Il metodo di Faulkner è il seguente: distoglierci dai nomi per precipitarci nella realtà direttamente, senza spiegazioni. E non è lui, l’autore, ad arrogarsi i nomi, non è l’autore a presentarceli, a prevenire le confusioni. Sono invece le figure a conoscersi tra loro, solamente loro a chiamare se stesse e altri per nome, e, come nella realtà, noi dobbiamo vedere da soli fin dove siamo capaci di arrivare”. Proust, infine, ha fatto dei nomi e dell’esperienza dei nomi il tema del suo romanzo. Ha immerso alcuni nomi in una luce magica, li ha riempiti di senso e poi li ha gettati via come gusci vuoti, “marchiandoli a fuoco come usurpatori”.
V Lezione: Letteratura come utopia
La letteratura. Tutti noi disprezziamo, rivalutiamo, trattiamo la letteratura come se fosse qualcosa di fisso, ma, al tempo stesso, la manipoliamo sino a farla assomigliare a un ideale. Ma che cosa intendiamo per letteratura? E’ un ideale che rivediamo e correggiamo a nostro piacimento, nel quale manteniamo alcuni fatti e altri ne escludiamo, perché l’entusiasmo che proviamo per una parte della letteratura implica il rifuto del resto e non è escluso che in futuro i nostri idoli vengano abbattuti e siano costretti ad uscire di scena per un certo periodo. Allora la letteratura “è la speranza, è il desiderio cui noi diamo forma attingendo al nostro patrimonio secondo le nostre esigenze, è un regno aperto al futuro di cui non conosciamo i confini”. Sulla letteratura non è possibile un giudizio obiettivo ma solo un giudizio vivo (così come nel corso della nostra vita siamo soliti modificare più volte il nostro giudizio su un autore). La letteratura non è un fatto compiuto, ma un territorio aperto che si sottrae ad ogni accordo e catalogazione definitivi. Tutti i presupposti insiti nelle sue opere si possono definire utopici, altrimenti la letteratura sarebbe un cimitero, ogni opera sarebbe sostituita e migliorata da quella successiva, ogni opera sepolta da quella che viene dopo. “La letteratura, che da sé non sa neanche definirsi, che si dà a conoscere solo come affronto più che millenario e mille volte compiuto contro una lingua brutta – perché la vita possiede soltanto una lingua brutta – e con questo affronto contrappone alla vita una utopia della lingua; questa letteratura, per quanto strettamente possa essere legata al tempo e alla sua brutta lingua, deve essere lodata per il suo disperato muoversi verso quella utopia e solo così essa può dirsi vanto e speranza degli uomini. I suoi linguaggi più preziosi, nonché quelli più volgari partecipano ancora di un sogno linguistico; ogni vocabolo, sintassi, periodo, interpunzione, metafora, ogni simbolo esaudisce qualcosa di quel nostro sogno di espressione che non sarà mai pienamente realizzato”. L’importante è continuare a scrivere: “A ogni cedimento delle prove, il poeta risponde con una salva di avvenire” (René Char)