CURZIO MALAPARTE – Kaputt – Adelphi
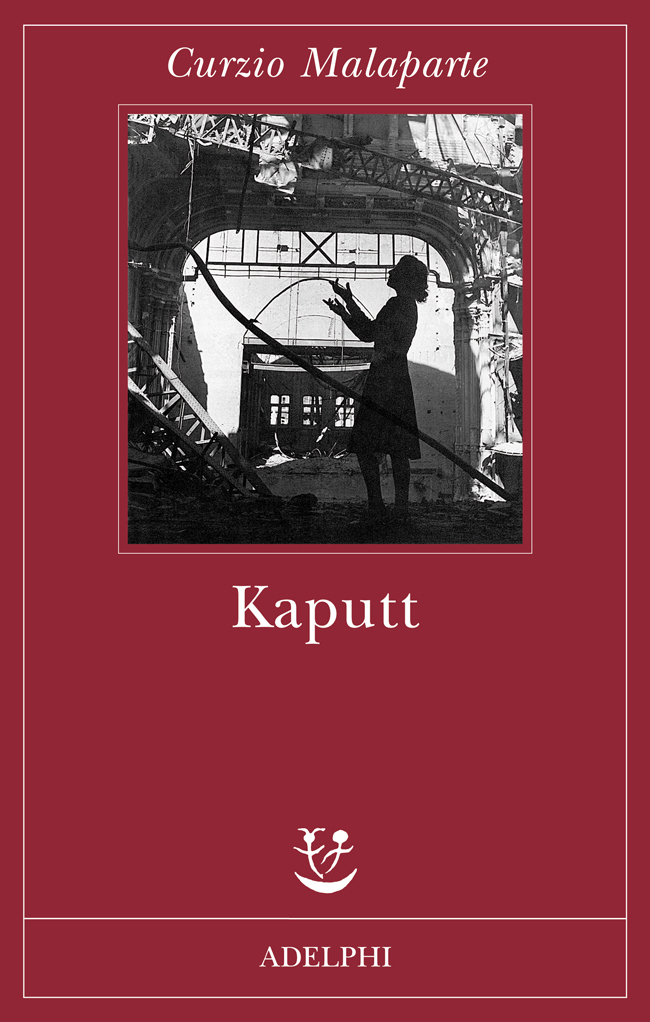 “Tutti hanno l’occhio disperato della renna. Sono bestie, penso, sono bestie selvatiche, penso con orrore. Tutti hanno nel viso e negli occhi la bellissima meravigliosa mansuetudine e tristezza delle bestie selvatiche, tutti hanno quell’assorta e malinconica pazzia delle bestie, la loro misteriosa innocenza, la loro terribile pietà. Quella pietà cristiana che hanno tutte le bestie. Le bestie sono Cristo, penso, e mi tremano le labbra, le mani mi tremano”.
“Tutti hanno l’occhio disperato della renna. Sono bestie, penso, sono bestie selvatiche, penso con orrore. Tutti hanno nel viso e negli occhi la bellissima meravigliosa mansuetudine e tristezza delle bestie selvatiche, tutti hanno quell’assorta e malinconica pazzia delle bestie, la loro misteriosa innocenza, la loro terribile pietà. Quella pietà cristiana che hanno tutte le bestie. Le bestie sono Cristo, penso, e mi tremano le labbra, le mani mi tremano”.
“Kaputt” è un libro che si impone e si fa amare con l’imperiosità del capolavoro, ma amarlo è una fatica che richiede impegno ed abnegazione, amarlo è il premio che si ottiene alla fine di un percorso accidentato e dolorosissimo. “Kaputt” è un libro che si ama nonostante le perplessità che suscita in alcune sue pagine, nonostante le domande a cui non dà risposte, nonostante la confusa sensazione di leggere il resoconto di una immane tragedia attraverso gli occhi di un privilegiato per sorte e convenienza politica, di un potente che con i potenti ha a che fare, che soffre e di indigna per le loro colpe, maneggiando spesso l’arma spuntata del motto di spirito, tollerato e benvoluto da chi di tanto orrore è corresponsabile, capace di dosare disgusto e compassione, di camminare, senza cadere, sul filo di un instabile equilibrio. “Kaputt” è un libro che si fa amare nonostante l’irritazione e l’indignazione che sorgono spontanee nel lettore, costretto da Malaparte a sostare insieme a lui nelle stanze del potere, nei palazzi del potere di mezza Europa che, nel bel mezzo degli anni più bui della guerra, sopravvivono come isole fortunate, noncuranti dell’umana disperazione che le circonda. Nonostante tutto questo, “Kaputt” si impone, travolge sospetti e difese, costruisce con la potenza di una scrittura raffinatissima e lussureggiante, un affresco pieno di ombre, e dove le ombre si fanno più cupe, penetra e scava, con uno stile a tratti maestoso, capace di decantare l’epica dell’orrore, di suscitare disgusto per tramutarlo in pietà e di lenire il rimpianto e la nostalgia con gli accenti poetici di una umanissima tenerezza.
“Kaputt è un libro crudele” – lo afferma l’autore nella sua introduzione – e il protagonista del romanzo è proprio “Kaputt, questo mostro allegro e crudele”, la misteriosa e dura parola tedesca che letteralmente significa “rotto, finito, andato in pezzi, in malora”, perché questo è ciò che la guerra, il paesaggio oggettivo del romanzo, ha fatto all’Europa, alle sue città, ai suoi popoli, ai suoi inestimabili tesori di arte, cultura, socialità ed identità, lasciando alla fine in vita solo spettri. “E anch’io” – afferma Malaparte – “ero certo uno spettro, lo spettro opaco di un’età remota, forse felice, di un’età morta, forse, forse felice”. Uno spettro colmo di un rancore triste e crudele che lo accompagna mentre svolge il suo compito di corrispondente di guerra italiano al seguito delle truppe tedesche, nel 1941 in Ucraina, nel 1942 in Polonia, in seguito in Finlandia e che continua ad accompagnarlo, nel luglio del 1943, dopo la caduta di Mussolini, al suo ritorno a Napoli. Malaparte è uomo di grande cultura e di vaste relazioni, si muove bene tra ambasciate e ministeri, intrattiene relazioni privilegiate con molti esponenti della nobiltà europea, è di casa presso le più potenti famiglie romane, a vari livelli conniventi per ideologia e convenienza con le più alte gerarchie fasciste, e tutto questo sostiene e motiva la cornice, la struttura portante di “Kaputt”, questo resoconto di “una guerra perduta”, quella cornice che suscita la perplessità del lettore che non può non avvertire – a tratti con vero fastidio – se non la complicità dell’autore, sicuramente una sua opposizione solo interiore, si potrebbe dire spirituale, al crudele potere di una ideologia dei cui drammatici effetti egli è consapevole testimone. “Io ho perso l’abitudine di agire […] Sono un italiano. Non sappiamo più agire, non sappiamo più assumere alcuna responsabilità, dopo venti anni di schiavitù. Ho anch’io, come tutti gli italiani, la schiena spezzata. In questi venti anni abbiamo speso tutta la nostra energia per sopravvivere. Non siamo più buoni a nulla. Non sappiamo che applaudire”.
Malaparte, che non sa agire, ha però gli occhi bene aperti per vedere e tra le mani uno strumento bene affilato, una penna che incide, scava e affida per sempre alla memoria storie, immagini, squarci di vita disperata, di morte, di inconsolabile e sommamente ingiusto dolore, e costruisce un monumento vivo alla umana pietas. E’ il potere della letteratura, la fascinazione della letteratura. “Kaputt” non è un documento, non è una testimonianza – documenti e testimonianze, anche crude, sono destinati a impallidire, colpevolmente, nella memoria – “Kaputt” è visione, sogno ed incubo, lavora con le parole ma costruisce immagini indelebili che sono monumenti all’umana abiezione, all’umana miseria. La pietas è la cifra di questo romanzo, la pietas che lentamente investe e sommerge il mondo, che una volta era umano e una volta, forse, felice. “Kaputt” non è un libro disumano; nelle sue pagine, anzi, c’è tanta affezione per l’umanità, mai dichiarata esplicitamente, ma raccontata, dipinta, sottintesa, una affezione così grande da costringere lo sguardo a seguirla fino in fondo, fino alla offesa estrema all’essenza dell’uomo, e anche oltre, fino a quel residuo di vita che lo avvicina alla bestia. Forse è proprio per questo che Malaparte sceglie di dedicare agli animali i titoli delle sei parti che compongono il suo romanzo – cavalli, topi, cani, uccelli, renne e mosche – regalando loro una straordinaria potenza metaforica che si aggiunge però – esaltandola – alla loro essenza di creature, anch’esse coinvolte a vari livelli in quella follia crudele che, se è incomprensibile alla maggior parte di una umanità sofferente, lo è ancor di più se riflessa nei loro occhi, inconsapevoli e, perciò, innocenti (“misteriosa innocenza e terribile pietà”).
E’ con un misto di pungente nostalgia, sconsolato rimpianto, estremo rispetto nel riconoscimento di un valore per sempre e stupidamente perduto che Malaparte rievoca “la dolcezza del viver sereno, che un tempo era stata la grazia dell’Europa”, e lo fa ogni volta che, nel rendere conto degli spostamenti a cui lo obbliga il suo incarico, conduce il lettore in una capitale, nel cuore antico di città morenti: “Muore tutto ciò che l’Europa ha di nobile, di gentile, di puro”. Sono pagine che decantano il rimpianto con l’arma della poesia. Stoccolma: “Nelle strade immerse in una luce azzurra, sotto il cielo di seta pallida, nell’aria illuminata dai bianchi riflessi delle facciate, le donne passavano simili a comete d’oro azzurro”. Il cielo di Parigi: “… e quei vermigli spenti, quei rosa accesi, quei grigi azzurri delle nuvole nel delicato accordo col nero sfumato dei tetti di ardesia, dolcemente mi stringevano il cuore”. Varsavia: “Dalle quiete stanze, odorose d’incenso, di cera, e di wodka, della piccola casa nel vicoletto che si apre in fondo alla Piazza del Teatro […] si udivan le campane delle cento chiese della Stare Miasto squillare nell’aria gelida e pura della notte d’inverno”. Helsinki: “Un magro odor di mare giungeva dal fondo dell’Esplanade. Alle facciate lisce e chiare dei palazzi l’ombra degli alberi si appoggiava lieve, era un’ombra di un verde chiarissimo, come se gli alberi fossero di vetro”. Leningrado: “L’immensa, grigia città, sullo sfondo verde dei boschi, dei prati e delle paludi, mandava strani riflessi metallici nel sole notturno: a volte pareva una città di alluminio, tanto il bagliore era dolce e spento, a volte una città di acciaio, tanto il bagliore era freddo e crudele, a volte una città d’argento, tanto il bagliore era vivo e profondo”, e infine Roma con il suo “cielo di miele”: “L’immensa distesa dell’Agro romano apriva davanti agli occhi le sue profonde prospettive d’erba gialla, di terra bruna, di alberi verdi, dove splendevano solitari nel sole d’ottobre i sepolcri di marmo, i rossi archi degli acquedotti”. Un paradiso perduto, perché chi abiterà ciò che ne rimane non potrà mai più prescindere da ciò a cui ha assistito.
E la penna di Malaparte racconta, guidata da una pietas tanto intensa che sembra accomunare vittime e carnefici e che vibra di pena persino per i soldati tedeschi, per i giovani Alpenjager bavaresi e tirolesi “sdentati, calvi, dal viso giallo e rugoso, dagli occhi umili e disperati di bestia selvatica”, che parlano della guerra con un segreto disprezzo e con rancore per le violenze, la fame, le distruzioni e i massacri, che hanno acquisito “la disperata umiltà delle bestie selvatiche […] quel misterioso sguardo di bestia che hanno gli occhi dei morti”. Ma “Kaputt” è un libro crudele e lo è sempre di più, pagina dopo pagina, soprattutto quando l’autore racconta ciò che ha visto sui vari fronti di guerra, racconta fino a che punto la violenza può stravolgere il cuore dell’uomo, e lo fa ogni volta con una fredda e brusca frase introduttiva che è come una porta aperta di colpo sulle tenebre, talmente efficace che il lettore impara presto a riconoscerla, a temere ciò che seguirà, a prepararsi all’orrore, al raccapriccio e allo sgomento: “E mi misi a raccontare della foresta di Raikkola, e dei cavalli del Ladoga”, “… e mi misi a narrare la cronaca dei fatti avvenuti nella nobile città di Jassy, in Moldavia, alla frontiera tra la Russia e la Romania”, “Allora io narrai dei cani dell’Ucraina, dei cani rossi del Dnieper”, “Allora io mi misi a narrare la storia di Spin, il cane del Ministro d’Italia, Mameli, sotto il bombardamento di Belgrado”, “Lasci che le racconti la storia delle ragazze di Soroca […] Soroca in Bessarabia, sul Dniester”.
“Kaputt” è un gorgo che trascina verso un fondo che si fa via via sempre più lontano e che attraversa barbarie inenarrabili, ma le racconta pietosamente e impietosamente. Conduce nel cuore della “città proibita”, nel ghetto di Varsavia, dove gli ebrei “muoiono come topi”, per quelle strade dove il silenzio è lieve e trasparente, rotto solo dal “leggero scricchiolio di mille passi sulla neve, simile a uno stridor di denti”. E in questo silenzio leva la sua elegia per i bambini ebrei, quelli che non camminano, perché “i bambini ebrei hanno le ali”. Racconta i pogrom e si fa aiutare da Chagall: “Poi, a poco a poco, il cielo si spense, la pioggia a un tratto cessò, la luna apparve in uno squarcio delle nuvole: sembrava un paesaggio dipinto da Chagall, popolato di angeli ebrei, di nuvole ebree, di cani e di cavalli ebrei, dondolantisi a volo sulla città. I suonatori ebrei di violino seduti sui tetti delle case, o librati in un cielo pallido a picco sulle strade, dove i vecchi ebrei morti giacciono sul marciapiede fra i candelabri rituali accesi. Le coppie d’amanti ebrei distesi a mezz’aria sull’orlo di una nuvola verde come un prato. E sotto il cielo ebreo di Chagall, in quel paesaggio di Chagall illuminato da una tonda luna trasparente, salivano dai quartieri di Nicolina, di Socola, di Pacurari, un clamore confuso, un crepitio di mitragliatrici, i tonfi sordi delle bombe a mano”. Alla fine, quando il lettore si aspetta una conclusione, un qualsiasi tipo di conclusione per una materia così ricca e densa, per questo viaggio nel cuore dell’indicibile, Malaparte regala uno stupefacente capitolo, “Il sangue”, che è un atto di amore viscerale per Napoli, la sua città ferita dalla guerra, e per la napoletanità. Napoli, “la più infelice, affamata, umiliata, abbandonata, torturata città d’Europa”. Non è la conclusione del romanzo, è una prosa cantata, un canto in levare che prelude a molto altro ancora, prelude a “La pelle” e lascia il lettore con un senso di stupita ammirazione per ciò che questo grande scrittore è riuscito a regalare alla cultura italiana.