Traduzione di Dóra Várnai
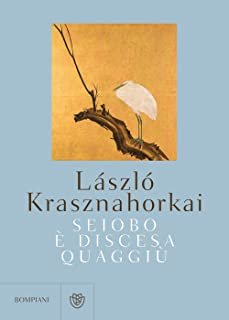
“… oggigiorno [..] non c’è più un sopra e un sotto, un alto e un basso, c’è solo un mondo, qui in mezzo, dove viviamo, dove passa la linea numero uno e la quattro e la sette, e dove c’è il Louvre, e dove al Louvre c’è la Venere che guarda un punto imperscrutabile, misterioso, lontano, se ne sta lì, a volte la mettono qui, a volte la spostano di là, e lei se ne sta dove la mettono, e volge orgogliosamente la testa in quella direzione misteriosa, e irradia, irradia la sua bellezza nel nulla, e nessuno capisce, e nessuno percepisce quanto doloroso sia questo spettacolo, una dea che ha perso il suo mondo, una divinità potente, immensamente potente – eppure ridotta a non aver più nulla.”
Dopo lo splendido ciclo di romanzi costituito da “Satantango”, “Melancolia della resistenza”, “Il ritorno del Barone Wenchkheim” e “Guerra e guerra”, Krasznahorkai torna disponibile per i lettori italiani con una raccolta di racconti ponderosa e ricchissima, che sollecita e interroga, andando a comporre, pagina dopo pagina, una sorta di specchio nel quale riconoscersi – perché ognuno di noi ha potuto sperimentare in alcuni momenti il potere della grande arte – e nel contempo perdersi, perché mostra gli abissi di una profondità e di una pienezza spesso solo intuite ma comunque sempre ricercate.
Non vi è dubbio che l’autore ungherese sia con la sua quadrilogia il cantore dell’apocalisse moderna, o meglio, il suo recensore o geniale e immaginifico cronista, colui che mostra, attraverso i suoi personaggi stralunati e i suoi paesaggi, urbani e non, in malinconico disfacimento, il lento e inglorioso avvio del mondo che conosciamo, e in cui siamo immersi, verso la sua fine. Un’apocalisse sempre sottesa e camuffata all’interno di storie e immagini che sono anche vivide metafore, enigmi e giochi strutturali che stupiscono e coinvolgono il lettore, richiedono la sua collaborazione, lo rendono in un certo senso complice dell’autore in un viaggio che sembra infinito, perché Krasznahorkai è uno scrittore estremamente generoso e non dispensa la sua meravigliosa scrittura a piccole dosi, ma al contrario la ama a tal punto da lasciarla scorrere come un fiume in piena.
E se è facile perdersi in tutto ciò, è anche facile accorgersi che questi romanzi costituiscono il quadro del disfacimento morale e materiale, della distruzione e del fallimento, come se l’apocalisse fosse insita nella natura dell’uomo e si riflettesse inevitabilmente nelle sue opere e nell’organizzazione sociale con cui egli tenta di migliorare la propria vita. Ma poi, quando il lettore crede di essere ormai giunto all’interno del cuore pulsante di questa splendida scrittura, di averne almeno intuito le dimensioni e la ragione ispiratrice, poi arriva Seiobo.
Arriva questa raccolta di diciassette racconti con questo titolo così oscuro ed enigmatico che pare avulso dai testi che accomuna. Bisogna arrivare nel cuore del libro, all’inizio dell’ottavo racconto, “La vita e l’arte del maestro Inoue Kazuyuki”, per incontrare Seiobo, la dea della mitologia giapponese che vive nelle sconfinate pianure celesti, nel radioso Regno della Luce, colei che può regalare all’uomo l’immortalità, a patto che il prescelto sia in grado di perdersi nella più pura contemplazione, di restare fermo e controllato, mantenendo il giusto rispetto e la giusta distanza nei confronti della divinità, ma anche degli accadimenti della propria vita. Seiobo scende quaggiù, sulla terra, in un episodio rappresentato dal teatro Nō, l’antica arte drammaturgica giapponese, a cui il maestro Kazuyuki consacra la sua intera vita, ricercando e insegnando la perfezione di gesti, voci e movimenti, consacrandosi dunque alla bellezza.
E’ proprio la contemplazione estetica, la produzione e la fruizione della bellezza veicolata dall’arte, intesa come unica via concessa all’uomo per uscire dalla dimensione mortale, per sfuggire all’apocalisse annunciata, il filo conduttore di questi racconti. Krasznahorkai si addentra dunque in un territorio dalle mille sfaccettature e dalle mille possibilità perché l’arte è l’altrove dell’uomo, è eversiva e rende eversivi coloro che, toccati dalla grazia, sono in grado di produrla, ma anche chi ad essa si avvicina, chi ne gode con una sorta di esaltazione mista però ad un nostalgico dolore, perché sa che la propria vita – la vita di tutti – è là in basso, lontana dalle sue vette. Oggetti preziosi, monumenti, santuari, musiche, quadri, icone, architetture, sculture, maschere teatrali sono il cuore intorno al quale la scrittura dei diciassette racconti si dipana con quel ritmo lento ma ugualmente impetuoso che i lettori dello scrittore ungherese conoscono bene.
Lento, rispettoso e scrupoloso perché questo è il modo migliore per accostarsi al miracolo tutto umano ma che tanto sa di divino, della creazione artistica; ma anche tumultuoso, il ritmo di una prosa che scorre veloce senza interruzione finché il suo respiro si placa con l’unico punto che decreta la fine di ogni lungo paragrafo, un ritmo che è forse lo specchio di ciò che la grande e ineffabile arte provoca nei nostri cuori costretti dal limite. Estasi e dramma, di questo sono colme le pagine di questi racconti, perché la bellezza consola mentre ferisce e viceversa, perché, non essendo di questo mondo, ad essa ci si può solo avvicinare, oppure si può servirla, prendendosene cura. Restauratori, guardiani di sala o custodi, donando se stessi a ciò che preservano o che custodiscono, rinunciano al mondo; artisti, appassionati, comuni mortali, ossessionati da ciò che diventa la loro passione, il loro pensiero dominante, finiscono per essere inadatti al mondo.
E l’autore, di volta in volta si addentra scrupoloso all’interno dell’oggetto artistico come un buon artigiano, un restauratore, un custode, oppure si immedesima con chi lo insegue, si danna per possederne l’anima, si lascia ferire da ciò che avverte come immensamente bello, con chi è in grado di provare quella sorta di “dolce dolore” che insieme dona e toglie la voglia di vivere. Tutto ciò a patto che si possieda ancora la capacità di contemplare, di lasciare che il tempo scorra, che il mondo scorra nella sua frenesia, e si sappia resistere “a quella dolce, leggera, eterna malinconia”.
Ormai i suoi lettori sanno che la scrittura di Krasznahorkai non è omologabile, sanno che sorprende e interroga, che spesso camuffa il proprio oggetto, che ama rivelarlo a chi ha la pazienza di seguire le tracce disseminate tra le righe di testi che arricchiscono la narrazione con vere e proprie prove di straordinaria erudizione. Come se ognuno di questi racconti fosse il frutto di un lungo apprendistato che l’autore abbia dovuto seguire per accostarsi al frutto della creazione artistica e voglia riversarlo nelle sue pagine, renderlo percepibile anche attraverso la struttura stessa dei suoi testi e persino grazie alla complessità e alla ricchezza formale che li contraddistingue. Percorrere le pagine di questo libro equivale in fondo ad addentrarsi in un museo personale, nella galleria che raccoglie e custodisce le opere delle varie arti più care all’autore, per mantenere viva la loro memoria, per attirare su di loro l’attenzione e possibilmente la contemplazione di una contemporaneità frenetica e distratta, concentrata unicamente nella ricerca del benessere e dei beni materiali, sempre più lontana dalla spiritualità.
Per questo Krasznahorkai si volge all’Oriente o al passato della cultura occidentale. All’antica arte cinese e giapponese che conosce così bene e a cui dedica sei dei suoi racconti, alle sue tradizioni che vedono l’artista come veicolo della divinità e l’arte come manifestazione del sacro; oppure alla pittura del Rinascimento italiano. Artisti così lontani nello spazio e nel tempo che hanno però in comune l’umiltà dell’artigiano e la capacità di maneggiare la materia finchè diventi manifestazione dello spirito. Il mondo contemporaneo invece sembra non aver più bisogno della trascendenza e l’ultimo bellissimo e terribile racconto, “Ululati sotterranei”, che dona voce e vita alle statuine antropomorfe cinesi della dinastia Shang, sepolte accanto alle tombe che devono custodire, può essere inteso come rappresentazione e metafora del destino dell’uomo che rinuncia o dimentica ciò che di più prezioso racchiude il suo spirito e si consegna al proprio inevitabile destino di essere mortale: “… e non rimane nient’altro se non l’oscurità sotto la pesante pressione della terra, e questo urlo, questo ululato, questo latrato, perché esso, questo urlo, questo ululato, rimane, e loro sono lì in piedi accanto alle tombe crollate, sono lì, inclinati su un fianco, sono lì, rotti in piccoli pezzi, mangiati dalla corrosione, incastrati nella terra, sepolti, ma sepolti con gli occhi spalancati e l’urlo che continua a uscire dalle loro bocche spalancate, perché in qualche modo ciò rimane, resta lì, rotto in pezzi, ma comunque rimane, nei millenni dei millenni: gli ululati di terrore, le urla di quel terrore stanno sempre e comunque a significare che l’universo sotterraneo, che il luogo della morte, che l’enorme e vasto e pieno spazio sotto il Mondo, che quel posto dove in definitiva tutti finiamo, esiste, ed esiste nella maniera più concreta e inequivocabile …”.
Un grande scrittore ungherese.
Hai ragione. Grandissimo.
Un autore che mi piace moltissimo
Anche a me. Spero che continuino ad uscire i suoi libri in Italia. L’ho conosciuto con i primi due volumi della sua quadrilogia che sono stati una vera rivelazione. Ciao!
Io ho letto Melancolia della resistenza, Guerra e guerra e Satantango. Tutti straordinari per linguaggio, fantasia, personaggi…