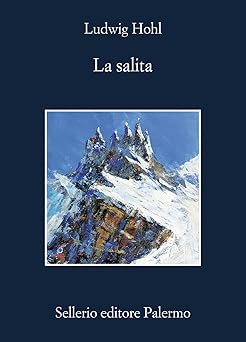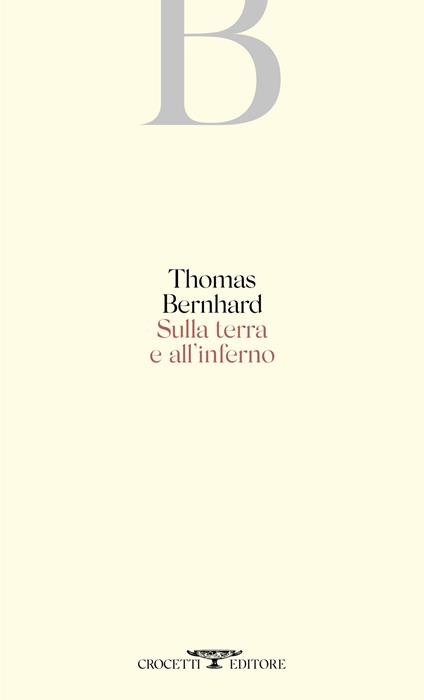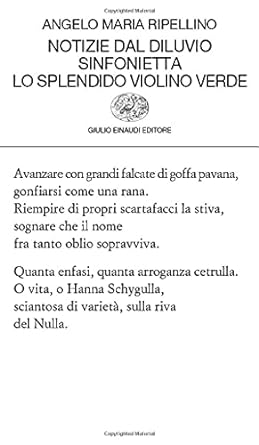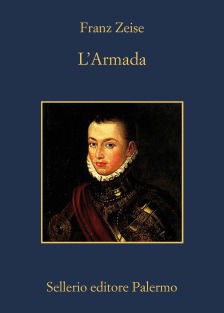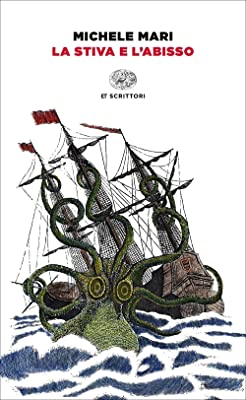Traduzione di Laura Angeloni
“La prima volta che vedi una mano staccata ti sembra impossibile, credi che sia un brutto sogno, e la seconda pensi: poveretto, sarà mutilato per sempre, e non puoi che superare il disgusto e distaccarti dalla realtà, perché è l’unico modo. E gli stringi il braccio con un laccio emostatico, per evitare che si dissangui, anche senza una mano si sopravvive no? E quando hai finito, tutto sudato e coperto di sangue, guardi bene il ragazzo e scopri che è morto. Allora ti senti svenire, e poi ti viene da vomitare, e da piangere, ma sai che non puoi, perché ti costerebbe la vita. Per fortuna l’adrenalina ti pompa nelle vene con una tale forza che nemmeno fai in tempo a renderti conto di quello che è successo. E la sera vorresti solo ubriacarti, ma non c’è niente da bere. E rimani così, staccato da tutto.”
Ho incontrato per la prima volta la voce letteraria di Bianca Bellová leggendo il suo bellissimo romanzo “Il lago” e la ritrovo qui con registri e stili in parte diversi, ma pur sempre riconoscibili. Per esempio riconoscibile è la capacità dell’autrice di gestire una trama complessa senza perderne le fila, intrecciandole, lavorandole, fino a condurle ad una conclusione dove tutto, anche ciò che è sottinteso, trova un senso.
La scrittrice costruisce quindi un labirinto e costringe il lettore a percorrerne quasi alla cieca i vari tratti, come se fossero narrazioni indipendenti, a formulare ipotesi sul senso ultimo di una vicenda che mescola il passato con il presente e la realtà con quel tanto di fantastico e di irrazionale che cerca di spiegarla o di darle un senso.
La capacità affabulatoria, che mi è sempre parsa una caratteristica degli scrittori cechi, trova una conferma nella prosa di questa scrittrice contemporanea che racconta in questo romanzo una lunga storia di famiglia e i suoi drammi oscuri che gettano ombre da una generazione all’altra, una storia che si esprime con voci e sensibilità estreme prevalentemente femminili, appartenenti a quelle donne che, come afferma l’autrice nella dedica iniziale, “tessono il collante del mondo”.