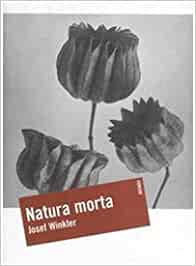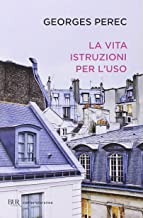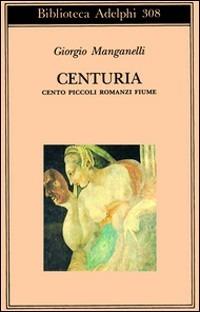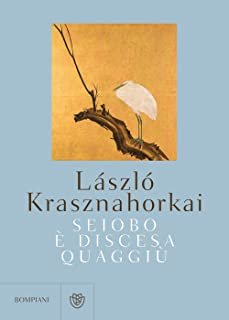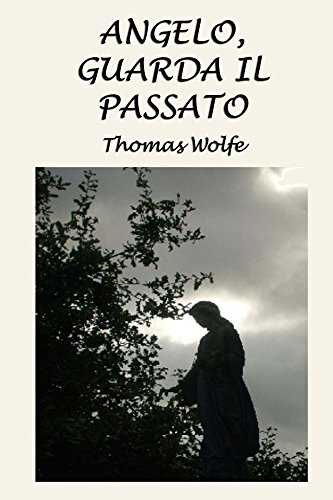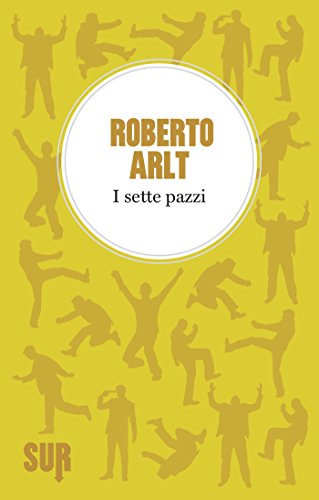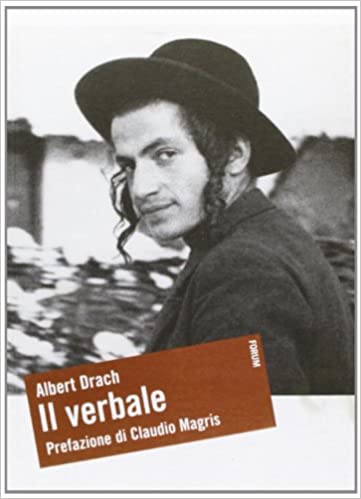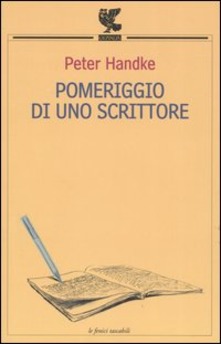Traduzione, cura e postfazione di Luigi Reitani
“Nella parte antica del Campo Verano, tra sarcofaghi monumentali in ferro e statue di angeli segnate dalle intemperie e ricoperte di muschio che reggevano fiaccole funebri, in camicia a mezze maniche e con un mazzo di ginestre rosse, grasso e confuso, si aggirava Frocio, miagolando e mormorando incessantemente <Buona notte, anima mia!>.”
Luigi Reitani, curatore della collana “oltre” delle edizioni “Forum”, regala ai lettori con questo libro, da lui tradotto e definito “novella romana”, la prima versione italiana di un’opera di Josef Winkler, lo scrittore austriaco originario della Carinzia che continua la grande tradizione letteraria di questa terra – che ha dato i natali a Robert Musil, Christine Lavant, Ingeborg Bachmann e Peter Handke – scegliendola anche come motivo ispiratore di una trilogia per ora non disponibile nella nostra lingua. Reitani arricchisce il volume con una postfazione che è in realtà un breve saggio ricchissimo di informazioni, richiami e suggestioni letterarie, dal titolo “La morte a Roma”.
Quella di Winkler è un’incursione, anzi una vera e propria immersione, in un aspetto grottesco e deleterio di una certa romanità, così come appare ai suoi occhi di straniero e di scrittore – romanità scelta probabilmente come esempio concreto e calzante di una ben più vasta umanità – un suo aspetto letterariamente inedito che l’autore sceglie appositamente per amplificarlo, stravolgerlo e deformarlo, portarlo al grado più basso della sua mera carnalità per farlo poi assurgere ad una inedita ed imprevista purezza di spirito. Il romanzo è costituito da affollate pagine descrittive attraverso le quali si va dipanando e componendo un esile filo narrativo che a sua volta si può leggere come una sorta di elegia romana nata dal fango: più la prosa è cruda, infatti, e più sorprendente e delicata è la poesia che ne scaturisce. La scrittura di Winkler trae spunto ed ambientazione da un’attenta e profonda osservazione di merci, persone, atmosfere che animano il mercato romano di piazza Vittorio Emanuele, uno dei più suggestivi mercati storici della capitale, colto e quasi fotografato in una giornata d’estate del 1992.
La natura morta del titolo costituisce un filo conduttore che permette al lettore di comprendere sia la struttura dell’opera che la sua natura allegorica, e di orientarsi quindi, percependo il sottile trapasso tra il disgusto e la pietà, tra la volgarità e la dignità a cui queste pagine lo conducono. “Nella tradizione figurativa”, scrive Reitani, “una natura morta è un dipinto che ritrae fedelmente degli oggetti inanimati, in particolare un insieme di elementi del mondo vegetale e animale, talvolta frammisti a utensili o ad altri artefatti, disposti senza un ordine preciso, spesso sul piano di un tavolo: composizioni di fiori o di frutta intorno a cui si aggirano insetti; vivande, in parte già consumate, come pesci, pane o vino; singoli frutti sparsi accanto a libri o strumenti musicali”. E in effetti i sei capitoli che compongono il libro possono essere considerati come dei quadri statici che in una immaginaria galleria rappresentano la vita del mercato: come nelle nature morte i pittori indulgono spesso e volentieri a rappresentare animali squartati e frutta marcia, così la prosa di Winkler, nel suo virtuosistico esercizio descrittivo, insiste ad accumulare particolari ripugnanti, con una frequenza sospetta e certo indicativa di una sua funzionalità letteraria, quella che Reitani definisce “estetica del brutto”.