PÉTER ESTERHÁZY, “Harmonia Cælestis”, Feltrinelli
Traduzione di Giorgio Pressburger e Antonio Sciacovelli
Introduzione di Giorgio Pressburger
“Insomma, mi devo mettere a impastare, rimpastare, far lievitare. Ma chi? Mio padre. Devo metterlo su un piedestallo, devo modellarlo, fotografarlo. Raccogliere i pezzi della sua fotografia che una volta mia madre fece a pezzi in un momento di rabbia, e rimetterli insieme. Quando? Nel corso del tempo. E devo preparare degli abbozzi, disegni, dipinture. Mio padre come incisione, acquarello, stampa, caricatura, paesaggio e scena di battaglia.”
Giorgio Pressburger, curatore e traduttore del romanzo di Péter Esterházy, nella sua Introduzione, lo definisce “una delle opere narrative più importanti della letteratura ungherese”, preparando il lettore a quella che si rivelerà una vera e propria avventura, un’immersione all’interno di un magma narrativo infinito, debordante e multiforme. Si potrebbe anche dire avvincente, certo in un modo del tutto particolare, per la varietà dei suoi toni, leggeri, pensosi, ironici, arguti e spesso irresistibilmente comici, illuminati da improvvisi lampi lirici, che impongono, a chi si accinga all’impresa, di seguire l’autore nel suo interminabile divagare in quell’immenso materiale che gli offre la storia della sua famiglia. Péter Esterházy appartiene infatti ad una delle più importanti famiglie aristocratiche ungheresi, discendente da una stirpe il cui albero genealogico si perde nella notte dei tempi, protagonista di spicco dei principali eventi che hanno caratterizzato la storia della sua terra.
Ma nulla è più lontano di questo libro dal romanzo storico o dalla ricostruzione biografica, qui tutto sfugge e deborda da qualsiasi classificazione, tutto stupisce e interroga, in alcuni punti sfinisce e lascia per strada chi pretende di tenere saldamente in mano le fila della narrazione, che certamente esistono, ma compongono un disegno sempre troppo vasto, o, al contrario, troppo minuzioso. E allora conviene fidarsi, e lasciarsi condurre sull’onda delle variazioni di mille vite e mille morti che l’autore rievoca, o meglio, sulle quali l’autore fantastica, perchè “La storia viene scritta dai vincitori. Le leggende sono custodite dal popolo. Gli scrivani fantasticano. Certa è soltanto la morte”. Una materia molteplice necessita di una struttura capace di accoglierla senza limitarla o costringerla entro confini troppo rigidi. Ecco allora che l’autore dà vita ad un libro che in realtà è costituito da due libri, contigui ed apparentati ma sostanzialmente anche autonomi.
Il primo – “Frasi numerate dalla vita della famiglia Esterházy” – è introdotto dal seguente avvertimento: “Poche persone sanno occuparsi del passato recente. O ci trascina con grande forza verso di sé la vita presente, oppure ci immergiamo nel passato per tentare, fin dove è possibile, di evocare e di riportare in vita ciò che è completamente trascorso. Anche nelle grandi famiglie abbienti, debitrici verso gli avi, vige l’abitudine di ricordare piuttosto il nonno che il padre”. Qui compare fin da subito la figura potentemente ricorrente e dominante su tutte le pagine del romanzo, quel “mio buon padre”, espressione che scandisce come un mantra o una giaculatoria la strabordante scrittura di Esterházy, chiamata a designare di volta in volta tutti gli antenati che si sono trovati nel tempo a capo della sua sterminata famiglia, una figura anch’essa multiforme, quasi una categoria entro la quale si raccolgono persone vissute in tempi molto lontani tra loro, dai caratteri molto diversi, protagonisti di vicende gloriose, ammirevoli, oppure ignobili ed esecrabili, buffe, comiche, grottesche, astruse, tragiche o della più disarmante normalità. Vicende della cui verità storica l’autore non si fa garante, rivendicando, anzi, in tutta tranquillità il proprio diritto a fantasticare, la propria attitudine a fantasticare intorno ad un così lontano passato che gli ha dato le origini, divertendosi però nel contempo ad insinuare dubbi nel lettore, mantenendolo nell’incertezza sul crinale di ciò che è storia, o invenzione, oppure esagerazione, e questo fin dal lapidario incipit del romanzo: “E’ di una difficoltà cane mentire senza conoscere la verità”.
“Il mio buon padre” è in fondo una categoria alla quale appartengono esempi di varia umanità, dei quali l’autore non rivela i nomi, ma solo stralci più o meno significativi delle loro vite, resi letterariamente vivi, perchè ammantati da un’aura che risiede solo nella capacità evocativa della parola. Ciò che li accomuna è l’appartenenza ad una famiglia nobiliare, è il privilegio della ricchezza e del potere. Esterházy è ben conscio di tutto ciò e utilizza la scrittura per immergersi attraverso i suoi antenati nella storia millenaria di un paese che ama, dissacrando e deridendo i potenti, ma anche lasciando trasparire, nell’attenzione minuziosa dei suoi racconti, l’attaccamento ad un popolo che ha sempre guardato ai suoi familiari con ammirazione. Lo fa mutuando i toni del linguaggio fiabesco che gli permettono di immedesimarsi nella fantasia popolare e di trascendere la realtà storica della propria stirpe, edulcorandola forse, ma rendendola anche suggestiva e romanzesca: “Questo nome significa sogno; il sogno magiaro dell’uomo prodigo, ricco, del signore con le mani affondate nella borsa, del padrone che getta al vento le banconote come se fossero semi di grano, che possiede oro e argento a iosa e la cui figura pare esser uscita dalle fiabe popolari. Significava l’ungherese ricco… Nella fantasia magiara il nome del mio buon padre significava tutto ciò che anche sulla terra poteva rendere la vita un paradiso… […] Significava terre di una tale vastità per sorvolare le quali nemmeno alle anatre selvatiche bastava una notte, figuriamoci all’uomo sognatore, che di questi uccelli notturni sentiva soltanto l’ingannevole grido di richiamo! Significava castelli girevoli turriti e imbandierati, che per la noia non fanno che specchiarsi nei laghi, giacché i loro padroni non trovano il tempo per visitarli. Intere vie di palazzi, nei quali soltanto i portinai fanno crescere le loro barbe, nelle sale sprangate i ritratti possono vivere a loro piacimento la loro vita intima, se si sono voluti bene, e voltarsi le spalle, se sono stati in conflitto tra loro”.
Non è una cosa facile maneggiare un millennio di storia e di storie e l’autore trova un modo tutto suo per farlo, negando al suo libro tutto ciò che una narrazione storica dovrebbe rispettare, la veridicità e il rispetto della cronologia, ma guadagnandosi in compenso uno spazio assolutamente libero in cui muoversi in leggerezza, rileggendo a modo suo episodi piccoli e grandi, rendendoli appetibili oltre la loro mera realtà, lasciando libero sfogo alla sua propensione ironica e beffarda. Scegliendo, infine, una forma del tutto inusuale che risulta fin da subito accattivante: il frammento numerato. A volte poche righe, a volte lunghe pagine, senza ordine temporale, di volta in volta “il mio buon padre” è diverso, lo si intuisce dal contesto, salvo poi ritrovarlo e riconoscerlo in un frammento successivo.
Una moltitudine impressionante di episodi, di padri e di figli che li rievocano, tutti appartenenti alla famiglia che “prese il nome dalla Stella della sera e della mattina (Esthajnal)”: “Il mio buon padre: chi sta nella sera e nella mattina può avere un capogiro spaventoso, perchè cade nel vuoto, né qua né là, non è giorno, non è notte, il cielo è vuoto, una sola stella appare; esclusivamente questo tremolante chiarore, questo nulla vibrante, che d’un tratto è qualcosa di più e di più ricco, compatto e leggiadro, come la crema di salmone, colorato e austero, si muove ed è stabile, l’ora della malinconia; chi si trova nel segno della Stella della sera e della mattina può abbagliarsi esultante, perchè dimora nel presente, nell’eternità – ah, l’attimo faustiano, per quanto imbarazzante! -, non lo tira giù il limo scivoloso del passato, non lo opprime l’avvenire irresponsabile, non esiste dove e verso dove, esiste l’adesso, il dorato presente, l’attimo d’argento, l’esserci di ferro, e così dopo non resta altro se non questo ferro, questa ruggine, la bellezza della ruggine, la sua rozzezza, questo veritiero pesante sbriciolarsi, materia dell’immaterialità: il mio buon padre”.
Il secondo libro – “Le confessioni di una famiglia Esterházy” – è introdotto da una avvertenza dell’autore: “I personaggi di questa biografia romanzata sono figure fittizie: possiedono pertinenza e personalità solo entro le pagine di questo libro, mentre nella realtà non esistono né sono esistiti mai”. Ancora depistaggi e camuffamenti, ancora più necessari perchè questa volta, gli eventi familiari si svolgono tutti nel XX secolo, dalla repubblica dei Soviet del 1919 fino a tempi molto recenti, e dunque anche dopo il 1950, anno di nascita dell’autore. Come non cedere al sospetto che questa volta il figlio che parla del suo buon padre sia proprio lui e che le altre comparse, in primis “la sua buona madre”, siano i membri della sua effettiva famiglia? Una famiglia aristocratica espropriata, impoverita e costretta al confino. Certo il piglio della scrittura non cambia, rimane fantasioso, indisciplinato e beffardo, i paragrafi numerati sostituiscono i frammenti, la cronologia si spezza e si ricompone, ma il tutto assume comunque un forte sapore autobiografico e la figura del “buon padre” si colora di accenti più intimi: “Mio padre diventò veramente solitario proprio allora. Lo vedo, eternamente seduto dietro al tavolo, che batte a macchina. Il battito dei tasti della macchina da scrivere attraversa di volata l’universo, riempie ogni angolo, raggiunge ogni golfo lontano, ogni luogo sperduto, questo bussare vano e crudele, che è piuttosto ansimo e rantolo, come il rumore oggettivo di una macchina, il riconoscimento del fallimento, pianto che singhiozza e supplica, con questo si riempie tutto il creato, questa è l’ultima parola sonora della vita di mio padre, questo suono terribile, terribilmente rotto, volgare, terrificante, brutto, conciliante, questa è impotenza, unicità e completezza”.
Percorrendo questa interminabile scrittura che non ha un vero inizio e nemmeno qualcosa che si avvicini ad una vera conclusione si avvertono, sotto lo stile scanzonato e “giovanile” del suo autore, le tracce di una sterminata cultura, quelle che Pressburger definisce “le immense elaborazioni della civiltà occidentale, al cui estremo limite europeo, ad est, sta la nazione ungherese”. E’ una scrittura che risuona dei libri e degli autori che Esterházy ha amato e dei quali si è nutrito, e lo stesso lettore si sofferma a volte su alcune righe che gli appaiono stranamente familiari, oppure che suscitano in lui solo un’imprecisa eco lontana. La riconferma si trova nell’appendice al volume dal titolo:“Elenco dei testi ospiti”. Si tratta di otto pagine che raccolgono le opere dalle quali l’autore ha tratto “citazioni letterali o in forma alterata”, trovando in esse, di volta in volta, corrispondenze con la propria materia narrativa, oppure spunti per rimaneggiarla. E alla fine si ha l’impressione che, al di là del destino familiare e della sua transitorietà, sia questa la vera eredità che negli anni si è costruito.
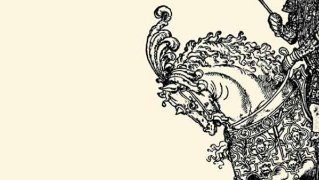
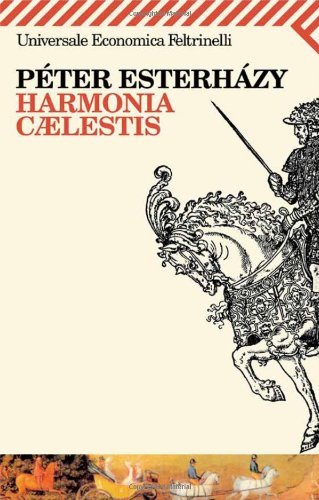
Grazie, prendo nota.
Buona giornata.
Grazie a te. Questo libro è stato una sorpresa. Nulla di ciò che mi aspettavo. Bello quando capita. Ciao!
[…] via PÉTER ESTERHÁZY, “Harmonia Cælestis” — dietroleparole.it | appunti di lettura […]