Traduzione di Anita Rho
Introduzione di Leonardo Sciascia
“Ed ecco, in quegli anni si moltiplicarono i segni miracolosi. Da tutti i punti cardinali si annunziavano e accadevano cose inaudite. Così si udì raccontare che montagne alte fino alle nuvole s’incendiavano improvvisamente e la loro cenere, simile a neve oscura, si spargeva per intere province. A volte nel turbine delle bufere cadevano a terra fiori variopinti come pietre preziose, che parevano stelle di corallo, farfalle morte o forse spoglie di aracnidi, ma talvolta anche, nella loro tumultuosa sontuosità di colori, nella loro velenosa dolcezza, facevano pensare a misteriosi ceffi ghignanti. Non di rado nuvole di un nero violetto, turgide come lampioni, si addensavano sulle città. Quando si laceravano, gli abiti della gente diventavano rossi come vesti di carnefici o di re, e le strade sembravano irrorate di sangue. Si parlava anche di creature favolose uscite dai mari o dalle selve, di mansueti taumaturghi e di minacciosi profeti.”
Il romanzo “L’Armada” è uno splendido e affascinante affresco, denso di ombre così come lo è stata la vita stessa del suo autore – e, soprattutto, la sua fine – l’uno e l’altra minacciate oggi da un ingiusto oblio. E’ storia, sogno, incubo e passione rielaborati da una mente geniale forse già destinata a patire i sintomi premonitori di quella demenza che la colpirà alla fine. Due grandi voci contribuiscono a mantenerne viva la memoria e a convincere i lettori della necessità della sua riscoperta: quella di Leonardo Sciascia, autore della bella e precisa introduzione alla edizione Sellerio e quella di Italo Alighiero Chiusano che recensisce il romanzo, scegliendo come titolo “Ogni armada è un’accolita di morti” (testo che si può trovare nel volume “Literatur. Scrittori e libri tedeschi”).
Poco si sa della vita di Zeise, nato in Polonia nel 1896, residente prima a Berlino, poi a Hersfeld; della sua opera sono ancora disponibili in Italia – ma difficile prevedere fino a quando lo saranno – grazie a Sellerio, solo i romanzi “L’Armada” e “Don Juan Tenorio”, ampiamente sufficienti però a testimoniare la raffinatezza e l’eleganza di una voce letteraria unica e originalissima. Del resto della sua produzione – Zeise è stato romanziere, ma anche commediografo e autore di radiodrammi – non c’è traccia in traduzione italiana. Una vita anch’essa in gran parte a noi sconosciuta; si sa che era vivo nel 1954, ma, come afferma Sciascia, “tra le tenebre di una semidemenza da cui forse non uscirà più”, ricoverato in un manicomio. Chiusano aggiunge che risultava ancora vivo ma non più produttivo nel 1963 e sicuramente morto, anche se non si sa dove, nel 1967. Anche la stessa pubblicazione de “L’Armada”, nel 1936, inspiegabilmente non osteggiata o impedita nella Germania hitleriana, suscita perplessità e solleva domande a cui non è possibile ormai dare risposte certe, data la natura anomala di un romanzo che, invece di esaltarlo, associa il potere alla follia e alla morte.
Curioso il fatto che, in definitiva, la nebulosità che avvolge la figura del suo autore predisponga il lettore ad entrare in sintonia con un romanzo che è, come scrive Sciascia, “memoria di un sogno: fortissima, carica di inquietudine e di premonizione, ma al tempo stesso labile, quasi evanescente, quasi sul punto di essere consumata dall’aria”.
La passione per la Spagna cinquecentesca e la semidemenza confluiscono in un romanzo che è il ritratto del suo autore, di ciò che egli prediligeva in vita e di ciò a cui la vita stessa lo condannava. Un romanzo che, dato il suo contenuto, dovrebbe essere definito storico, in quanto l’Armada, a cui il titolo si riferisce, è la flotta militare spagnola affiancata alla Lega Santa, a cui si deve la vittoria nella battaglia navale di Lepanto del 7 ottobre 1571 contro le flotte musulmane dell’Impero Ottomano. Ma la storia non è che la trama che Zeise arricchisce con l’ordito della sua propensione a fare propria la materia che ha tra le mani, a farla decantare e lievitare finchè giunga ad assumere l’aspetto di un sogno, labile, lento e inquietante come un incubo ricorrente. Sogni, incubi, inquietudini, paure e fughe, coraggio e disperazione trovano rifugio e nutrimento nell’animo dell’uomo che l’autore sceglie come protagonista: Don Giovanni d’Austria, il figlio illegittimo dell’Imperatore Carlo V, a cui il fratellastro regnante, Filippo II affida l’armata che dovrà difendere la cristianità nella battaglia di Lepanto. Un personaggio di grande importanza storica che l’autore sottopone ad una operazione di dissezione al fine di scoprirne e metterne in luce le tare mentali e le bassezze umane. Scrive Chiusano, in una prosa elegante e fortemente allusiva che bene rende la natura di questo romanzo: “Si ha l’impressione, a volte, che Zeise sia uno spettro maligno ma compitissimo, un’anima dannata che torna ai luoghi e alle persone delle sue frequentazioni terrene, e li riesumi col piacere vampiresco di far sentire anche a noi quei tanfi e quelle torture, quelle deformazioni da Corte dei Miracoli e quelle sordide ipocrisie”.
Così i fatti realmente accaduti che l’autore conosce e sui quali si è ben documentato, i personaggi realmente vissuti, finiscono per essere immersi in ombre cupe o illuminati da luci fiammeggianti, tanto da assumere l’aspetto di allucinazioni, come se Zeise non stesse raccontando la loro storia, ma riferendo il sogno in cui gli sono apparsi.
Il romanzo si apre con la nascita, anzi con il concepimento, di Don Giovanni d’Austria, culmina nella descrizione della battaglia di Lepanto e si conclude con la malattia e la morte del condottiero a trentatrè anni. Questa è la linearità dei fatti storici, il filo sottile che Zeise abbandona e riprende, confonde, aggroviglia e nel frattempo illumina con la grandiosità della sua scrittura. A partire dal primo capitolo che si apre con l’immagine dell’”ipocondriaco sire”, l’Imperatore Carlo V, infermo e malato di malinconia, oppresso da terrori e premonizioni, consolato dallo spettacolo notturno delle costellazioni che lo fanno sentire “eletto e predestinato a regnare su popoli e principi cinto da tre corone” e atterrito al giungere di ogni alba: “Un sogno visitava l’imperatore appena si levava il primo canto del gallo. Non era che una mano accennante, poco più chiara che la nebbia dalla quale emergeva. Al suo apparire persino il battito del cuore si arrestava, e il suo sparire era accompagnato da un riso fesso e strascicato. E ogni volta Carlo si svegliava sotto il baldacchino che odorava di polvere. Il riso della madre demente, Giovanna la pazza, gli tornava alla memoria. Piamente recitava un Ave per implorare alla sua anima, vagante senza pace fra i regni della terra, del cielo e dell’inferno, l’eterno riposo”. A questo imperatore malato nello spirito, afflitto da allucinazioni e senza pace, il carmerlengo procura una giovane fanciulla bionda, figlia del maestro cintolaio e dalla loro unione viene concepito l’eroe di questa storia, chiamato don Giovanni d’Austria, che nascerà a Ratisbona il 29 febbraio 1545.
Don Giovanni, che viene generato dall’uomo più potente del mondo, a sua volta figlio di una madre pazza, afflitto da strane paure, impegnato ad osservare nella più completa solitudine le tappezzerie fiamminghe della sua camera dalle quali pian piano emergono, terrorizzandolo, i lineamenti della sua stessa figura massiccia, che tra lo stupore della servitù afferra i ferri da calza per lavorare a una nappa nuova per la sua spada, ha nelle sue stesse origini il proprio destino di una vita malinconica predisposta geneticamente alla follia.
Questa primo potente ritratto dell’Imperatore dà inizio ad un’opera narrativa principalmente visiva, “svolta quasi totalmente per immagini”, scrive Sciascia, “un romanzo in cui la pittura, da Bosch a Goya, è parte intrinseca del processo creativo e in cui i documenti, le cronache, le enumerazioni e le denominazioni vengono assunti visivamente, in una successione di immagini che sembrano non avere movimento in sé, ma acquistarlo nel ritmo, appunto, della successione”. Così, percorrendo gli avvenimenti della vita dell’”Imperial Bastardo”, le pagine del romanzo dispongono davanti ai nostri occhi una serie di visioni che compongono il ritratto di una Spagna cinquecentesca sinistra e crudele, come se l’autore fosse mosso, scrive Chiusano, “dal gusto di scoprire miserie umane, bassezze di calcolo, tare mentali e fisiche nei personaggi che ci guardano dall’alto dei loro ben dipinti ritratti”.
Ed ecco quindi passare sotto i nostri occhi, ogni volta presentate in modo potente e straordinariamente nitido, nella loro natura grottesca e crudele – simile a quella del magico brulichio di spettri e folletti che Zeise ammira nei quadri di Bosch – le scene della processione degli hidalgos e degli autodafé, dei flagelli che assalgono l’accampamento dell’Armada, dei lanzichenecchi che impazzano per le strade di Messina, dell’attacco della Santa Inquisizione all’esercito di prostitute al seguito dell’Armada, e, soprattutto, quella della lunga e vittoriosa battaglia navale contro la flotta ottomana, merito delle strategie messe in atto da Don Giovanni d’Austria.
Chi detiene il potere nella Spagna cinquecentesca raffigurata dal romanzo – ma forse Zeise che opera nella Germania nazista vuole adombrare che questo è il destino a cui incorre qualsiasi potere politico autoritario e assoluto – porta in sè una tara, una sorta di maledizione che si trasmette agli eredi legittimi e ancora di più a quelli illegittimi. Lo testimonia la morte di Don Giovanni d’Austria, simile a quella di suo padre Carlo V, che Zeise racconta in un capitolo finale così speculare al primo, alla prima immagine dell’Imperatore folle, che è possibile trovare corrispondenze persino nei singoli capoversi. Don Giovanni muore di peste, ma già da tempo la sua mente è persa. Così il romanzo inizia e finisce con lo stesso sogno febbrile: “Un sogno visitava don Giovanni d’Austria appena si levava il primo canto del gallo. Non era che una mano accennante, poco più chiara della nebbia dalla quale emergeva. Al suo apparire s’impadroniva dell’assopito Juan una struggente melanconia, ch’era dolce e disperata. Egli gettava un grido soffocato, e la visione spariva accompagnata da una risata lunga e frullante. [..] Strani terrori si prendevano gioco di don Giovanni in quelle ore mattutine. Nella mezza luce del giorno, mentre fuori il vento frustava la pioggia sottile, sembrava al bastardo che gli arabeschi delle tappezzerie dorate si mutassero nei segni cifrati dei messaggi di stato, o assumessero l’aspetto di facce umane tutte identiche, fin nella più piccola grinza. Il volto di Filippo II. Allora il governatore generale storceva furibondo la piccola bocca. E malediceva il re”.
Il destino si compie e si chiude così un cerchio, come indica la frase di Confucio che l’autore sceglie come esergo all’ultimo capitolo del suo romanzo: “Per noi che abitiamo sull’orlo del pozzo della terra, aurora e tramonto sono una cosa sola”.
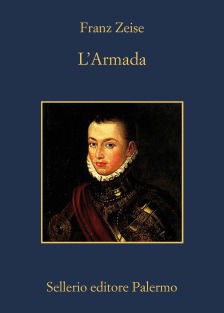
Acquistai i due romanzi di Zeise quasi trent’anni fa, nella collana “Il castello”. Letti quasi subito, come per molte delle mie letture antiche ne conservo un ricordo vago, che tuttavia si condensa nella sensazione di una prosa potente. La Tua bellissima recensione me lo conferma, e come spesso mi accade accende la voglia di una rilettura. Chissà.
Quanto al perché il nazismo non censurò il romanzo, si deve ricordare che oltre la più efferata è stata la più stupida dittatura del ‘900, giocandosela bene con il mascellone nostro.
Grazie
V.
Grazie Vittorio, queste edizioni danno davvero lustro alla Sellerio, che spero le riproporrà perchè stanno diventando difficilmente recuperabili se non nell’usato. Anche “Don Juan Tenorio” è bellissimo, più misterioso ed esoterico, meno controllato direi, come se la mente del suo autore avesse cominciato a vagare in territori estranei al nostro vissuto, ma propizi alla grande letteratura. A volte sembra che Zeise si rivolga a noi suoi futuri lettori: “Venite con me e vi prometto i brividi dell’orrore. Unitevi a me che vi voglio provare quanto la vita quotidiana sia a volte più spettrale che il segno delle ombre. Non abbiate paura, siete solo stupiti o meravigliati dal paesaggio incredibilmente pittoresco, dalla storia e dal volto meraviglioso del quotidiano che vi voglio far vedere, quasi come da un mantello magico sospeso nell’aria”.
Un saluto. Anna