FRANCO STELZER – Ano di volpi argentate – Einaudi
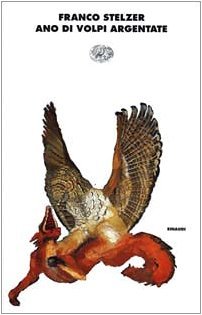 “Voglio dire questo, che quando ti penso, vedo una distesa di boschi. Voglio dire che, in un punto oscuro di quei boschi, esiste veramente lo sfintere di una volpe. Certo, quel muscolo ha qualcosa di tremante. Esso è una stretta rapida. E’ un pensiero oscuro. Esso si stringe o si allenta, a seconda del caso. Quando la volpe muore, per esempio, lo sfintere si allenta. Ora, quando guardo una distesa di boschi, e quando penso allo sfintere delle volpi, mi vieni in mente tu. Voi due siete un pensiero oscuro. Una rapida stretta. Siete qualcosa di tremante che, dal buio, invia segnali verso l’alto”.
“Voglio dire questo, che quando ti penso, vedo una distesa di boschi. Voglio dire che, in un punto oscuro di quei boschi, esiste veramente lo sfintere di una volpe. Certo, quel muscolo ha qualcosa di tremante. Esso è una stretta rapida. E’ un pensiero oscuro. Esso si stringe o si allenta, a seconda del caso. Quando la volpe muore, per esempio, lo sfintere si allenta. Ora, quando guardo una distesa di boschi, e quando penso allo sfintere delle volpi, mi vieni in mente tu. Voi due siete un pensiero oscuro. Una rapida stretta. Siete qualcosa di tremante che, dal buio, invia segnali verso l’alto”.
Questa scrittura, il rumore di questa scrittura, l’ansito di questa scrittura, è una stretta rapida e un pensiero oscuro. Questa pagina che l’autore sceglie come introduzione ai suoi scritti e, presumo, come presentazione di sé in quanto scrittore, ha il potere di lavorare nel tempo, senza fretta, perché stupisce e attrae chi conosce l’oscurità e il tremore, il lettore che ad ogni nuova stretta si predispone a quel piacere sottile che è aspettativa ma anche glorioso superamento di ogni aspettativa. La scrittura di Stelzer, si potrebbe definire una prosa poetica, una narrativa contaminata, dall’andamento sinuoso e destrutturato, accenni di trama condotti sul filo dell’intuizione, che chiedono, chiamano la partecipazione del lettore, anzi, in un certo senso, la esigono.
Ma non è solo questo, la scrittura di Stelzer esige il primo piano, anzi il primissimo piano, è una sostanza viva che respira con il lettore, che lo penetra perché conosce le sue oscurità, le sue strette e i suoi tremori. E lo fa con “una splendida, indugiante lentezza”. Lento, criptico, avvolgente e corporeo, questo stile mi appare come la carta di identità di uno scrittore italiano contemporaneo che è per me una sorprendente e felice scoperta. Scova e inventa una parola che si aggira con la stessa naturalezza e con lo stesso impeto nei territori della corporeità e della sacralità, che scopre l’una attraverso l’altra e viceversa, che non sa leggere l’una al di fuori dell’altra, in un modo che insieme sollecita, anche tramite la crudezza, ma che nella stessa crudezza, in qualche suo strano modo, consola. E’ una scrittura che si aggrappa, viscida persino, al suo oggetto, lo scruta fin nei suoi minimi dettagli, nelle sue fessure e cavità, sosta, cerca e chiama il disgusto per poi accendersi con un’impennata improvvisa in illuminazioni metafisiche, sapienti e antiche, che hanno il rumore della poesia; perché “siamo ratti spaventati di una tribù soccombente”, ma “abbiamo un mattino ventoso nel petto, un rabbioso bisogno di gloria”.
Stelzer con questi quattro racconti compone un inno al corpo umano, lo canta e lo esalta a tal punto da chiamare in causa, o in aiuto, per penetrarne l’essenza, la sua animalità. Perché questo libro è, anche, uno splendido bestiario, vivo o morente, e sembra sempre di fissarli negli occhi questi animali e la loro caldissima drammaticità, sembra sempre di fissare sul fondo delle loro pupille l’attimo in cui saranno crudelmente violati, perché quell’attimo li nobilita, quell’attimo ci nobilita, e queste pagine richiedono l’identificazione, la fuga nei boschi più fitti, dove “regine e volpi si lasciano andare”, si fingono morte, zampettano e “lascino macchie sul mondo”. E’ un mondo macchiato e contaminato quello di Stelzer, dove le cose seguono i percorsi più tortuosi, dove la condizione per alleggerirsi, per trascendere, per nobilitare lo spirito, rendersi degni della vita, è appesantirsi nell’accettazione, gioiosa o meno ma ciò in fondo non importa, della propria carne, che è gloria miracolosa di giovinezza nella ritualità religiosa dei gesti dell’amore, ma che è anche malattia, decadimento, estrema decrepitezza, disgusto di sé e infinito rimpianto: “Io muoio alla prima impressione del dolente ottobre”.
Un mondo oscuro e sporco, l’ano di una volpe, ma la volpe è argentata e il muscolo è una stretta fremente e tremante, un’umanità sporca che semina tracce di sé ma tende verso un altrove, e l’altrove è verso l’alto. Con naturalezza e misura l’autore va a recuperare nella fiaba e in quel repertorio di suggestioni e di ancestrali emozioni che è la metamorfosi i materiali che gli occorrono per amplificare l’effetto della sua prosa, per donarle di volta in volta spessore o leggerezza, per sostare sulla soglia di oscuri segreti e confondere la prima e l’ultima sera di maggio della vita di un uomo. Come potrebbe altrimenti addentrarsi nei boschi sacri e penetrarne i misteri, come potrebbe addentrarsi in quel bosco sacro che è il povero cuore dell’uomo? Come potrebbe trovare le parole per regalare al corpo impiccato di un giovane paggio una simile inoffensiva e dolcissima leggerezza: “Pendeva sorridente dal soffitto delle stalle di corte. La corda gli arruffava i capelli. Aveva il portamento dei bambini che vengono sgridati. […] E pendeva con grazia, con estremo distacco. Ed era simile alle dita delle donne che cercano i capelli. Che li cercano per riportarli là, dietro le orecchie. Dimenticando che sono già raccolti. Lui pendeva da morto come aveva vissuto. Ed era aereo. Indifeso. Agitato da un vento”.
Mi succede a volte, ma forse con Stelzer in modo più netto, di avvertire la sensazione di una vicinanza, di leggere un’opera prima e di ritrovarvi un respiro – un ansito in questo caso, un ansito regale – che dipende solo ed esclusivamente dalle parole, dal modo in cui si sostengono, dal modo in cui sanno rispettare e rendere il peso, la leggerezza ed anche la indeterminatezza. Poi ho appreso che l’autore ha tradotto per le edizioni Silvy “La classe” di Hermann Ungar e “La porta verso l’impossibile” di Oskar Baum. E così tutto si spiega e tutto si tiene.