STEFANO D’ARRIGO – Horcynus Orca – Rizzoli
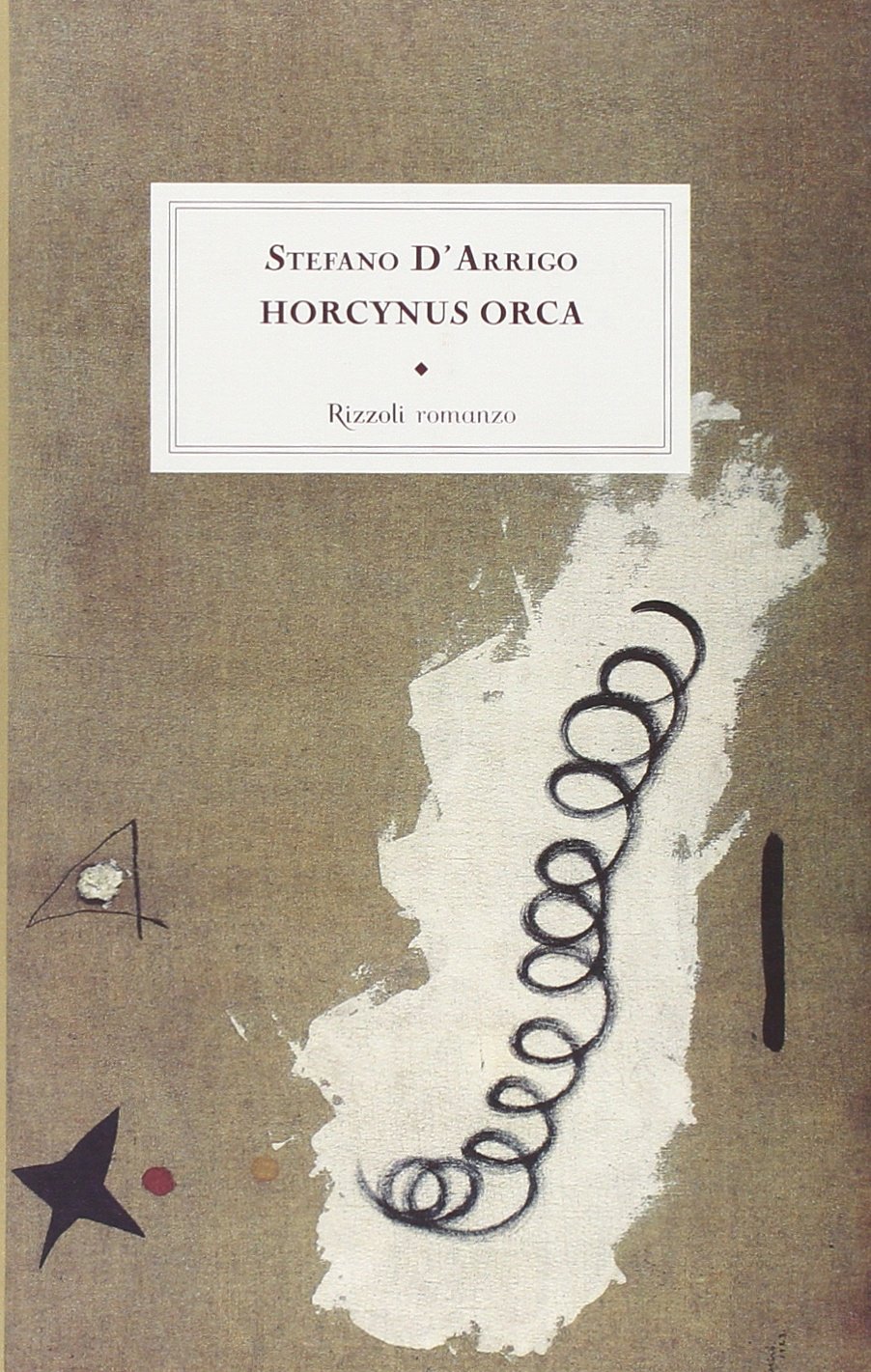 “Allo scuro si sentiva lo scivolio rabbioso della barca e il singultare degli sbarbatelli come l’eco di un rimbombo tenero e profondo, caldo e spezzato, dentro i petti. La lancia saliva verso lo scill’e cariddi, fra i sospiri rotti e il dolidoli degli sbarbatelli, come in un mare di lagrime fatto e disfatto a ogni colpo di remo, dentro, più dentro dove il mare è mare”.
“Allo scuro si sentiva lo scivolio rabbioso della barca e il singultare degli sbarbatelli come l’eco di un rimbombo tenero e profondo, caldo e spezzato, dentro i petti. La lancia saliva verso lo scill’e cariddi, fra i sospiri rotti e il dolidoli degli sbarbatelli, come in un mare di lagrime fatto e disfatto a ogni colpo di remo, dentro, più dentro dove il mare è mare”.
Così si conclude, nel mare, dove il mare è mare, con due periodi che guidano il respiro sull’onda di un movimento regolare, ritmato sul dolore e sulla profondità, su qualcosa di antico ed eterno, che tocca e rende grati di essere giunti fino a qui, così si conclude questo mirabile romanzo che possiede l’impeto e il carisma della grande letteratura, della grande letteratura italiana. Più dentro dove il mare è mare e che questo mare sia nostro, profondamente, per nascita, natura e cultura, per qualcosa di atavico che forse scorre nelle vene insieme al sangue, D’Arrigo ce lo suggerisce, di più, lo insinua nella nostra mente, lo rende causa evidente della compartecipazione con cui ci costringe a seguire le ampie volute della sua narrazione.
Figli di questo mare, le sue pagine ci trascinano dentro, più dentro, a riscoprirne la vastità reale e metaforica, a ritrovarlo nella nostra memoria, a sentirlo in tutta la sua eterna saggezza, nella sua incoercibile libertà e nel suo stupefacente furore. E non importa se accanto a questo mare il lettore non abbia avuto la ventura di vedere la luce, perché qui di un’altra luce si tratta, quella della cultura, del mito, degli archetipi che obbligano comunque ad un riconoscimento, immediato, a pelle, e anche mediato dalle infinite pagine, immortali, che a questo mare devono il loro respiro. Il mare dello scill’e cariddi diventa con questo libro una patria, ricorda che cosa sia una patria, condensa nella sua dolente bellezza e nella sua imperturbabile natura – ammaliante, incurante e crudele, teatro delle intricate trame del mito, sostanza di figure immortali – i sogni, le illusioni, le paure, la fatica, il dolore, la dolcezza infinita dell’amore, che sono inevitabili compagni al nostro vivere. Non importa se il mare di questa Sicilia ci è geograficamente lontano, perché è chiuso nella profondità dei nostri geni, si muove nelle storie che per prime ci hanno ammaliato, e se per ventura capita di annusare lo scirocco che lo accarezza, “quel mare tormentoso” diventa all’istante parte di noi: “Gira e rigira, alla fine ci troviamo sempre davanti a un mare, e per andare dove siamo diretti, ci tocca superarlo. C’è sempre un mare rosso, un mare vivo o morto, che si para davanti a chi va ramingo, in cerca di casa…”.
Questo ci regala D’Arrigo, questo e molto altro ancora, perché il suo interminabile romanzo – l’opera di una vita – è una summa di ciò che la letteratura, da sempre appassionata amante del mare, può fare se in lui trova materia, stimolo e occasione per esaltare la propria creatività. E quanta letteratura c’è in questo romanzo! Scoprire dove affondano le sue radici, in quale materia si aggrappano saldamente per rianimarne lo spirito e il valore, per rinnovarne l’incanto, è la riconferma del fatto che nella creatività umana ciò che vale non va mai perduto ma diventa patrimonio di tutti e fonte di nuove suggestioni. C’è il vagare di Ulisse intorno allo scill’e cariddi e il suo avventuroso ritorno, c’è la levità degli incontri stupefatti del poema ariostesco, c’è persino la corrusca e inquietante presenza del cupo nocchiero dantesco, in vesti femminili, traghettatore dello stretto, l’esotica fantasia delle “Mille e una notte”, una barca-arca di biblica memoria, il mostro marino novello Moby Dick, novello Leviatano, con tutta la sua portata simbolica, ma c’è anche la lotta del vecchio contro i pescibestini, solo con le sue forze testarde, come ne “Il vecchio e il mare”, c’è una Messina bombardata che ricorda la Napoli di “Kaputt”… e c’è “La canzone di Orlando”, rivisitata mille volte dal teatro dei Pupi, e persino episodi, storie seconde, che sembrano trarre ispirazione dalla migliore novellistica della tradizione italiana, c’è in queste immense pagine una materia letteraria densissima e catapultata nel bel mezzo degli eventi rovinosi del 1943, all’indomani dello sbarco degli Alleati in Sicilia, così che il protagonista del romanzo, ‘Ndrja Cambrìa, marinaio della fu Regia Marina, in fuga da Napoli verso la natia Cariddi, porta con sé l’esperienza drammatica di una violenza tale, di un tale disinganno, che nulla, nemmeno nel luogo delle sue origini, potrà mai più essere come prima.
‘Ndrja, che proviene da un delirio, è alla ricerca del senso originario della sua esistenza e di quella della sua gente, quei “pellisquadre”, pescatori dalla pelle “simile alla cartavetrata per squadrare il legno”, che da sempre conoscono la fatica ma anche l’orgoglio del loro onesto mestiere, che sanno che dal mare può venire la vita e la morte e per questo lo rispettano e lo conoscono “piega per piega, magagna per magagna”, e questa ricerca è, tra le mille avventure, tra i mille accadimenti di cui il romanzo si compone, di gran lunga il senso profondo di una scrittura affascinante e multiforme che compone allegoricamente il romanzo della fine del mondo millenario dei pescatori dello stretto, e quando un mondo muore, quello che si perde è irrecuperabile e definitivo, come l’estinzione di qualcosa di prezioso per l’umanità intera. Forse è per questo che D’Arrigo, mentre si prende il tempo e lo spazio di più di mille pagine, perché la fine di un mondo, materia adatta ad un racconto epico, richiede lo sviluppo di cicli narrativi, svolgimenti lineari o involuti tesi a svelare ma anche ad esorcizzare arcani, si ancora alla mitologia per creare la propria, perché solo il mito rivela e nasconde, narra e spiega, solo il mito può far convivere armonicamente la natura realistica degli eventi con il loro significato ultimo.
“Hocynus Orca” è in questo senso una summa mitologica, ma molti dei suoi personaggi, a ben vedere quasi tutti, sono figure di un mito dissacrante perchè, mentre rappresentano, stravolgendoli, valori universali, ne decretano la irrimediabile fine. Ma questo fa la vera letteratura, riporta in vita i padri per trasgredire alle loro leggi, per navigare a vista e procedere nel territorio vergine in cui nuovi miti possono essere creati. Ogni pagina di questo romanzo è un invito al riconoscimento e alla interpretazione, si presta a molteplici letture che, come una scatola cinese, conducono ad insospettabili profondità e il lettore può scegliere liberamente a quale livello fermarsi, fino a che punto spingersi nella sua adesione al richiamo delle sirene letterarie che abitano le spiagge dello scill’e cariddi. E’ proprio la rivisitazione delle sirene che dà vita alle figure mitologiche più indimenticabili del romanzo: le femminote, le donne contrabbandiere di sale tra le coste dello stretto, portatrici di una femminiltà seducente ed ardita, forti come uomini, abili navigatrici, indipendenti e disinibite, coraggiose ed aggressive, donne che non invecchiano mai ma che ad un certo punto, semplicemente, muoiono, con “il busto intesato come un fuso, la pelle liscia e vellutata, la movenza carnosa e snella”, oscuro oggetto di desiderio per gli uomini ai quali concedono di soddisfare le proprie voglie ma mai di essere da loro possedute, sogno proibito degli “sbarbatelli” per i quali costituiscono una sorta di rito di iniziazione alla vita adulta. D’Arrigo trova per loro mille appellativi, tutti suggestivi, tutti tesi ad evidenziare la loro natura sovrumana, o semplicemente umanamente diversa dalla norma e perciò appetibile e pericolosa: “draghesse”, “serpentesse”, “deisse”, “magone”, “piratesse”, fatesse”, e, fra tutte, quella Ciccina Circè, la femminota traghettatrice che porterà ‘Ndrja da Scilla a Cariddi attraversando di notte le acque pericolose dello stretto, protagonista indiscussa della parte centrale del romanzo perché, traghettando il giovane verso il paese natale, renderà possibile il suo ritorno, ma anche la sua ripartenza verso la morte. Ciccina Circè, con questo suo nome che richiama alla memoria l’omerica maga Circe e il suo potere soggiogatore nei confronti degli uomini, così legato ad una sessualità prorompente e maligna, è anche lei parte attiva di quella drammatica trasformazione alla quale tutto nel romanzo viene sottoposto. Pagine veramente intense dal respiro epico la vedono guidare nell’oscurità la sua barca attraverso lo stretto, solcando un mare colmo di cadaveri dei marinai morti negli scontri navali, attirando le fere – i delfini- con il suono di una campanella, affinchè nuotino di fianco allo scafo per evitare che i corpi degli annegati si avvicinino troppo, per evitare di vedere da vicino tutto l’orrore che il mare nasconde.
Una grande donna maligna ma anche una grande madre salvatrice, entrambe legate come una cosa sola al mare, perché il mare, la madre e l’amore sono una cosa sola lungo le rive dello scill’e cariddi: “Poi, dov’era stato il fuoco, si rovesciò il mare. Per quei minuti, era stato come non avesse sentito più il mare, quasi che il respiro della femminota che saliva e scendeva dal suo orecchio, come la bava di un vento terribile, penoso, imprigionato dentro di lei, fosse più forte del rumore delle onde; ed era stato come si rendesse conto dopo, di questo, quando si staccava dalla femminota e gli pareva che il mare gli risorgesse in quel momento all’orecchio e ne era come soprassaltato: lo sciacquio delle onde alle sue spalle gli sembrava un rombo di cavalloni, di ondate gigantesche che rotolavano dietro a lui e si alzavano all’altezza delle palme per sommergerlo”.
Il mare, la madre, l’amore, ma non può certo mancare la morte in questo tutto che in continuazione si scompone e si ricompone e la morte sullo scill’e cariddi ha un nome e un aspetto visibile, riconoscibile e terribile, la morte è l’orcaferone, l’orca assassina, l’Horcynus Orca che dà il titolo al romanzo. Quando all’improvviso compare sulla linea dei due mari, apparizione mitica ricordata vagamente dai racconti tramandati dalla memoria collettiva, per tutti è chiaro che lei è quella che dà la morte, mentre passa per immortale, che lei è la morte marina, “sorda, cieca e refrattaria a tutto, fuorchè all’ammazzare. Vive per dare morte, fu creata appositamente per questo. […] Senza fermarsi mai, passando di carneficina in carneficina, appestando e spopolando le acque per miglia e miglia, l’animalone s’è lasciato dietro mari di rovine: di reti, di barche e di cristiani che c’incappano, mari di pesci massacrati o scappati in terrore davanti a lui […] villaggi e villaggi di pescatori, come investiti da un momento all’altro dal contagio e destinati alla più nera carestia di mare, restano chiusi in quell’immenso cordone di acque ribollenti di sangue, ribellate e appestate di fetori di carogne martoriate”.
Dunque l’orcaferone è il male, novello drago che solo il coraggio di un eroe può sconfiggere, la balena bianca da inseguire e da uccidere a costo della vita. Ma ancora una volta D’Arrigo sopravanza il mito e lo reinventa piegandolo al senso del suo romanzo. Perché l’orcaferone sembra non conoscere il proprio ruolo, inconsapevole benefattore che con le sue immersioni porta a galla un’enorme quantità di cicinella, di piccole anguille non ancora formate, che permette alla comunità di pescatori di sfamarsi, perché l’orcaferone che dovrebbe essere immortale, in realtà è orribilmente ferito e sembra galleggiare sulla linea dei due mari, in balia delle correnti e delle maree, in attesa della guarigione, perchè infine l’orcaferone, la bestia immortale, muore vittima dei delfini che le strappano a morsi la carne della coda impedendole di nuotare e poi delle cannonate degli inglesi. E morendo trascina con sé lo spirito stesso dei pellisquadre che scendono a patti con se stessi e con il loro onore, dimenticano di essere pescatori e approfittano del suo enorme corpo morto per rivenderne le parti e guadagnarsi così da vivere senza fatica e senza pericolo, trasformandosi in spiaggiatori, ridotti a vivere di ciò che il mare butta sulle sue rive. Tanto clamorosa e inaudita è la morte dell’orcaferone, tanto appare consequenziale la morte di ‘Ndrja, costretto ad accettare compromessi tra ciò che ha sempre creduto e ciò di cui ha fatto sulla sua pelle esperienza.
E’ un romanzo di morte “Horynus Orca”, di morte e di arcani, un romanzo degno di una lingua inaudita, unica e irripetibile, che cresce addosso alla propria materia narrativa e a lei aderisce, accompagnandola in ogni più piccola piega, sostenendola ed esaltandola, una lingua difficilmente definibile ma della quale è straordinariamente facile cogliere tutta l’armonia, una lingua che accoglie la corposità del dialetto, la sua onesta materialità, avvitandola in giri sintattici che scendono vorticosamente al cuore più profondo del significato di cui sono portatori, ma che sempre si appoggiano su parole salde come pietre. Una lingua che si arroga il diritto di creare parole nuove e impossibili in qualsiasi altro contesto ma che qui appaiono naturali e che nella sua vitalità, nel suo proliferare, riesce a cogliere tutta l’antica saggezza di cui il dialetto siciliano è portatore, trasformandolo in una lingua, a suo modo, coltissima e adatta a quella che Walter Pedullà nell’introduzione al romanzo, definisce la maggiore opera della nostra narrativa dedicata al mare.