ERMANNO CAVAZZONI – Il poema dei lunatici – Bollati Boringhieri
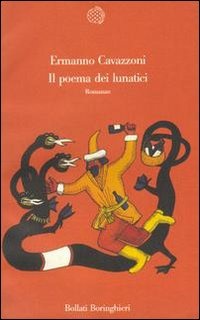 “Ma la mia educazione l’ho avuta dai tetti, e mio padre era davvero l’aria del cielo, e mia madre l’odore che viene d’estate su dalla terra. E io stavo tra mio padre e mia madre sui tetti della città, e mi sono educato così”.
“Ma la mia educazione l’ho avuta dai tetti, e mio padre era davvero l’aria del cielo, e mia madre l’odore che viene d’estate su dalla terra. E io stavo tra mio padre e mia madre sui tetti della città, e mi sono educato così”.
Lieve come una bolla di sapone, e come lei iridescente, della stessa sostanza del fumo e della nebbia, come suggerisce l’epigrafe ariostesca, felicemente demente ma estremamente fedele alla propria strutturata illogicità, che si esalta in un crescendo spumeggiante per poi spegnersi in una dolce e lenta bruma malinconica, l’opera di Cavazzoni mi appare come un inaspettato e riuscitissimo esempio di epopea padana. Questa piana che allontana l’orizzonte e induce a fughe e inseguimenti, macina il tempo e invita all’operosità, così chiara, aperta, a se stessa uguale e prevedibile, così parca di nascondigli e così ostile al deviante vagare, svela in queste pagine una sua dimensione fantastica che è propria “dei recessi e dei segreti del mondo”, invisibile ai più, irriverente e irridente, candidamente estranea alla logica, ma anche caparbiamente intenta alla sua opera di smascheramento della realtà, o meglio, di svelamento di una realtà parallela.
Scavare nei recessi, sostare sul confine e da lì con un occhio ancora sul mondo e l’altro, curioso, divertito, oppure spaventato e perso, sbirciare oltre il confine, trovare conferme a segreti o sospetti e nutrimento a sfrenate fantasie sembra l’insensata opera riservata ai bambini, ai poeti o ai dissennati. Nulla di più adatto allora a quel liberante gioco di distruzione, costruzione e finzione che in fondo è la letteratura, o almeno, certa letteratura. Un gioco liberante, lussureggiante, ardito, totalmente esagerato e fuorviante, malinconicamente divertente e così teneramente grottesco. “Il poema dei lunatici” introduce il lettore in un mondo tanto visionario e folle quanto potrebbe esserlo, ad esempio, l’inferno manganelliano, oppure la sua palude definitiva, non-luoghi che appaiono però, per il tempo del tragitto, perfettamente plausibili e decisamente ammalianti come i pericolosi canti delle sirene, perché inducono a credere che l’umana mente racchiuda una miriade di mondi inesplorati a fronte dei quali la misera realtà – l’unica della quale ci è dato di fare una limitata esperienza – impallidisce e, almeno per il tempo della lettura, si fa da parte. Poi il tragitto finisce ma qualcosa nello sguardo rimane perché non si esce indenni dalla luce della luna.
La visionarietà ha di buono quel suo prescindere da ogni giudizio di valore, vale per ciò che riesce a far risuonare e permanere, sia quella manganelliana, coltissima e metafisica che è allegoria del pensiero rivestita di carne e di sangue, sia quella così umile, tenera, commovente, degli stralunati eroi di Cavazzoni che aprono i loro occhi su quei lacerti del mondo sensibile, che restano silenti ai più, perché protetti dalla loro risaputa inutilità, si insinuano in loro, animandoli di una vita improbabile, creando per loro abitudini e gesta, intere epopee, e, appunto, un poema. E’ così forse che anche Max Ernst, fissando lo sguardo su un banale nodo del legno scorto su una trave, lo animava rendendolo il seme germinatore delle sue tavole di storia naturale, oppure delle sue intricate e magiche foreste. Il seme germinatore di Cavazzoni è l’acqua, quella che la pianura nasconde nei suoi meandri profondi, che giace nel fondo dei pozzi, che bisogna scrutare con timore e meraviglia perché è l’arcano che si rivela a pochi, come un segreto, o meglio, come una malattia. “[…] in molti credono che l’acqua dei pozzi sia comunicante nel sottosuolo, e che qui in pianura si sentono dai pozzi spesso venire voci o lamenti, e ci si sente a volte chiamare per nome”.
Da quest’acqua animata e vivente inizia un castello narrativo che innalza il suo proliferare svagato su mattoncini ben disposti l’uno sull’altro, così che ogni capitolo inizia proprio dove il precedente vuole condurre, con le stesse identiche parole. Perché la dissennatezza non è il caos, è un altro modo di vedere le cose, di vederle con l’occhio incantato: “Cioè quando l’occhio è incantato, si vedon le cose di fianco, che a guardarle poi dritto non si vedono più. Un potere della coda dell’occhio. O chissà”. L’acqua del pozzo è l’arcano e il pozzo una botola, così che la pianura non è altro che una crosta, e chi ci vive sopra lo fa per abitudine: due pagine bastano all’autore per sovvertire il regolare e comune distendersi di uno spazio perfettamente comprensibile, misurabile, controllabile. Complice, ovviamente, la luna.
La luna ariostesca, custode del senno perduto degli uomini che la devono raggiungere per recuperarlo, nelle pagine di Cavazzoni allunga il suo influsso sulla terra, a lambire i soggetti più propensi a subire il suo incantamento, primi fra tutti il protagonista, colui che si fa chiamare Savini, e il suo compare, l’ex prefetto caduto in disgrazia, riempiendoli di strane illusioni e di strani sogni. “E in quel frangente succede che dal buio del cielo spunta la luna, una bella fetta di luna sottile e lucente. […] Era bassa sopra le case e le sfiorava, quasi fosse appoggiata, come un paralume da notte, come una lettera al neon che avevano acceso. Mandava una luce del colore della perla o del nichel, e vicino la nuvola che l’aveva coperta era orlata d’argento e se ne andava come fosse stato un sipario che si apriva, o uno schermo che veniva abbassato. Ho girato gli occhi sopra il prefetto che prendeva in pieno la luna, e così finalmente mi è apparsa davanti la sua faccia non come un’ombra, ma chiara. E è inutile dire com’era. Ma per qualche sua proprietà o per effetto di questa luce lunare l’ho sentito come la cosa più vera, più vera e recondita, tra tutte quelle che mi sono passate davanti. Vera e recondita; è il modo giusto di dire come sentivo”. Alla ricerca del vero e del recondito sembrano dirigersi i due donchisciotteschi figuri nella loro lotta contro i mulini a vento di una città che a loro pare un fondale finto di cartone popolato da abili attori che fingono la normalità e, soprattutto, nelle loro investigazioni intorno a quelle popolazioni minori che irritano, spiano, emanano voci, disturbano i sonni, appaiono come improvvise visioni, si annidano nei pensieri. Una ridda di fantasie, parvenze, metamorfosi, una dovizia di stralunati racconti che non risparmiano le imprese dei grandi della storia ridotte a stravaganti cavalcate verso il nulla, oppure solo al fortuito frutto di un madornale fraintendimento.
Questo romanzo produce con la sua levità un senso di felice sazietà mentre tumultuoso conduce oltre il confine, la frontiera che separa la realtà-messinscena dalle regioni segrete affollate di parvenze che galleggiano nell’aria e mandano segnali alle menti che sanno cogliere le voci della luna, la frontiera insomma che separa una specie di nulla da un’altra. Sarebbe forse un libro amaro, se non fosse così teneramente comico. E solo arrivati alla fine ci si convince che la mente di colui che si fa chiamare Savini, così fervida e viva, è davvero una mente malata, lo si capisce quando il suo cervello diventa “bianco e pulito” come dopo un lungo sonno, proprio quando, dopo un mese esatto, termina un ciclo lunare, e l’incantamento finisce, così come il poema: “L’ho vista questa luna sorgere su dalla parte dell’autostrada. E io che mi ero quasi perduto, e avevo paura di sentire per aria dal buio il fischio del tempo. Era una luna, mi ricordo, più pesante che mai, vecchissima e tutta rugosa. Che nasceva già a notte fonda, malfatta. E faceva fatica ormai a alzarsi dall’orizzonte e a uscire dai veli di nebbia. Me lo ricordo. O comunque ce l’ho chiarissimo in mente. Restava torbida e come coperta di muffe. E io la stavo a guardare: una luna, mi sembrava, così faticosa”.