Cura e Postfazione (“Pavana per un’infanta”) di Monica Farnetti
Notizia bibliografica di Giuseppe Iannaccone
“Può darsi che tutte queste non fossero che fantasticherie, torbide supposizioni di un cuore che, ieri come oggi, è portato a vedere dovunque dei prigionieri, a riconoscere in ogni albero un carcere di spiriti ardenti, in ogni sasso una cella infame, dove qualcuno arde e si lamenta.”
Più si legge la Ortese e più ci si rende conto che è impossibile penetrare fino in fondo al fascino misterioso che tiene avvinti alle sue pagine, che è impossibile raggiungere il centro, il cuore profondo che le ha generate. Ogni suo libro appare al lettore come quello definitivo, quello che racchiude i lineamenti di uno spirito così complesso che, per non soccombere agli infiniti impulsi che lo sollecitano, sembra avere l’impellente bisogno di riversarsi e di rivelarsi attraverso un linguaggio ardito, evocativo, coloratissimo e capace di generare con la sua sola forza immagini inverosimili e di renderle plausibili, di dare vita a narrazioni là dove persino la sola immaginazione si arrenderebbe.
Ma poi la selvaggia malinconia, l’irriducibile struggimento che guidano la penna di questa grande scrittrice danno vita ancora e ancora a nuove avventure letterarie, perché tali sono le meravigliose architetture che reggono romanzi come “L’iguana”, “Il cardillo addolorato”, “Alonso e i visionari”, “Il porto di Toledo” e ogni volta si scoprono riconferme, si avvertono i segni di un clima noto, ma ogni volta la meraviglia è anche avvinta da qualcosa di diverso, arioso ed enigmatico, che genera dapprima sconcerto e poi ammirazione per una creatività che sa rinnovarsi e crescere su se stessa intorno al nucleo spirituale di un’anima che sfugge e si nasconde. “Nessuno scrittore ha insegnato alla Ortese questa callida acredine del discorrere, quella volatile furia e insieme quella macerazione labirintica che danno, fin dalle prime pagine, una letizia aspra, inquieta, insonne e insieme allucinatoria”, scrive Giorgio Manganelli. Ed è con i racconti giovanili che tale nucleo inizia a delinearsi, con quelli inseriti nelle sue due prime raccolte, “Angelici dolori” e “L’infanta sepolta”, vero e proprio laboratorio di quel misterioso vaneggiare intorno a immagini incantate che sarà cifra e conferma della maturità dell’autrice.
Monica Farnetti nella Postfazione alla presente edizione, dal bellissimo titolo “Pavana per un’infanta”, suddivide i diciassette racconti de “L’infanta sepolta” in tre gruppi, partizioni ovviamente affatto rigorose data la natura di una ispirazione letteraria che tende a sfuggire alle categorizzazioni, a indulgere a virate improvvise e a contaminare temi e generi: “.. la prima [è riservata] a miraggi, contemplazioni estatiche e apparizioni angeliche, la seconda a situazioni autobiografiche, infantili e non, spesso in varia accezione alterate, direbbe lei, dal rumore del mare [..], l’ultima a vedute, tipi e tradizioni di Napoli – non senza che tratti caratteristici di una sezione slittino in un’altra, e viceversa, scompigliandone il disegno complessivo”.
E’ già prepotentemente evidente in questi racconti giovanili quella intimità privilegiata con le creature che la Ortese utilizzerà più avanti per dare vita a iguane, puma, cardellini, animali arguti e fatati, ma anche a folletti, a bambini magici, a presenze angeliche, “Angeli soprattutto”, come scrive Monica Farnetti, “in figure di padri soavissimi, di amici lunari, di amanti perduti grevi di profezie e di stranieri ammantati di funebre dolcezza”. Intimità, vicinanza e immedesimazione con le creature, a patto che esse siano inermi, innocenti, incomplete, disperatamente bisognose di una consolazione che non avranno mai. Questo desiderio struggente sembra essere ovunque, e l’occhio visionario della scrittrice lo individua, lo fa vivere e vibrare in tutto ciò che l’uomo cosiddetto civile, compiuto e sicuro di sé, trascura perché non è in grado di vedere.. Può essere un bambino malamente amato o un adolescente toccato dalla grazia caduca dei suoi anni, un povero essere prigioniero, un animale ferito, una pianta, un filo d’erba, un oggetto dimenticato, un disegno appeso al muro, addirittura un lume ammiccante nella notte; tutto nelle pagine della Ortese ha un’anima, tutto convive in un mondo arcano e magico dove dolore e dolcezza possono persino coesistere, dove possono appunto esistere “angelici dolori”.
Il dolore e la dolcezza sono incantesimi che hanno la forza di mutare oggetti, ambienti e fenomeni naturali, ma solo se sono veicolati da un linguaggio letterario che, come scrive Pietro Citati “coglie e uccide per sempre il brulichio della vita”, quella refrattaria ad ogni minuscolo incanto: “.. così, in seguito a qualche cosa di lieve e di agitato, quale può essere la felicità, il dolore, oppure la semplice speranza o la pena di una persona che vive in una stanza, questa può mutarsi, e divenire ora un prato ora una caverna, ora un sentiero protetto dall’oro e il profumo delle gaggie, ora una landa sterminata o un pozzo abissale in cui si lamenti il vento, corrano i ragni e gonfino selvagge le ortiche” (dal racconto “Stregata una stanza”).
Indubbiamente troneggia, al centro di questa raccolta, l’immagine che le dà il titolo, quella infanta sepolta che il lettore della Ortese finirà per accomunare, per potenza letteraria, pur in un testo così breve, al cardellino, al puma e all’iguana dei romanzi maggiori, forse perché nata dalla stessa malinconica estasi, dallo stesso segreto dolore: “Nero il suo volto dai contorni acerbi e gentilmente allungati, nere le mani pari a zampine d’uccello, nere le trecce, neri gli occhi che ardevano sotto quella rotonda fronte. Dolore e un rapimento funesto li animavano. Erano occhi che pensavano, che ricordavano, che chiedevano; occhi spesso velati dalle memorie, distrutti da un desiderio arcano, abbagliati da canti remoti, da gridi di gioia, che lei sola, l’Infanta, poteva ascoltare. Un’indifferenza assoluta pel fanciullo che portava sul braccio, morto come chi non è mai nato; un fastidio, un orrore educatamente contenuti per quel luogo chiuso, allucinato, dove la sua giovinezza di idolo si consumava; un’attenzione cauta, una avidità dispersa, tremante, intesa a raccogliere il minimo passo, un grido, una voce cantante che suonassero al di là di quella porta, e non fossero quelli a lei noti dei monaci o di qualche vecchia supplichevole: ecco ciò che rendeva astratto e pensoso, ambiguo e travagliato, vivente di vita umana, il viso oscuro di quel simulacro”.
L’Infanta sepolta è una statua, una piccola Maestà Nera di legno chiusa in una grotta d’altare di una chiesa napoletana persa tra i vicoli del porto, poi distrutta dalla guerra, che la scrittrice bambina frequentava. La Ortese nel rievocarla la trasforma in una delle sue creature incomprese e sofferenti, la anima di una vita reclusa e anelante alla libertà dell’aria, del mare, delle grida e dei canti che non la raggiungono nella sua segregazione. Rende i suoi occhi vivi all’interno della corazza di legno e vi legge “la stanchezza di un fanciullo che muore”; con strazio infinito si immedesima nei pensieri di questa fanciulla desiderosa di calore umano e consapevole che non le verrà mai concesso: “Era orribile ed era vero. Si muoveva. Parlava come parlano a volte, quasi meccanicamente, una mano, un piede di poveri esseri massacrati, in cui la vita sussulta ancora”. Uno strazio talmente intollerabile che la distruzione della chiesa e con essa della statua è vissuta come una liberazione: “Ora la prigione è caduta, il simulacro dell’Infanta travolto. Disperse le sue membra nere così delicate; mozzata la testa che pensava; non si sa dove, sotto quale pietra, schiacciate, le sue zampine d’uccello. Vi sono sciagure teneramente invocate, tristezze che danno pace. Io sorrido, quando penso che sole, vento, pioggia, le cose e gli anni si avvicendano su quelle macerie.”.
L’Infanta, fanciulla designata con questo appellativo nobile e spagnoleggiante a causa della leggenda legata al suo arrivo a Napoli e alla sua provenienza, rende conto del legame che sussiste tra la produzione giovanile della Ortese e quella sua grande autobiografia romanzata costituita da “Il porto di Toledo” che l’autrice riscriverà fino alla sua morte, oltre che della consonanza della sua scrittura con la cultura del barocco spagnolo, pervaso, come sottolinea Monica Farnetti di sensualità e misticismo, di eterno e di effimero, di santità e di dissennatezza. L’anima di quella Napoli che la Ortese celebra e trasfigura nei racconti e nei romanzi e che ama per quelle luci e quelle ombre, per quei contrasti nei quali forse sente vibrare forte la vita, o forse placarsi, nell’eterno teatro dei vicoli, quel desiderio di senso e di completezza, speranza e dolore di ogni creatura; “Qui [..] tutte le cose, il bene e il male, la salute e lo spasimo, la felicità più cantante e il dolore più lacerato, santità e dissolutezza, pietà e voluttuosa ferocia, troni e galere, mercati ed altari, patiboli e giostre, i canti di gioia degli eletti e il singhiozzo lamentevole del dannato erano [..] saldamente strette, confuse, amalgamate tra loro. [..] Nelle loro case, in gran parte nere e miserande, vi erano angoli misteriosi, illuminati da brandelli di arcobaleno, e intenso lume di sole o debole e fascinoso di luna.” (dal racconto “Un personaggio singolare”).
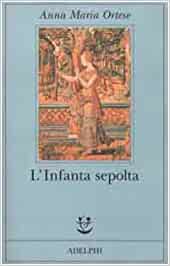
Una grande scrittrice!
Hai ragione. Uno stile inconfondibile, una sensibilità rara e una intelligenza acuta. Ogni suo libro è una scoperta e una sorpresa.