A cura di Alessandro Fo, Federico Lenzi, Antonio Pane, Claudio Vela
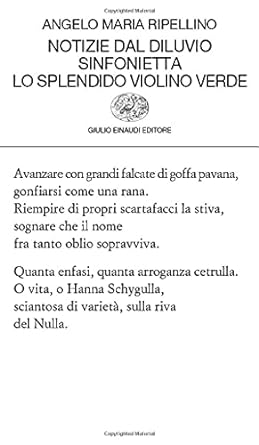
“Non c’è divario tra i miei saggi, i miei racconti, le mie liriche: allo stesso modo diramano le loro radici nell’humus del teatro, della finzione pittorica, allo stesso modo ricorrono alle duplicazioni e ai camuffamenti. Un’ebbra molteplicità di rimandi e reminiscenze ricerca e nutre il tessuto della mia scrittura: ombre jiddisch, immagini di Klee e di Magritte, motivi di Mahler e di Janáček, splendori barocchi, truculenze boeme, vampate di zolfo vi convergono come in un gran Baraccone dalle luci malate, scontorto da smorfie di clownerie, sconquassato da raffiche di ipocondria e di rimpianti.”
Così scrive Ripellino nel testo “Di me, delle mie sinfoniette”, riportato in Appendice al presente volume, confermando il sospetto che coglie i suoi lettori, abituati a ritrovare sempre nei suoi scritti, anche se di vario genere, la stessa esuberanza lessicale e originalità di pensiero che li rendono vivi, luminosi e toccati da una sorta di grazia. Esuberanza e originalità che ovviamente esplodono nella poesia, nel luogo in cui – ed è sempre l’autore ad affermarlo – si difende “la sempre insidiata libertà dell’uomo”. Le sue parole “tangibili come oggetti” sono al servizio di un pensiero che gioca, si camuffa, si diverte a costruire trabocchetti e castelli di illusioni fantastiche, ma che pure sosta sempre lì, sull’orlo di un abisso. La poesia di Ripellino è la lacrima disegnata sulla maschera di un clown. Ma è anche “il cuore e la fonte di ogni sua attività letteraria”, come afferma Alessandro Fo nell’introduzione al volume, perché per lui la poesia è “una manifestazione prepotentemente vitale, che ha il compito di lenire e contrastare il dolore e, a un più alto e decisivo livello di scontro, tenere a bada la morte”.
I versi di Ripellino catturano perché fanno leva sulla meraviglia, incuriosiscono perché sfruttano sapientemente il fascino dell’insolito, avvincono il lettore in una rete di luminose corrispondenze e lo conducono in territori che appaiono sempre nuovi e suadenti.
Per la prima raccolta presentata nel volume, “Notizie dal diluvio”, l’autore sceglie una epigrafe che appare in questo senso illuminante. Si tratta di una citazione da “Nämlich”, un romanzo in lingua tedesca del cecoslovacco Paul Adler: “C’è però qualcosa nel mio essere, che chiede non un medico ma forse un incantatore. C’è in me lo stesso fruscio che nella conchiglia lontano dal mare. Ma non esistono più incantatori purtroppo dal tempo di Hoffmann…”. Solo un incantatore può guidare chi si appresta a percorrere quell’itinerario nel meraviglioso che secondo Ripellino è la vera natura della Letteratura, per riprendere il titolo di un suo bellissimo saggio sulla letteratura russa. La sua lingua poetica, colorata e spumeggiante, sognante e avventurosa, avvolge il lettore in una sorta di turbinio di invenzioni che lo collocano direttamente sul palco di un teatro o sulla pedana di un circo, forse perché, come l’autore scrive in alcuni suoi versi “.. un giorno/ parecchi avranno sete di bianca fantasia./ Per loro io lavoro, per di qui a cento anni.”
Eppure, la magia e l’incanto, quell’effetto stregonesco che questa poesia è in grado di suscitare nel lettore, lascia intravedere a sprazzi accenti di una inguaribile malinconia, che si evidenzia per contrasto con la perenne luminosità di cui è circondata e in qualche modo sostenuta. Federico Lenzi, autore dello scritto che nel volume introduce la raccolta “Notizie dal diluvio”, riporta la definizione che Ripellino stesso dava di queste poesie, riportandola sulla quarta di copertina della prima edizione del 1969: “diario di un anno calamitoso”.
Si tratta dunque di una sorta di diario in versi, che ripercorre con il carattere immaginifico e allusivo della poesia vicende che hanno reso il 1968 l’annus horribilis nell’esistenza del poeta e che quindi rende la sua scrittura la testimonianza di ciò che rimane di un mondo personale e pubblico colpito dagli effetti di un diluvio, di una calamità che corrode le certezze e trascina via ogni possibile speranza di un futuro migliore.
Un diluvio è l’invasione sovietica della Cecoslovacchia culminata nella notte tra il 21 e il 22 agosto 1968, dopo l’illusione di quella breve primavera di Praga che Ripellino segue come inviato de “L’Espresso”. Un evento che gli preclude il ritorno in quella città tanto amata, diventata la sua patria d’elezione, dove comunque i suoi versi nostalgici continuano ad aggirarsi, respirando le sue atmosfere e la sua magia, piangendo un mondo perduto, fiammeggianti d’ira e di odio contro l’invasore (“Male olide frotte di negromanti, caterve/ di messaggeri di brume e machiavellisti,/ ungari, lupi bulgari, cinghiali di Mazòvia,/ segugi e sgabelli e satelliti di inquisitori e anticristi,/ maestri di scaltritezza imbottiti di boria/ vanno e vengono dall’Aldilà, dai sottili confini,/ calpestando la nostra alterità ed interezza,/ minacciano di castigarci, di stringere il cappio/ delle trecce d’aglio delle nostre colpe.”).
Un diluvio è la consapevolezza della sua malattia che non gli permette più di sperare nel futuro, che gli preclude la possibilità di mantenere nella sua scrittura quella leggerezza sognante, divertita e fantasiosa che gli è tanto congeniale (“E da tempo so il nome dell’implacabile/ ombra-sgherro che mi braccheggia”). E così quell’arcobaleno di colori, quel “chiassoso circo animale accompagnato da trombe, tamburi e da strumenti meno comuni”, quella sua lingua così vivace e complessa, condita da arcaismi e neologismi, quella sua “smania di nomenclature” e quella sua “passione per gli ammucchiamenti di oggetti”, pur sopravvivendo, vira verso la tristezza e si trasforma nel velo che non riesce a nascondere la desolata constatazione dell’approssimarsi della fine. Il guitto che da sempre abita l’anima del poeta sa ormai che la vita è in fondo un “disperatissimo imbroglio” (“Scende a colpi di accetta la vecchiaia,/ l’uomo si spacca come un tronco./ Nel cavo di simili piante un fugace rifugio/ trova talvolta qualcuno più giovane./ Ma chi vorrà servirsi di questa piroga scheggiata/ con mille puntini di spari di tosse,/ di questa saggezza da sbriciolare ai passeri,/ di questo feltro da tenda che ormai lascia filtrare la pioggia,/ di questa pagina lambita dalle fiamme, come Blake,/ di questa muffita afflizione, che un tempo/ era un vetro soffiato,/ un albero di anemoni?”; “Io resterò da questa parte, in questo buio,/ in questo viluppo di meschinità e di bisogno,/ senza conoscere il terso luccichio del futuro./ A me sarà bastato visitarlo nel sogno,/ come uno sciamano che scenda con piatti e sonagli/ nel reame dei morti a conversare coi lemuri./ Resterò sulla soglia come un reprobo, come uno spergiuro./ Perché scusatemi, posteri, che freddo,/ che vitreo deserto, che uniformità, che sbaragli/ soffiano da quel futuro.”; “Tu pensi che, quando cresce il tuo male,/ si spengano i fuochi, le barche non prendano il mare,/ si proibisca ai cani di latrare,/ i figli si incantino come sculture di sale.// Oh no, lascia perdere. Osserva/ la ghiandaia azzurra che ruba/ il tuo ultimo cucchiaino d’argento./ Ferma lo sguardo sgomento/ sull’estranea bellezza di questa caraffa in cui luccica/ tutto il ghiaccio del mondo.”).
Infine, ancora più dolorosa è per il poeta la consapevolezza che il diluvio di questo anno calamitoso finirà per spazzare via anche la possibilità di vivere gli affetti più cari, come quello per la moglie Ela Hlochová, sua compagna, madre dei suoi figli, ma anche valida collaboratrice nella sua opera di traduttore e saggista. A lei dedica versi densi di pena e che suonano come una accorata ribellione contro il destino: “Dove trovarti, quando avrò desiderio di te, dei tuoi occhi smeraldi,/ quando avrò bisogno delle tue parole?/ Dio esige l’impossibile,/ Dio ci obbliga a morire./ E che sarà di tutto questo garbuglio di affetto,/ di questo furore? Sin d’ora promettimi/ di cercarmi nello sterminato paesaggio di sterro e di cenere,/ sui legni carichi di mercanzie sepolcrali,/ in questo teatro spilorcio, in quel vortice/ e magma di larve ahimè tutte uguali,/ fra quei lugubri volti. Saprai riconoscermi?”.
Come epigrafe a “Sinfonietta” – la seconda delle tre grandi raccolte proposte da Einaudi nel presente volume – che, come scrive Federico Lenzi, ripropone il titolo di un’opera del compositore ceco Leoš Janáček, Ripellino sceglie dei versi di Záviš, un accademico praghese del XIV secolo: “Il cigno, uccello raro,/ canta morendo:/ anch’io, triste scolaro,/ muoio cantando dallo struggimento…”. E’ evidente che queste ottantadue poesie si possono leggere come la continuazione di quel diario in versi che il poeta aveva iniziato con la precedente raccolta, come la germinazione fruttuosa dei relitti che dal diluvio si erano salvati, ben lontana quindi dalla rassegnazione che quell’addio così sconsolato poteva far intuire: “Così se ne va per il mondo la gioia, la giovinezza,/ lasciandoci obliqui, appassiti, di pezza.”.
Il poeta è un cigno morente che però continua a cantare e ad utilizzare le sue “venature tematiche guida”, facendo loro comporre, come un funambolo o un giocoliere, mille disegni diversi che costituiscono un intero universo poetico, lo spartito delle sue sinfonie. Alessandro Fo, nella sua Introduzione al volume, ne individua alcune, quelle maggiormente ricorrenti: “i clown, i treni e le stazioni, le candele, la pioggia, il mare e le onde, la nomenclatura geografica, il teatro, l’armadio, le stoffe e i capi di vestiario, il violino, l’amore con le sue meravigliose goffaggini e buffonerie”, ma è lo stesso Ripellino, nei risvolti di copertina della prima edizione di “Sinfonietta” del 1972, ad aggiungere ai suoi attrezzi di giocoliere i personaggi che appaiono “come feticci alle finestre delle poesie: bianchi musi di gesso, pagliacci, venditori di oroscopi, garzoni fornai, menestrelli, pupazzi di trucioli, larve febbrili..”. Il cigno morente utilizza i suoi strumenti e canta, per dissipare il proprio malessere e per sopravvivere a quella che lui chiama la demonía di un mondo oppresso dalla violenza (“Le parole sparute che io scrivo/ non hanno virtù di salvarmi/ come i talismani e i pentàcoli./ Mi servono solo a costruire/ senza stregonerie né miracoli/ la mia meschina eternità, la mia buffa/ nicchia di allocco impagliato,/ la mia cupola già verderame, già muffa,/ la mia immagine di trapassato./ Devo appendere pesi ai piedi del vento,/ sgusciare al nodo scorsoio della luce,/ e rimbrotto la ruggine,/ che già si appresta a sbiadirmi./ Diranno i nipoti: il signor Gobellino,/ questo archivio di preziosità e anacronismi,/ portava calzoni rigonfi come cipolle,/ un cuore dipinto sul suo balachòn di pierrot, un cilindro sghimbescio da music-hall./ E, anche se affranto da mille malori,/ danzava la vita come un cavallo ammaestrato./ Eppure danzare per lui era difficile come/ percorrere un lungo convoglio sciancato,/ scavalcando montagne di viaggiatori,/ perché costretto a lottare per ogni filo di fiato.”).
Nella terza raccolta, “Lo splendido violino verde”, la poesia di Ripellino sembra esplodere nella più assoluta libertà espressiva. Tutti i temi usuali, si sommano e aggrovigliano, vengono riproposti in composizioni inedite attraverso giochi linguistici arditi e arguti, in un repertorio che trabocca di oggetti, di personaggi veri, fittizi o inverosimili, e di tantissime musiche, quelle più amate dal poeta. Sembra quasi che la tristezza della prima raccolta si sia trasformata in ribellione al destino nella seconda, per poi mutarsi nell’ultima in un estremo ma prolifico tentativo di recuperare la gioia liberante della scrittura, di quella magia che il poeta si ritrova tra le mani e che gli permette di trasformare la rabbia in ironia e in alcuni momenti in leggerezza divertita. Lo splendido violino verde è proprio la sua poesia, una metafora che richiama la leggerezza e lo struggimento di un’immagine ricorrente nei quadri di Chagall a cui probabilmente Ripellino intende riferirsi con questo titolo. La raccolta è composta da due parti; la prima è intitolata “Das letze Varieté” (L’ultimo varietà) e la seconda prende il nome dall’opera lirica di Donizetti “Don Pasquale”, caratterizzata dalla leggerezza di intrighi e vicende amorose. E proprio l’opposizione tra l’evidenza del male e la ricerca dell’ebbrezza della vita che pur continua e che si mostra a volte grottesca, a volte gioiosa, è l’impianto che sottotraccia percorre l’intera raccolta (“Siamo allocchi avviliti,/ dondolanti su lunghi bastoni,/ fagotti con buffi barboni,/ con occhi di vetro./ Siamo allocchi intontiti/ in mano a un pazzo uccellaio,/ in mezzo al tetro/ abbaruffío di un mercato,/ avvolti con funebre pasta di corde.// Eppure ti illudi, Signore, di averci ammaestrato./ Tu pensi che scenderanno a ballare i tuoi nani/ da fiera, i tuoi granchi, le tue catoblepe,/ come tu vuoi, con fanfare balorde?/ Resteremo così: imbambolati, cosparsi di crepe,/ ma sempre sovrani.”).
Quest’ultima raccolta non è introdotta da un’epigrafe, che è invece presente all’inizio dell’ultima poesia, che è sintesi e conclusione di un lungo discorso poetico.
“Stelle! Non voglio morire! Sono pieno di talento!”
Jules Laforgue, “Éclair de gouffre”
Sonare su un violino in fiamme
una mia seguidilla,
prima che cada il sipario come una ghigliottina.
Mi piace il fragore, il bailamme,
ma la mia vita arlecchina,
veliero viluppo di stracci,
con la sua gracile chiglia
si impiglia in un groppo di ghiacci.
Avanzare con grandi falcate di goffa pavana,
gonfiarsi come una rana.
Riempire di propri scartafacci la stiva,
sognare che il nome
fra tanto oblio sopravviva.
Quanta enfasi, quanta arroganza cetrulla.
O vita, o Hanna Schygulla,
sciantosa di varietà, sulla riva
del Nulla.
L’anno scorso ricorreva il centenario della nascita di questo nostro grande poeta e saggista e il cinquantesimo della pubblicazione del suo volume più celebre, “Praga magica”. Nessun oblio potrà cancellare il suo nome.