THOMAS BERNHARD – Sotto il ferro della luna – Crocetti
Traduzione di Samir Thabet
“Dietro il bosco nero/ brucio questo fuoco della mia anima/ in cui tremola il fiato delle città/ e il merlo della paura./ A mani nude abbatto queste fiamme/ che all’aria montano sino al cervello/ e che tremano nel mio nome./ Come una nuvola il mio cuore migra/ sui tetti/ vicino ai fiumi/ finché io, una tarda pioggia, ritorno/ nel profondo autunno”.
Luigi Reitani, nel saggio “L’arte dell’Ars moriendi”, che appare in postfazione alla sua traduzione della raccolta “In hora mortis”, edita da SE nel 2002, fornisce le informazioni necessarie per inquadrare la produzione poetica di Bernhard: cinque volumi di versi – “Sulla terra e nell’inferno” (1957), “In hora mortis” (1958), “Sotto il ferro della luna” (1958), “I folli. I forzati” (1962), “Ave Virgilio” (risalente agli stessi anni, ma pubblicato nel 1981) – ai quali si aggiunge una raccolta rimasta in gran parte inedita, comprendente 140 poesie, già pronta per la stampa nel 1960, che avrebbe dovuto avere come titolo “Frost” (Gelo), scelto poi da Bernhard per il suo primo romanzo uscito nel 1963. “Sotto il ferro della luna” è la terza raccolta edita in traduzione italiana (ad opera di Samir Thabet), segue infatti “Ave Virgilio” (Guanda, 1991, tradotta da Anna Maria Carpi) e “In hora mortis” (SE, 2002, tradotta da Luigi Reitani). Si tratta di una produzione non indifferente quanto a mole, tutta risalente agli anni giovanili dell’autore che, dopo la pubblicazione di “Gelo”, nel 1963, non ritornerà più al genere della lirica, ma si dedicherà esclusivamente alla prosa e alla scrittura teatrale. E’ una curiosa, ma anche significativa coincidenza, il fatto che, esattamente negli stessi anni, anche Ingeborg Bachmann, altra voce d’eccellenza della letteratura austriaca del secondo Novecento, abbia compiuto la stessa scelta.
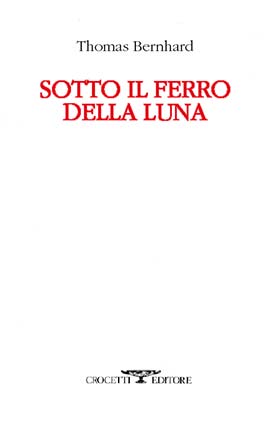
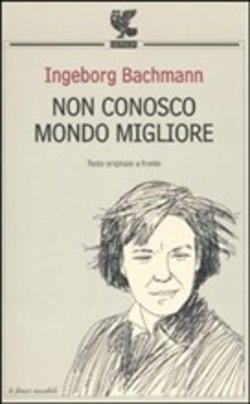
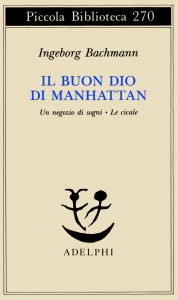
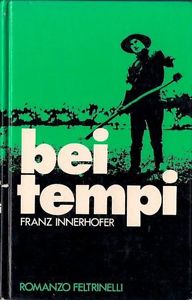
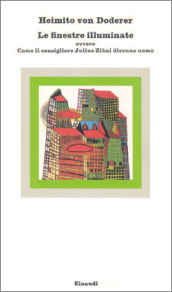
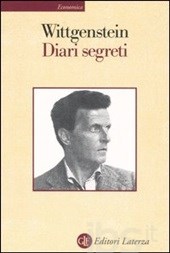 “Si potrebbe fissare il prezzo dei pensieri. Alcuni costano molto, altri poco. E con che cosa si pagano i pensieri? Io credo così: con il coraggio” (Ludwig Wittgenstein)
“Si potrebbe fissare il prezzo dei pensieri. Alcuni costano molto, altri poco. E con che cosa si pagano i pensieri? Io credo così: con il coraggio” (Ludwig Wittgenstein) “Ho scoperto di non appartenere più a nessun paese, non ho più nostalgia di nessun posto, una volta era diverso, una volta credevo di avere un cuore e di appartenere all’Austria. Ma tutto passa prima o poi, il cuore vien meno e una certa mentalità va perduta, solo che sento in me qualcosa che sanguina, e non so cos’è”.
“Ho scoperto di non appartenere più a nessun paese, non ho più nostalgia di nessun posto, una volta era diverso, una volta credevo di avere un cuore e di appartenere all’Austria. Ma tutto passa prima o poi, il cuore vien meno e una certa mentalità va perduta, solo che sento in me qualcosa che sanguina, e non so cos’è”.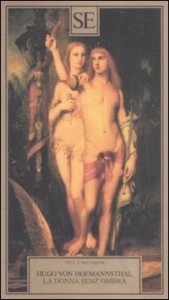 Elogio dell’ombra, dell’imperfezione e del limite, perché solo l’ombra, l’imperfezione e il limite, e quindi l’idea della morte, intesa come consapevolezza della ineluttabilità della fine, hanno in sé i germi della fecondità e quindi la forza capace di generare la vita, e quella irrinunciabile vita dello spirito che è la creazione artistica. A circa un secolo dalla pubblicazione della “Storia straordinaria di Peter Schlemihl” di Adelbert von Chamisso, Hugo von Hofmannsthal si impadronisce di questo fecondo topos letterario, lo reinterpreta, lo rielabora, lo stravolge e se ne lascia conquistare, creando la prosa cristallina e rarefatta del suo ultimo testo narrativo, apoteosi e vertice di una produzione che sarà successivamente dedicata unicamente al teatro. Nata contemporaneamente al libretto per l’omonima opera di Richard Strauss (rappresentata per la prima volta a Vienna il 10 ottobre 1919), “La donna senz’ombra” si trasforma ben presto nelle mani di Hofmannsthal in un racconto autonomo che sottopone il suo autore ad uno sforzo compositivo notevolissimo, testimoniato dagli stralci tratti dai suoi epistolari, riportati nella Postfazione alla presente edizione curata da Elisabetta Potthoff. Un lavoro che procede nel segno della sottrazione, della decantazione e della purificazione di una trama nata sotto l’insegna della potenza icastica della fiaba e della vertigine della polisemia, dell’accumulo di significati e quindi di possibili interpretazioni.
Elogio dell’ombra, dell’imperfezione e del limite, perché solo l’ombra, l’imperfezione e il limite, e quindi l’idea della morte, intesa come consapevolezza della ineluttabilità della fine, hanno in sé i germi della fecondità e quindi la forza capace di generare la vita, e quella irrinunciabile vita dello spirito che è la creazione artistica. A circa un secolo dalla pubblicazione della “Storia straordinaria di Peter Schlemihl” di Adelbert von Chamisso, Hugo von Hofmannsthal si impadronisce di questo fecondo topos letterario, lo reinterpreta, lo rielabora, lo stravolge e se ne lascia conquistare, creando la prosa cristallina e rarefatta del suo ultimo testo narrativo, apoteosi e vertice di una produzione che sarà successivamente dedicata unicamente al teatro. Nata contemporaneamente al libretto per l’omonima opera di Richard Strauss (rappresentata per la prima volta a Vienna il 10 ottobre 1919), “La donna senz’ombra” si trasforma ben presto nelle mani di Hofmannsthal in un racconto autonomo che sottopone il suo autore ad uno sforzo compositivo notevolissimo, testimoniato dagli stralci tratti dai suoi epistolari, riportati nella Postfazione alla presente edizione curata da Elisabetta Potthoff. Un lavoro che procede nel segno della sottrazione, della decantazione e della purificazione di una trama nata sotto l’insegna della potenza icastica della fiaba e della vertigine della polisemia, dell’accumulo di significati e quindi di possibili interpretazioni.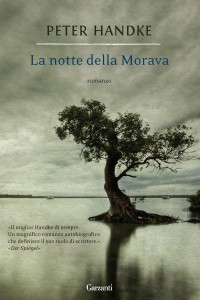 “La notte della Morava”, uscito in Germania nel 2008, non è l’ultimo romanzo di Handke, ma possiede tutte le caratteristiche dell’opera definitiva: le sue pagine sono il resoconto poetico di una vita, la riscoperta e la rilettura di un’origine e di una appartenenza, il canto di una balcanicità perduta, la lotta all’ultimo sangue condotta fino al rifiuto, fino al silenzio, contro la scrittura, contro un destino e una vita ad essa dedicati. E ancora: un pellegrinaggio a tappe verso luoghi e paesaggi dell’anima, un viaggio interiore nella memoria e nella consapevolezza della propria essenza e poi il bilancio di un amore, così conturbante e violento da essere desiderato, ma innumerevoli volte rifiutato e avvertito come un pericolo. Handke, che è uno scrittore esigente con i suoi lettori, con il suo stile ostico, spesso criptico, con le sue favole metafisiche, con quegli sprazzi di poeticità così rari, improvvisi e avari che sembrano evitare di proposito qualsiasi possibilità di condivisione o di riconoscimento, con questo romanzo li travolge letteralmente, concedendo loro l’accesso ad una materia narrativa fantastica ma anche evidente trasposizione di esperienze e memorie reali, oltretutto strutturata in modo geniale ed accattivante, in grado di mantenere uno schermo, una sorta di residua distanza tra l’autore e la narrazione e quindi tra l’autore e il lettore.
“La notte della Morava”, uscito in Germania nel 2008, non è l’ultimo romanzo di Handke, ma possiede tutte le caratteristiche dell’opera definitiva: le sue pagine sono il resoconto poetico di una vita, la riscoperta e la rilettura di un’origine e di una appartenenza, il canto di una balcanicità perduta, la lotta all’ultimo sangue condotta fino al rifiuto, fino al silenzio, contro la scrittura, contro un destino e una vita ad essa dedicati. E ancora: un pellegrinaggio a tappe verso luoghi e paesaggi dell’anima, un viaggio interiore nella memoria e nella consapevolezza della propria essenza e poi il bilancio di un amore, così conturbante e violento da essere desiderato, ma innumerevoli volte rifiutato e avvertito come un pericolo. Handke, che è uno scrittore esigente con i suoi lettori, con il suo stile ostico, spesso criptico, con le sue favole metafisiche, con quegli sprazzi di poeticità così rari, improvvisi e avari che sembrano evitare di proposito qualsiasi possibilità di condivisione o di riconoscimento, con questo romanzo li travolge letteralmente, concedendo loro l’accesso ad una materia narrativa fantastica ma anche evidente trasposizione di esperienze e memorie reali, oltretutto strutturata in modo geniale ed accattivante, in grado di mantenere uno schermo, una sorta di residua distanza tra l’autore e la narrazione e quindi tra l’autore e il lettore.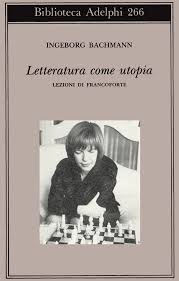 “Ferito di realtà e in cerca di realtà, consegna la propria esistenza alla lingua” (Paul Celan)
“Ferito di realtà e in cerca di realtà, consegna la propria esistenza alla lingua” (Paul Celan)