MALCOLM LOWRY – “Buio come la tomba dove giace il mio amico” – Mondadori
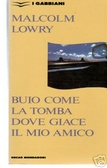 Si legge questo libro come tributo al Console di “Sotto il vulcano”, come un pegno pagato alla nostalgia che il protagonista del romanzo più famoso di Lowry, ma anche le atmosfere e i luoghi in cui si aggira quell’indimenticabile “divagatore alcolizzato” lasciano nel lettore. C’è un legame talmente stretto tra i due romanzi, che non è quasi possibile comprendere e apprezzare questo “Buio come la tomba dove giace il mio amico”, così colmo di allusioni, ricordi e riferimenti all’opera precedente, prescindendo dalla sua conoscenza o, addirittura, in molti casi, dalla sua puntuale consultazione. Eppure non si tratta di una semplice continuazione; d’altra parte Lowry può essere definito in molti modi, ma sicuramente è uno scrittore tutt’altro che semplice. Il suo fascino risiede tra le pieghe di una complessità che continuamente interroga il lettore. Una complessità che investe prima di tutto la natura della sua intera produzione. Come spiega Alex R. Falzon nella Postfazione alla presente edizione, il programma letterario di Lowry si basa su un metodo di lavoro eccentrico, originale e, forse, eccessivamente ambizioso. Tutte le sue opere contribuiscono alla realizzazione di un unico, immenso progetto, un vero e proprio ciclo, di cui ogni romanzo o racconto costituisce un tassello, indispensabile per la costruzione del disegno finale, dal titolo “Il viaggio che non ha fine”.
Si legge questo libro come tributo al Console di “Sotto il vulcano”, come un pegno pagato alla nostalgia che il protagonista del romanzo più famoso di Lowry, ma anche le atmosfere e i luoghi in cui si aggira quell’indimenticabile “divagatore alcolizzato” lasciano nel lettore. C’è un legame talmente stretto tra i due romanzi, che non è quasi possibile comprendere e apprezzare questo “Buio come la tomba dove giace il mio amico”, così colmo di allusioni, ricordi e riferimenti all’opera precedente, prescindendo dalla sua conoscenza o, addirittura, in molti casi, dalla sua puntuale consultazione. Eppure non si tratta di una semplice continuazione; d’altra parte Lowry può essere definito in molti modi, ma sicuramente è uno scrittore tutt’altro che semplice. Il suo fascino risiede tra le pieghe di una complessità che continuamente interroga il lettore. Una complessità che investe prima di tutto la natura della sua intera produzione. Come spiega Alex R. Falzon nella Postfazione alla presente edizione, il programma letterario di Lowry si basa su un metodo di lavoro eccentrico, originale e, forse, eccessivamente ambizioso. Tutte le sue opere contribuiscono alla realizzazione di un unico, immenso progetto, un vero e proprio ciclo, di cui ogni romanzo o racconto costituisce un tassello, indispensabile per la costruzione del disegno finale, dal titolo “Il viaggio che non ha fine”.

 Il Console, questo personaggio inevitabilmente e perdutamente amato dai lettori di Lowry, è il protagonista di una tragedia che si preannuncia nelle prime pagine del libro e che si compie rapidamente nelle ultime. Quello che è richiesto e imposto al lettore da uno stile trascinante e lussureggiante è di seguire il succedersi degli eventi che si snodano lenti, che indugiano, che rallentano fino a fermarsi per dar luogo a splendide divagazioni. Quello che è chiesto al lettore è di condividere lo sguardo ubriaco del Console sul mondo, sulla realtà, uno sguardo di volta in volta lucidissimo o visionario, disperato, rassegnato o, persino, ingenuo. La strada, amarissima, verso la disillusione è costellata da momenti di rara intensità emotiva e lirica.
Il Console, questo personaggio inevitabilmente e perdutamente amato dai lettori di Lowry, è il protagonista di una tragedia che si preannuncia nelle prime pagine del libro e che si compie rapidamente nelle ultime. Quello che è richiesto e imposto al lettore da uno stile trascinante e lussureggiante è di seguire il succedersi degli eventi che si snodano lenti, che indugiano, che rallentano fino a fermarsi per dar luogo a splendide divagazioni. Quello che è chiesto al lettore è di condividere lo sguardo ubriaco del Console sul mondo, sulla realtà, uno sguardo di volta in volta lucidissimo o visionario, disperato, rassegnato o, persino, ingenuo. La strada, amarissima, verso la disillusione è costellata da momenti di rara intensità emotiva e lirica. Stevenson scrisse questi splendidi racconti a Upolu, la principale delle isole Samoa, dove trascorse gli ultimi cinque anni della sua vita straordinaria. Gli isolani lo chiamavano “Tusitala”, il narratore di storie e lo consideravano una specie di nume tutelare. Tra queste righe si nascondono i profumi e le luci di una terra da lui amatissima e le suggestioni, i misteri, le paure ataviche e le leggende tramandate dai suoi abitanti. Prima di morire aveva più volte detto di voler essere sepolto sulla cima del Monte Vaea, il più alto dell’isola, per poter dominare dall’alto il mare che tanto amava, così gli isolani di Samoa gli tributarono un funerale che sembra tratto da uno dei suoi racconti.
Stevenson scrisse questi splendidi racconti a Upolu, la principale delle isole Samoa, dove trascorse gli ultimi cinque anni della sua vita straordinaria. Gli isolani lo chiamavano “Tusitala”, il narratore di storie e lo consideravano una specie di nume tutelare. Tra queste righe si nascondono i profumi e le luci di una terra da lui amatissima e le suggestioni, i misteri, le paure ataviche e le leggende tramandate dai suoi abitanti. Prima di morire aveva più volte detto di voler essere sepolto sulla cima del Monte Vaea, il più alto dell’isola, per poter dominare dall’alto il mare che tanto amava, così gli isolani di Samoa gli tributarono un funerale che sembra tratto da uno dei suoi racconti. Non so se mi capiterà ancora di incontrare un libro di Walter De la Mare e la sua “sussurrata malìa che lascia libero accesso ai fantasmi della mente” (sembra che così Eliot definisse la sua arte), ma so che questo racconto, così ricco nella sua brevità, così intenso e insieme controllato (cosa rara), testimonianza della grande perizia del suo autore, ma anche della sua capacità di sollecitare la collaborazione del lettore, addirittura la sua presenza nell’oscurità del luogo in cui tutto ciò che è grottesco, misterioso e infine tragico si compie, non me lo dimenticherò. Dal punto di vista narrativo, De la Mare mi appare come un grande maestro nell’arte di accentuare la tensione, mediante il rinvio, la dilazione e la divagazione, nella capacità cioè di disperdere i meccanismi narrativi, di usarli come ferri del mestiere ma di tenerli celati in un magazzino che non è aperto al pubblico.
Non so se mi capiterà ancora di incontrare un libro di Walter De la Mare e la sua “sussurrata malìa che lascia libero accesso ai fantasmi della mente” (sembra che così Eliot definisse la sua arte), ma so che questo racconto, così ricco nella sua brevità, così intenso e insieme controllato (cosa rara), testimonianza della grande perizia del suo autore, ma anche della sua capacità di sollecitare la collaborazione del lettore, addirittura la sua presenza nell’oscurità del luogo in cui tutto ciò che è grottesco, misterioso e infine tragico si compie, non me lo dimenticherò. Dal punto di vista narrativo, De la Mare mi appare come un grande maestro nell’arte di accentuare la tensione, mediante il rinvio, la dilazione e la divagazione, nella capacità cioè di disperdere i meccanismi narrativi, di usarli come ferri del mestiere ma di tenerli celati in un magazzino che non è aperto al pubblico. “Sono un appassionato lettore di storie cliniche, ma non ho mai letto dei racconti psicologici così intensi come quelli narrati da Oliver Sacks nell’Uomo che scambiò sua moglie per un cappello. E’ un libro che vorrei consigliare a tutti: medici e malati, lettori di romanzi e di poesia, cultori di psicologia e di metafisica, vagabondi e sedentari, realisti e fantastici. La prima musa di Sacks è la meraviglia per la molteplicità dell’universo”. (Pietro Citati)
“Sono un appassionato lettore di storie cliniche, ma non ho mai letto dei racconti psicologici così intensi come quelli narrati da Oliver Sacks nell’Uomo che scambiò sua moglie per un cappello. E’ un libro che vorrei consigliare a tutti: medici e malati, lettori di romanzi e di poesia, cultori di psicologia e di metafisica, vagabondi e sedentari, realisti e fantastici. La prima musa di Sacks è la meraviglia per la molteplicità dell’universo”. (Pietro Citati)