ALEKSANDER WAT – Lucifero disoccupato – Salerno Editrice
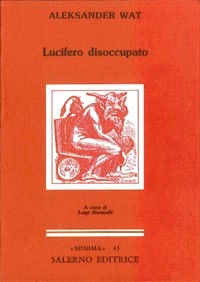
“La notte fiorisce d’un colpo di stellati esorcismi,
coi quali il giorno scaccia le nubi odorose di muschio.”
Nel 1927, mentre Stanislav I. Witkiewicz sta lavorando al suo romanzo maggiore, “Insaziabilità”, esce a Varsavia una raccolta di nove racconti, dal titolo “Lucifero disoccupato”, prima opera in prosa del giovane ventisettenne Aleksander Wat. La presente edizione italiana ne contiene cinque; presso Salerno Editrice, nella stessa collana “Minima” sono disponibili gli altri quattro, raccolti sotto il titolo “L’ebreo errante”. Apprezzata da Bruno Schulz e dallo stesso Witkiewicz, quella di Wat è un’altra voce luminosa e sferzante che si leva dalla fortunata stagione delle avanguardie polacche – letterariamente fortunata, ma drammatica e tragica per gli accadimenti storici che ne costituiscono lo sfondo e per i destini personali dei suoi protagonisti. Un giovanile furore, intransigente ed irridente, pervade queste pagine, letteralmente dissacranti, perché non si limitano a percorrere un mondo senza Dio, ma vanno ben oltre, riducendo lo stesso Lucifero, da potente e inquietante incarnazione del male a tragicomico personaggio, inerme e imbelle. Perché anche Lucifero è inutile in un mondo senza Dio.Ancora il “demonismo” dunque, quel demonismo che Gombrowicz riconosce come cifra prevalente dell’opera di Witkiewicz, ma ben lontano dal “catastrofismo decadente” (definizione coniata da Luigi Marinelli nella sua bella introduzione al presente volume, “L’una e l’altra parte di Aleksander Wat”) di quest’ultimo, lontano, diametralmente opposto, ma ad esso imparentato da una comune origine: il riconoscimento dell’irrimediabile fallimento degli ideali di un’intera generazione. C’è un termine ora abusato ma ancora affascinante e, soprattutto, calzante, per definire la visione del mondo delle giovani avanguardie, polacche e non solo: nichilismo. Quello che percorre i grandi capitoli della storia letteraria europea del Novecento, fino alla letteratura contemporanea, quello che Magris in molti suoi saggi, primo fra tutti “L’anello di Clarisse”, esamina con rigore, trovandolo spesso – e quasi illogicamente – indissolubilmente legato al grande stile. Lo afferma chiaramente lo stesso Wat nel suo “Diario parlato”, uscito in Italia con il titolo “Il mio secolo” – una lunghissima conversazione con il Premio Nobel Czeslav Milosz – parlando di questi racconti: “E se si considera Lucifero disoccupato racconto per racconto, è come se mi fossi sistematicamente confrontato in questa piccola raccolta con tutte le idee fondamentali dell’umanità: la morale, la religione, perfino l’amore. Volevo addirittura screditare il concetto di personalità […] Smascherare praticamente ogni cosa. Nulla. Punto e basta. Finito. Nihil”.
Un Lucifero triste e depresso che vaga per la città, intimorito dalla indifferenza che la gente gli dimostra, che non può trascinare nel regno del male chi non crede nemmeno nell’esistenza del valore supremo del bene, è la figura, ridicola più che beffarda, intorno alla quale Wat costruisce le sue novelle, a prima vista dettate da un feroce spirito satirico e parodistico. A prima vista, perché Wat è uno scrittore polacco, anzi uno scrittore ebreo polacco e i suoi “maligni” racconti, condotti sul filo del grottesco, rivelano a volte – e sono i passi migliori – la traccia di un sorriso disincantato e inerme, quasi bonario e desolatamente rassegnato, oppure un accanimento sospetto, che finisce per assomigliare ad un lamento. Forse perché, se non è data creazione asettica, a maggior ragione è impossibile una dissezione chirurgica senza ombra di pena o di rimpianto. Così, per esempio, Wat, già poeta ma che lo diverrà sempre di più negli anni della sua tormentata maturità, introducendo Lucifero nel caffè dei poeti, presta la sua voce ad una invettiva che è in realtà una dichiarazione d’amore per la parola: “Qui si riunivano i saccenti che succhiano saggezza dal poppatoio delle parole. Purtroppo! Purtroppo! Da troppo tempo ci manca un’allattatrice di rivelazioni! Le parole sono tubercolotiche, sifilitiche e conservano in innumerevoli membrane le formicolanti colonie di microbi della polisemia […] E se anche si è trovata in qualche recesso una parola sana, ben saldata alla terra, ci hanno pensato poi i poeti a toglierle le catene e ad attaccarla a un cielo nudo e vuoto. Erano soltanto delle piccole bolle colorate di parole!”.
Se Satana disoccupato è l’antieroe per eccellenza di Wat, un povero diavolo che intende suicidarsi perché la contemporaneità non ha bisogno di lui, che addirittura si sente ridotto ad un essere umano, ma ad un uomo di troppo, perché il mondo “è plus diabolique que le diable meme”, nei racconti successivi della raccolta fanno la loro apparizione personaggi burloni e malinconici dai quali traspare maggiormente l’ingenua raffinatezza dell’aneddottica ebraica. Personaggi lucidi e tragici, tratteggiati con un tocco lieve che li accompagna anche nel cuore delle più assurde o grottesche situazioni, quello che Marinelli definisce “lo spirito sognante del chassidismo”. E’ il caso di Raffaele, protagonista del bellissimo “Non avete mica visto via dei Piccioni?”, tutto giocato sul potere di convincimento della finzione e della menzogna che si rivela più forte della verità e che, al di là del suo significato e del suo scioglimento narrativo, è uno splendido viaggio nel surreale, nella “minaccia del quotidiano” che nasconde l’inspiegabile minaccia del mistero. Una finzione, un castello di finzioni, ma la disperazione per la scomparsa assurda e definitiva della propria casa e di tutto ciò che contiene, cose ma anche affetti, è vera, strazia il cuore e apre un varco nel quale si insinua l’afflato lirico del narratore di razza che ad un tratto depone le sembianze del beffardo parodista: “In questo mondo strapieno, urlante, gesticolante, che razza di vuoto orribile e crescente era quello? In mezzo allo strepito, ai ruggiti infernali, che cos’era quell’atroce silenzio? Gli attimi scavavano uno dietro l’altro il sasso sforacchiato del cuore. Le parole strisciavano via come serpi dagli angoli della bocca. Fuggivano da sotto il macigno del cuore. Le conchiglie degli orecchi si ricoprivano di malerba. Lo scalpitio della scala a chiocciola si spandeva intorno come quello di una mandria infuriata. […] La notte della spossatezza cullerà fino al sonno la disperazione, la paura, la nostalgia, il piagnucolante terrore accucciato in un angolino dell’anima”. Nella malinconia delle quattro del pomeriggio va in scena in queste pagine la potente metafora dello sradicamento, quello dell’ebreo errante, ma anche quello dell’uomo contemporaneo, senza Dio e senza Lucifero. Un mondo così assurdo, anarchico e caotico che, in confronto, il manicomio in cui Raffaele viene rinchiuso è un luogo di riposo: “La follia delle anime era un’isoletta di pace e di silenzio a fronte del terribile mondo dei misteri ingarbugliati, a fronte di un mondo dove spariscono improvvisamente le strade, dove domina la follia dei fatti”. Oppure è il caso della trascinante vicenda che, nel breve volgere di una giornata, il 31 marzo 1921, nel fulgore di una appena nata primavera parigina, coinvolge il serioso e compassato bibliotecario Pierre Moreau, protagonista di “Pesce d’aprile”, spingendolo nel territorio instabile dell’infrazione, nel mistero della mistificazione, a conoscere l’incanto. Perché “cosa sarebbe l’uomo senza l’inganno? L’inganno è l’unica morale accessibile all’uomo, questa bestia in cui si sono intrecciati irresolubilmente tutta la santità del cielo e tutta la malvagità degli inferi”.
Colpisce nella tragica vicenda umana di Wat e nella sua produzione artistica il fatto che i racconti di “Lucifero disoccupato” costituiscano nello stesso tempo un esordio narrativo, ma anche la vigilia di un cupo silenzio creativo durato circa trent’anni. La sua voce, quando si alzerà nuovamente, sarà esclusivamente poetica. In questi anni sarà la storia del suo paese ad infliggere ferite insanabili al suo spirito ed al suo corpo. Wat perde due fratelli, sterminati ad Auschwitz e a Treblinka, viene arrestato dalla polizia staliniana nel 1940, subendo per sei anni una serie di internamenti in carceri speciali, lager e ospedali dai quali alla fine uscirà affetto da una terribile malattia, incurabile e dolorosissima, una malattia-agonia che, nel luglio del 1967 lo porterà al suicidio. Questi racconti sono allora, come afferma Marinelli, la testimonianza della vitale e affascinante giovinezza di Wat, del tempo in cui ancora gli era ignota la geografia dell’agonia: “A parte la vita e la morte (oppure oltre la vita e la morte) esiste una terza condizione: l’agonia, la dissoluzione quotidiana, che progredisce ora lentamente, gradualmente, in modo continuo; ora per sbalzi. Né guerra né pace: la condizione del mondo contemporaneo. Né vita né morte: l’agonia – questa è la mia condizione. E in tal modo risulterà che la mia esistenza (o malattia) è una figura dell’esistenza del mondo contemporaneo? Se così è, allora è giusta l’ipotesi dell’eziologia demoniaca della mia malattia. Se così è, mi si deve curare con gli esorcismi. Demoni. L’agonia – pochi lo sanno – non è uno stretto valico o un ponticello vacillante tra la vita e la morte: l’agonia ha i suoi propri territori, le sue vette e bassipiani, i suoi orizzonti. Descrivere la geografia dell’agonia è tutto ciò che è rimasto a qualcuno da fare, per quanto sia ancora in grado di fare qualcosa”. (da “Diario senza vocali”, pubblicato postumo)
[…] === Sul blog dietroleparole.it/appunti di lettura una interessante ed accurata recensione della raccolta di racconti Lucifero disoccupato di Aleksander Wat, utile per saperne di più di questo intellettuale polacco credo non molto noto in Italia >> […]