JUAN CARLOS ONETTI – Gli addii – SUR
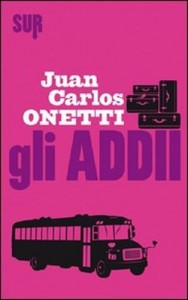 “Quasi senza respirare, guardai la ragazza che chinava il viso sull’insieme inopportuno, furiosamente orizzontale, di scarpe, pantaloni e lenzuola. Rimase immobile, senza lacrime, accigliata, tardando a comprendere quello che io avevo scoperto vari mesi prima, la prima volta che l’uomo era entrato nel mio negozio – non aveva altro che questo e non volle condividerlo – decorosa, eterna, invincibile, mentre si preparava già, senza saperlo, a qualsiasi altra notte futura e violenta”.
“Quasi senza respirare, guardai la ragazza che chinava il viso sull’insieme inopportuno, furiosamente orizzontale, di scarpe, pantaloni e lenzuola. Rimase immobile, senza lacrime, accigliata, tardando a comprendere quello che io avevo scoperto vari mesi prima, la prima volta che l’uomo era entrato nel mio negozio – non aveva altro che questo e non volle condividerlo – decorosa, eterna, invincibile, mentre si preparava già, senza saperlo, a qualsiasi altra notte futura e violenta”.
Come si può percorrere il territorio dell’addio, come farlo assurgere a tema, dotarlo di svolgimento e variazioni, indulgere a soppesare ogni suo estremo passo, sia pure incerto o inconcludente, lungo la strada che conduce verso il suo compimento? Onetti lo fa costruendo, ma sarebbe meglio dire creando, l’affabulazione dell’addio, anzi degli addii, perché in queste pagine quello che si celebra – proprio come in una lenta e soffusa e raccolta cerimonia – è il distacco, da sé, dalla vita, dal passato, dai ricordi, dagli affetti, ma anche dall’infinito e ricorrente trascolorare delle luci e delle stagioni di un mondo che si va spegnendo insieme agli occhi di chi, consapevole, lo osserva. Quasi che affabulare sia l’ultima occasione concessa per sostare, ancora un po’, sul limitare, quasi che costruire una trama, rifinirne o camuffarne i meccanismi, sia un modo per prendersi beffe del tempo, segnato, e del destino, indifferente.
Quanto si addice tutto ciò alla penna di Onetti, alla concentrazione divagante della sua narrazione, condotta sempre all’interno di tempi dilatati da un lirismo discreto, soffuso, ma ammaliante! Quanto è lungo l’addio alla vita di questo uomo, geloso della propria morte annunciata, che non intende condividere e contaminare e che si costruisce il rifugio estremo di un esilio volontario. Un breve romanzo, ma un lunghissimo addio, perché i tempi – e gli spazi – della letteratura si sottraggono, liberi e liberatori, al contingente e si permettono il lusso della dilazione, della reiterazione, della sospensione e, persino, del vuoto e dell’assenza. Onetti si avvicina – e ci avvicina – con grande delicatezza, con tenerezza e pudore, ai passi estremi dell’uomo che muore, lo segue con gli occhi dell’osservatore, io narrante, ma anche schermo e velo, per non accendere una luce troppo cruda sulla sua morte, e non tanto sul dolore della malattia mortale – nel romanzo non ve n’è quasi traccia – quanto sulle ferite crudeli del rimpianto, del rimorso e della nostalgia. Un gioco di schermi regge le lente svolte dell’azione e le conduce verso il compimento. Onetti racconta attraverso gli occhi, i pensieri e le parole di un uomo che racconta, l’osservatore attento, esercitato ad individuare da pochi indizi, nei malati che giungono nel sanatorio del paesino di montagna in cui il romanzo è ambientato, “le loro quote diverse di vergogna e di speranza, d’ipocrisia e di sfida”. Perché con saggezza dolente e disarmata sa che come ognuno fa quello che può per non lasciarsi travolgere dagli avvenimenti della vita, gestendo come può splendori e miserie, così ogni uomo si avvia come può lungo la strada del suo personale e unico addio.
L’osservatore intuisce nei malati “l’importanza che ha per loro quello che hanno lasciato, l’importanza che ha quello che sono venuti a cercare” e confronta “una cosa con l’altra”. E dell’uomo che seguirà fino alla fine, con curiosità, interesse, pena e infine rispetto e forse immedesimazione, individua subito, il suo essere “nemico senza orgoglio della pietà”, la sua “disperazione domata senza sforzo”, una disperazione “a cui si è già abituato, che conosce a memoria”, il suo rifiuto di sottoporsi ad ogni cura, non perché ritenga impossibile farlo, ma perché “non crede nel valore, nell’importanza di curarsi”. Un uomo e la sua resa, dunque, ma una resa affrontata con una tale “dolce e vecchia protervia”, con un’aspra e ossessiva volontà di sostenere fino all’ultimo il proprio ingenuo gioco, che gli dona il piglio e il carattere del vincitore.
Certo non si può evitare di scorgere nello sguardo dell’osservatore – di colui che si sente responsabile del compimento del destino dell’uomo che va celebrando i suoi addii – lo stesso sguardo di Onetti, quella “affettuosa curiosità” con cui egli guarda l’avventura dell’uomo (così Mario Benedetti definisce l’atteggiamento dello scrittore nei confronti della fatalità nel suo saggio in appendice alla presente edizione) mentre costruisce i suoi mondi inventati, i suoi paesi inventati, allevando in un laboratorio di finzione un intero campionario di vera, disillusa e amata umanità. “Mi sentivo investito di un grande potere, come se l’uomo e la ragazza, e anche la donna matura e il bambino, fossero nati dalla mia volontà per vivere ciò che io avevo deciso”, dice l’osservatore, dice Onetti. E quello che lui, l’autore, ha deciso, è la messa in atto di un meccanismo narrativo perfettamente funzionante, con tanto di indizi, anticipazioni, colpi di scena e rivelazioni che, passo dopo passo, conducono ad un inaspettato compimento i cui segnali premonitori sono ben dosati e distribuiti fin dall’inizio della vicenda. Onetti conduce saldamente la sua macchina narrativa che resta però immersa nella bruma labile e indistinta delle motivazioni e dei sentimenti, degli enigmi e degli equivoci, che ne celano i meccanismi, trasformando le cause in ricordi indistinti di tempi lontani e ormai morti e gli effetti in rivelazioni. E così ogni svolta narrativa è un miracolo e ogni espediente un mistero. E così l’uomo che muore diventa capace di attirare a sé più vita di tutta quella che i pettegoli abitanti del paese siano mai stati capaci anche solo di immaginare, attira a sé la passione, l’amore maturo, l’innocenza, la bellezza e la seduzione, e poi, alla fine, si impossessa anche della morte, della sua morte, senza condividerla, come estrema possibilità della vita.