JUAN CARLOS ONETTI – Il cantiere – SUR
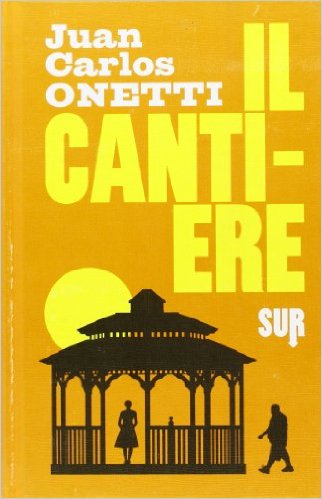 “- Che buco immondo – sputò fuori Larsen; poi scoppiò in un’unica risata, solo tra le quattro lingue di terra che formavano un incrocio, grasso, piccolo e senza meta, curvo contro gli anni che aveva vissuto a Santa Maria, contro il suo ritorno, contro le nuvole basse e compatte, contro la sfortuna”.
“- Che buco immondo – sputò fuori Larsen; poi scoppiò in un’unica risata, solo tra le quattro lingue di terra che formavano un incrocio, grasso, piccolo e senza meta, curvo contro gli anni che aveva vissuto a Santa Maria, contro il suo ritorno, contro le nuvole basse e compatte, contro la sfortuna”.
E’ qui che si compie il destino di Larsen e che termina l’esistenza letteraria del Raccattacadaveri, qui, in un ritorno e nella vaga ipotesi di un nuovo inizio; ma il tempo della fine è un tempo lungo, è il tempo che resta e che va riempito nell’esercizio di “vendette senza importanza”, di “sensualità senza vigore” e di “un dominio narcisista e distratto”. E’ il tempo che occorre ad Onetti per rendere Larsen l’eroe della sua personale leggenda, che di decadenza si nutre e che la decadenza affronta, accettando una sfida già persa in partenza, alla ricerca di un evento definitivo che nulla ha a che fare con il riscatto o con il prestigio sociale, ma che è legato al senso, al senso da dare agli anni affinchè, per quanto possibile, non siano irrimediabilmente morti.
Che strano tipo di eroe è Larsen, quest’uomo lento e dondolante, grasso, basso, anonimo, e ora anche più vecchio e “in apparenza domo” e che strano tipo di inspiegabile legame riesce a creare con il lettore mentre lo trascina a Puerto Astillero, nella inutile desolazione di un abbandono talmente radicato nella terra, nell’acqua e nelle creature che qui trascorrono i loro giorni, da far sembrare Santa Maria, il paese che è di per sé l’altrove in cui muoiono le velleità, il centro vivo di una vita organizzata e plausibile. E da lì, dall’approdo, fra case povere, strade sterrate e fangose, attraverso un paesaggio piatto, fino al luogo potentemente simbolico che regge e motiva l’intero romanzo, attrae il suo protagonista e ne determina il destino: “l’edificio grigio, cubico, eccessivo” del cantiere. E’ un legame che nasce dal tempo trascorso insieme nelle pagine di Onetti, un tempo dilatato da una scrittura che dà il meglio di sé quando sosta senza una qualche apparente motivazione nello “scenario giallognolo e sconsolato” di una vetrina, oppure procede, ma con un ritmo divagante e avvolgente. E’ un legame che nasce per tutta una serie di brevi, accennate, fulminee osservazioni, disseminate qua e là, che riscattano Larsen dalla sua essenza macchiettistica di vecchio imbroglione e sfruttatore di donne e aprono dei varchi attraverso i quali si intravede la verità di una malinconica, malata e lucida umanità.
Il fatto è che quest’uomo trasuda ridicolo ma non si difende, indossa la solitudine senza sottrarsi mai al suo peso, si espone, indifferente, alle parole di disprezzo che sa di poter suscitare, contiene la disperazione non permettendole di travolgere il ritegno, conduce un gioco sottile, quello di credere, un istante dopo l’altro, che il riscatto sia possibile, ancora, che il gioco del destino non abbia ancora concluso l’ultima mano. Larsen gioca, disperato e contenuto, finge con se stesso e ne è consapevole, a tal punto che, quando in mezzo alla desolazione incontra l’estasi, “la tinge di malinconia” e quando avverte la sensazione di un trionfo, sa già che sarà “complicato e inservibile”. Larsen che, lucido, è spaventato dalla lucidità, accetta di essere il protagonista di una farsa perché fuori dalla farsa non c’è altro che “l’inverno, la vecchiaia, il non saper dove andare, persino la possibilità della morte”. E’ così che un cantiere navale dismesso in abbandono e in avanzato disfacimento diventa il presentimento di un’ultima possibilità e insieme simbolo evidente di un definitivo fallimento, del compiersi di un destino. Onetti lo trasforma in un luogo letterario potente e a suo modo affascinante, con i suoi pezzi di ferro imprigionati in un turbinio di fili metallici, le sue ombre, i suoi nidi di polvere e ragnatele, il suo silenzio da cattedrale sotto la pioggia battente, chiuso tra un passato che non è più e un futuro improbabile.
C’è sempre qualcosa di residuale nei romanzi onettiani, la sensazione che i personaggi si muovano nel tempo che rimane, che vivano in carenza, di stimoli, di speranze e di possibilità, sullo slancio del tempo già trascorso, immersi in un “tollerante tedio”, impermeabile all’odio e alla pietà. Irretisce scoprire quanto sia vasto e profondo questo tempo residuale, quanti passi e quante pagine occorrano per percorrere tutti i luoghi su cui incombe, di quanti colori si possano ammantare l’assurdità e la inutilità. Ma Onetti è maestro nel dissodare fino alla estenuazione il terreno che lavora, maestro nella amplificazione e nella replica, maestro nello scavo indolente. Si serve di tutto, frammenta il racconto, varia i punti di vista, chiama in causa, facendoli ricomparire dal passato fittizio di romanzi precedenti, personaggi che riflettono come in uno specchio l’immagine di quel Larsen che si va lentamente componendo nell’immaginario del lettore. E, soprattutto, crea intorno al cantiere una geografia fatta di luoghi ad esso legati, ad esso funzionali, che in qualche modo riproducono e amplificano la sua assurdità, la sua inabitabilità: il bersò, la casupola, la bettola del Chamamè. Ma in fondo è da “La vita breve”, dalla nascita di Santa Maria, che Onetti si esercita nella creazione di luoghi plausibili, dove abitano i fantasmi attraverso i quali si rivela il suo pensiero sulla vita, la perplessità attraverso la quale guarda alla vita.
Il bersò è la terra di conquista, il palcoscenico su cui recitare la farsa della seduzione per impadronirsi di un ruolo e di un potere fittizi. La casupola, sordida e cadente, è il luogo più simile ad un focolare domestico che Larsen abbia mai conosciuto, ma mostra senza ritegno tutto il suo disarmante squallore e per di più appartiene ad un altro, un altro inconcludente fantasma, e lo sforzo per impadronirsene è al di là di ogni plausibile immaginazione. E la bettola è l’inferno: “Larsen vi entrò un sabato con Kunz e non andò oltre il bancone. Esaminò le donne con una specie di terrorizzata fascinazione e forse pensò che un dio avrebbe potuto sostituire l’inferno universale e fiammeggiante che si immagina di solito con piccoli inferni individuali. E forse pensò che un Chamamè bloccato alla mezzanotte del sabato, senza pausa, senza musicisti mortali che all’alba staccavano per chiedere delle uova fritte con una bistecca, era l’inferno che gli era destinato fin dal principio dei tempi, o che lui si era pian piano guadagnato, a seconda dei punti di vista”. Larsen abita e percorre le quinte su cui deve rappresentare l’evento definitivo del suo riscatto, per dare “un senso agli anni morti”, e non può che muoversi come ha sempre fatto, inventandosi qualche forma di passione, approfittando della sua naturale propensione per le bravate.
Vittime del suo gioco, ma anche complici e comprimarie sono le donne, perché Raccattacadaveri, l’alter ego di Larsen, è un esperto conoscitore dei loro intimi desideri e della loro natura, o almeno è convinto di esserlo: “Non ci sono mai state donne ma una sola donna che si ripeteva, che si ripeteva sempre nello stesso modo. E i modi possibili erano pochi e non potevano prendermi alla sprovvista. Così tutto, dal primo ballo in una sala di periferia fino alla fine, è stato dolce, in discesa, e io non ho dovuto metterci altro che tempo e pazienza”. Le donne onettiane sono magnifiche, mentre reggono un gioco di cui non sono consapevoli, esemplari tipici di quella intima regalità che è il loro tratto distintivo; e non importa se sono vecchie prostitute consumate dal tempo, o poveracce che campano la vita tenendola stretta tra i denti, oppure folli per un difetto di nascita o per i postumi di un dolore troppo forte da sopportare. Sono regali perché imprimono la loro impronta sul mondo che abitano, lo possiedono e lo dominano, e se nel loro mondo compare Larsen, in un modo o nell’altro se ne impadroniscono e ne riempiono i pensieri. E’ così per la giovane donna della casupola. “brutta, spettinata e gialla”, ma per lui “più temibile che mai, segreta, intoccabile”, e per Angelica Ines, la figlia del proprietario del cantiere, “unica, idiota, zitella”, una preda apparentemente facile da conquistare, in grado però, nella sua incomprensibile demenza, di irretire Larsen nei lacci di una ritualità che lo imprigiona nel bersò, impedendogli l’accesso alla villa, luogo simbolico del potere.
Ed è così anche per Josefina, la serva e custode di Angelica, acuta e sapiente che accompagna il gioco della seduzione fino al punto di mettersene lei stessa alla guida e di costringere Larsen a riconoscere la loro fratellanza della carne, la loro provenienza da una stessa terra natale e di concedergli di fiutare tramite lei l’aria dell’origine prima di morire: “Lì c’erano, di nuovo, il letto di metallo con le sbarre allentate che avrebbero tintinnato per le spinte; il catino e la sua brocca, di ceramica verde, che gonfiava i rilievi delle ampie foglie acquatiche; lo specchio circondato da un tulle rigido e ingiallito; le immaginette di santi e madonne, le fotografie di comici e cantanti, l’ingrandimento a matita, in una spessa cornice ovale, di una vecchia morta. E l’odore, la mescolanza che non avrebbe mai potuto essere eliminata, di chiuso, donna, fritto, ciprie e profumi, del taglio di stoffa a buon mercato conservato nell’armadio”. E’ dopo questa notte con la donna che Larsen inizia a morire e Onetti regala al personaggio di cui per tanto tempo si è servito una fine epica – perché annunciata da lontano, raggiunta con lentezza, attraverso movimenti rituali degni di un vero eroe – ma nello stesso tempo infinitamente affettuosa e dolce, nell’incontro con quella perfetta solitudine “che aveva tante volte immaginato, e quasi desiderato, in anni remoti”.
È sempre un piacere leggerti ma ancor più è attendere ogni volta quella consonanza del sentire che sempre mi stupisce. Grazie e scusa per questo commento poco “letterario”
Incontrare consonanze sulla strada della letteratura è sempre una consolazione. Quindi sono io che ti ringrazio. Anche per le magnifiche pagine che continuamente proponi, che parlano alla testa e al cuore.