GIORGIO MANGANELLI – Tragedie da leggere – Bompiani
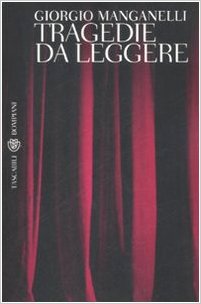 “Lasciatemi il mio nulla. Non c’è donna, né vino, né cibo, né figlio, né sangue di nipote, non c’è lussuria, vendetta, placata gola, fasto di vestiti, gloria di re, massacro di eserciti che abbia più luce e durata e forza del mio nulla… Ti lascio il sangue del mio nemico, ti regalo la verginità di mia figlia, mi faccio mezzana della sposa in bianco, ma non insidiare questo bambino d’oro, questa femminuccia che brilla, questo niente duro e compatto… Chi vuole futuro? Chi vuole cosa diversa dalla solitudine? Morire senza amici, senza servi, senza figli, nella casa sprangata, che il fantasma possa gustare ancora, totalmente invisibile eccetto ad altri fantasmi invidiosi, quel mio nulla segreto…”.
“Lasciatemi il mio nulla. Non c’è donna, né vino, né cibo, né figlio, né sangue di nipote, non c’è lussuria, vendetta, placata gola, fasto di vestiti, gloria di re, massacro di eserciti che abbia più luce e durata e forza del mio nulla… Ti lascio il sangue del mio nemico, ti regalo la verginità di mia figlia, mi faccio mezzana della sposa in bianco, ma non insidiare questo bambino d’oro, questa femminuccia che brilla, questo niente duro e compatto… Chi vuole futuro? Chi vuole cosa diversa dalla solitudine? Morire senza amici, senza servi, senza figli, nella casa sprangata, che il fantasma possa gustare ancora, totalmente invisibile eccetto ad altri fantasmi invidiosi, quel mio nulla segreto…”.
La voce del Don Giovanni manganelliano è una delle tante che, poderose e incalzanti, risuonano su questo palcoscenico così volatile e impreciso, luogo di parole che per la loro stessa forza si fanno figure, figure e attori, astrazioni che si fanno carne, impegnate nello sforzo di creare ciò che per sua natura attiene all’inafferrabilità, all’astrazione e alla menzogna. La parola finge di essere tangibile per creare il teatro che finge di essere realtà. Da una finzione all’altra, la parola dal nulla chiamata al nulla ritorna. Nel tragitto si allarga lo spazio scenico, transitorio, metamorfico, sfuggente, che si disfa e si ricrea sotto gli occhi del lettore-spettatore, invenzione mirabile, oppure provocatoria e dissacrante, oppure persino un poco sordida che comunque sa come agire, come attrarre a sé e come permanere: “Voi uscirete di qui colti, pensosi, litigiosi, uxoricidi, figli ribelli, mogli adultere, ufficiali dimissionari; in ogni modo migliori”. Perché non c’è gioco che come la finzione sappia irretire e la finzione manganelliana si dispiega all’ennesima potenza.
Manganelli lavora una materia così eterea e sfuggente che sembrerebbe disperata l’impresa di trattenerla, dissezionarla, plasmarla e poi spingerla con forza alla ribalta di una scena altrettanto lontana dalla salda concretezza di ciò che è tangibile e percorribile. Innamorato dei meandri del pensiero che affonda nella razionalità straniante, frantumata nei suoi meccanismi più vertiginosi e disperanti, e innalzata nel debordare di una immaginazione ardita e di se stessa divertita, Manganelli drammaturgo passeggia nei labirinti di un suo personale atto creatore che attiene più all’incantesimo che alla genesi, ma che anch’esso si affida all’unico insostituibile strumento della parola. Il verbo creatore diventa qui “incantesimo nominale” – così lo definisce Luca Scarlini nell’introduzione al volume – che dà voce ad anime e destini, gioca con loro, li esalta e li stravolge, li irride e ci irride, di volta in volta caustico o bonario, li conduce e ci conduce al massimo grado dell’intensità emozionale, senza mai distrarre a tal punto che non sia però ben avvertibile il nulla metafisico, origine e fine di tutto l’intenso brulicare di commedie e tragedie che occupa il tempo della finzione, teatrale e non.
C’è qualcosa nella parola di Manganelli che rende possibile tutto ciò – i lettori della sua prosa lo sanno bene – ed è la sua straordinaria plasticità, che la rende non solo bastevole a se stessa, ma anche in grado di costruire intorno a sé architetture, di abitarle e di agire in esse. Basterebbe pensare all’inferno manganelliano, o alla sua palude definitiva, luoghi inesistenti, irreali e impossibili, ai quali la parola dona spessore e profondità, dimensioni insomma plausibili, in un modo che è altro rispetto allo spazio da noi esperito, ma altrettanto misurabile seppure con altri metri. Tale è il suo palcoscenico, pronto a “tutti gli abietti giochi della retorica teatrale”, luogo privilegiato atto ad accogliere la sua idea di teatro, quella che lui stesso definisce “perplessa e tuttavia eccitante; un sistema di diffidenze, irritazioni e imprecise speranze”. C’è un che di allucinatorio nell’apparizione su una tale scena delle parvenze più o meno identificabili che fungono da attori di questi drammi, una allucinazione che erompe con la forza e l’intensità di una apparizione sbalzata all’attenzione dello spettatore-lettore da un fondo buio. Le parole erompono, eloquenti, divertite, cerimoniose, sconsolatamente liriche, da un’oscurità alla quale ritornano: “All’apertura del sipario, il palcoscenico appare completamente buio: è destinato a restare tale per l’intera rappresentazione. Occorre pertanto che all’inizio e alla fine il rumore del sipario che si apre o chiude sia assolutamente inequivoco. […] Nessun rumore di fondo, nessun effetto speciale di qualsivoglia genere durante l’intera rappresentazione: nient’altro che le voci”. Sono indicazioni sceniche che l’autore premette ad un suo “Monodialogo”, uno dei pezzi che meno concedono al pubblico al quale, in questo caso, è richiesto il minimo livello di partecipazione, anche lui coinvolto nell’inesistenza, fatta oggetto di una sorta di dialogo teologico.
Manganelli estremizza, destruttura i suoi personaggi sino a ridurli a numeri, o a lettere dell’alfabeto che nulla possiedono tranne la voce e che unicamente ad essa devono fare affidamento per affermare un sé altrimenti inesistente. Nemico dell’istrionismo, persino nemico dell’attore – “Non amo, diffido di, disamo, ho in uggia, in dispetto, detesto il teatro agonistacentrico, inventato per il grande attore, colui che strappa l’applauso a scena aperta…” – il suo teatro fiorisce su una valenza letteraria, il suo teatro si legge, così come la sua prosa si mette naturalmente in scena nella testa del lettore. Non necessita di istrioni o di primi attori Manganelli drammaturgo, perché il vero istrione è lui e in questa accattivante contaminazione di generi – come non considerare altissima narrazione anche quella dei suoi saggi critici? – che attende chi si inoltra nella produzione di questo grandissimo scrittore italiano, è nel bel mezzo de “La palude definitiva” che egli lo afferma chiaramente: “Ed ora, scoprendomi ricolmo di monologhi e di battute, io non posso non parlare, non solo, ma soprattutto non posso non sapermi coinvolto in storie non meno allucinatorie che affascinanti.
Ma chi sono i fantasmi che sostano sulle soglie del mio corpo, e che mi si propongono come interlocutori a vario titolo, assassini, donne amorose, avvelenatori ai miei ordini, tiranni e spie?”. Questi fantasmi sono Amleto, Ofelia, Edipo, Giocasta, Gesù, la Maddalena, Otello, Desdemona, Cassio, Jago, Don Giovanni, perché Manganelli estremizza ma, anche concede, anzi si concede al lettore-spettatore regalandogli la soddisfazione di una sorta di riconoscimento culturale. Presuppone vicende, anima i suoi personaggi in un momento che è oltre il dramma, chiama le loro voci ad un eloquio purificato e pensoso, ben lontano dalla banale attualizzazione, che oltrepassa in profondità, anzi che vanifica, ogni trama, che diventa solo pura contingenza. La tragedia ha reso tutti loro figure, la loro storia si è compiuta e il drammaturgo può, a suo piacimento, creare per loro una situazione grottesca e aprire in essa spazi in cui la loro voce monologante possa elevarsi a dire ciò che hanno sentito una volta sulla propria pelle e che ora sanno per sempre.
Così, per esempio, Edipo sa il male del mondo: “Talora accade che un gesto umano venga vissuto dagli animali, dalle nuvole, dai sassi, come una malattia. O forse noi uomini siamo il virus della malattia, siamo la febbre, la peste, talora nascosta, un pus quotidiano, una infezione lenta; e in certi momenti deputati noi esplodiamo come la grande, irreparabile malattia dell’universo. Una nostra menzogna fa esplodere un vulcano che a stento si tratteneva, un omicidio isterilisce le vigne di una collina, la percossa di un bambino ad un cane fa spaccare di dolore, di furore, di terrore tutto il fianco di una montagna che, ingravidata da quel gesto feroce e casuale, partorisce istantaneamente sassi desolati e rocce lamentose. Il nostro incesto uccise i feti nel ventre degli animali, e spense le linfe delle piante”. Ofelia sa la pazzia: “Ma forse straparlo, io non sono del tutto mondata dai miei deliri, mi piace sempre, da allora, oscillare sull’altalena di un leggero delirio, oh niente di ambizioso, una filastrocca con nomi di fiori, di erbe, di villaggi isolati, di preti apostati, di vecchi libri, di ragazzi mai dimenticati, dei miei nomi alternativi… Ofelia, Amelia, Aurelia, Cornelia, Ilaria… E’ una cosa abbastanza infantile, vero? Ma che pazzia volete mai che sia la mia? Una cosa povera, incolta, blesa, una demenza improvvisata, per andare incontro ad una morte di stracci, una bambola deforme e innocua…”. Don Giovanni sa l’immoralità: “Una giarrettiera sconfigge i cieli. Il diavolo paventa l’acquasanta, ma Iddio trema come un giunco davanti ad un profumo paesano, uno scialle da mercato suburbano. Mi dicono che un angelo custode sviene di fronte a un reggiseno, ad una scatola di cipria, ad un ricciolo posticcio. Io non ho angelo custode. Non avendo anima, non avendo peccati, non temendo Inferno né tremando per un posto in Paradiso, io sono un mostro, un errore, una cosa impossibile”. E Jago sa la menzogna: “Ma mentire, signore, mentire fino a morirne! Nascere in un’agonia di menzogne, mentire una vita, amare, disamare amati mentendo, mentire a vita, mentire a sangue, mentire a morte, morti mentire. Il mentitore Jago dichiara che Jago è mentitore. Chiaro, vero? E Lei, mi consenta, di tutto ciò che sa, che capisce?”. Parvenze, perché fuori dalla loro tragedia tutti loro non esistono, svaniscono come le loro parole, al calare del sipario. Ma nel teatro della palude definitiva, nella notte teatrale densa di monologhi, l’innamorato sfiduciato e furioso proclama: “Oh, amare ciò che non esiste, che sa di non esistere, che sa che noi sappiamo che non esiste, oh quale stremante dolcezza!”.
adoro Manganelli come un altro me stesso, ma purtroppo non sono io. Ciao Anna!
Ciao Giovanni, eppure un po’ della luminosa polvere di questi amati libri resterà addosso no?
resta, resta… 🙂