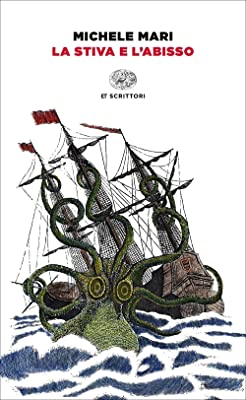“.. finchè navigo voglio solo navigare, essere una cosa sola con il fasciame e l’alberatura velata, vibrare come una gomena tesa, impregnarmi di mare come le vele di fiocco, quando le onde son prese di punta e la schiuma sormonta il bompresso, sì, voglio essere pura voce imperiosa, ‘Molla tutto!’, ‘Inverti la barra!’, puro flatus nell’orror tenebroso della tempesta, fatto della stessa sostanza degli schiocchi dei paranchi e del rimbombante muggito del mare…”
Tutti, credo, abbiamo iniziato a leggere per soddisfare un bisogno di avventura, che andasse oltre a quella che i giorni ci riservavano o che da soli avremmo potuto immaginare, desiderare o temere. Ce ne siamo nutriti e appassionati fino a che l’avventura è diventata una metafora della vita e abbiamo continuato a cercarla nei libri, a svelare i suoi camuffamenti, ad individuare le sue diverse facce, scoprendo che poteva travalicare le trame, liberarsi dai loro lacci, annidarsi nelle parole, nelle loro forme e strutture, diventando così inesauribile e inimmaginabile. Gli scrittori veri sono legati a doppio filo con l’avventura della parola, di tutte le sue forme e sfumature, del loro modo di ricreare ogni volta il mondo, sono degli avventurieri e leggerli significa seguirli, inoltrarsi con loro verso l’ignoto, spesso senza punti di riferimento. Si può fingere che sia solo un gioco, ma nessun trastullo o passatempo ha a che fare con il nostro bisogno di conoscenza o, come dice Stig Dagerman, nel titolo del suo bellissimo libro, di consolazione.
In questo senso Michele Mari è il principe degli avventurieri, non solo perchè ha riempito la sua letteratura di quello che fin dalle sue origini di lettore lo aveva entusiasmato e tenuto avvinto alle pagine, ma anche e soprattutto perchè ha trasfigurato tutto ciò contaminandolo con quel mondo delle lettere di cui è un inesausto esploratore, l’ha contaminato con tutti gli espedienti che la retorica gli mette a disposizione, ha forzato la lingua obbligandola ad utilizzare parole ed espressioni desuete ma piene di fascino e di molteplicità di significati. Ha riempito le sue pagine di labirinti in cui ci si inoltra pieni di incertezza e di stupore, di dubbi interpretativi, di reminiscenze e di consonanze, afferrando frammenti affascinanti e perdendo, quando si crede di averlo compreso, il senso dell’insieme, per poi ritrovarlo, ipotizzare, costretti a ritornare su pagine già lette e riscoprire così la loro bellezza.
“La stiva e l’abisso”, il terzo romanzo di Mari, pubblicato nel 1992 dopo “Di bestia in bestia” e “Io venìa pien d’angoscia a rimirarti”, è prima di tutto un omaggio a quegli scrittori a cui l’autore deve, per sua stessa ammissione, il merito di averlo introdotto nello splendido gioco della letteratura, di averlo avvinto con i loro racconti fin dalla sua più tenera età, appassionandolo con le loro trame e rendendolo per sempre incline a ritenere la narrazione molto più di un mero susseguirsi di avvenimenti e di colpi di scena, introducendolo fin d’allora a quel gusto per l’affabulazione che caratterizza tutta la sua ricca e varia produzione.
Nel racconto intitolato “Otto scrittori”, contenuto nella raccolta “Tu, sanguinosa infanzia”, essi vengono espressamente citati e messi a confronto, anzi vengono coinvolti in una sorta di gioco antagonistico, di sfida all’ultima pagina, al fine di individuare chi tra di loro possa definirsi il perfetto scrittore di mare. Si tratta di Joseph Conrad, Daniel Defoe, Jack London, Herman Melville, Edgar Allan Poe, Emilio Salgari, Robert Louis Stevenson e Giulio Verne. L’incipit del racconto rende perfettamente l’idea di quale sia l’origine de “La stiva e l’abisso”, da quale fascinazione nasca la sua ambientazione e a quale sia l’humus in cui affonda le sue radici: “C’erano una volta otto scrittori che erano lo stesso scrittore. Tutti scrivevano del mare e delle sue tremende avventure, tutti usavano parole meravigliose come bastingaggio e bompresso, tutti conoscevano le geografia più lontana, i venti, le faune, le flore, le costellazioni, il computo della posizione, da quella conoscenza ricavando profondissimi affanni; mi facevano ardere della stessa sete e dello stesso delirio, rabbrividire per la stessa tempesta, sprofondare nello stesso identico flutto..”
Il mare dunque, che è l’abisso insondabile che terrorizza e attira nello stesso tempo, e la nave, che nella stiva racchiude ciò che motiva il viaggio, ma anche ciò che dovrebbe garantire la sopravvivenza sopra acque perigliose. La stiva e l’abisso: tutto si compie in uno spazio conchiuso ed esiguo in balia dell’infinita e ingovernabile distesa delle acque. Entro questi confini si dipana una narrazione che sotto molteplici aspetti è totalmente lontana da tutto ciò che il lettore si aspetterebbe, anche se è evidente il suo debito alla letteratura d’avventura di mare ottocentesca. Ma Michele Mari è un contaminatore e riesce a condurre i suoi fili narrativi intrecciandoli e piegandoli a registri a prima vista imprevedibili e comunque alieni al genere a cui il romanzo dovrebbe appartenere.
Una nave secentesca, presumibilmente spagnola, che non naviga – “un vecchio galeone da guerra riattato al commercio, con gli sportelli dei cannoni sigillati di pece e i ponti scorciati” – irrimediabilmente bloccata da una bonaccia ostinata; un capitano,“Torquemada”, sempre meno in grado di comandare, bloccato nella sua cabina da una cancrena alla gamba che gli sta lentamente divorando il corpo – “La gangrena sembra immobile, ma io so che dilaga. La sento arricchirsi, divenire di giorno in giorno più infetta, come un animale che s’aggomitoli per spiccare meglio il suo balzo. A volte giurerei che mediti: in che direzione estendersi, in quanto tempo, con quali sintomi. Il bruciore va e viene, con punte lancinanti: in sua assenza lascia sempre, come un fido luogotenente, un pizzicore diffuso. La pelle, che fino a una settimana fa era ricoperta di bolle e di vesciche piene di siero, sembra ora asciugarsi, e già in qualche punto si crepa: la diminuzione dello spurgo, mi pare chiaro, denuncia un aggravarsi del male.” – una ciurma composta da marinai inappetenti, esangui, languenti e moribondi, divorati dallo scorbuto e da una misteriosa malattia dell’anima, che pure sembrano contenti – “.. la vitalità dei miei uomini è andata spegnendosi. Tutto questo silenzio è innaturale. Innaturale e impressionante. [..] nessuno gioca più, gli uomini giacciono abulici, buttati dove capita; alcuni sembrano dormire, altri hanno lo sguardo perduto nel vuoto, come spiritati: altri ancora parlottano per conto loro, come recitassero il rosario. Che siano malati? Se è così, d’un morbo sconosciuto” – un ufficiale al sestante, “Torriani”, perso nei suoi calcoli e nella progettazione di un misterioso ordigno – “Ho progettato uno strumento di esplorazione, e l’ho chiamato Batispecola [..]. Grazie alla Batispecola, che mi porterà in fondo all’abisso, vedrò. Non chiedetemi cosa: ma so che se le malie che ci avvolgono hanno una scaturigine, è là sotto che bisogna cercarla” –
La stasi incombe anche sulla narrazione che si frantuma, affidandosi ai monologhi del capitano – riflessioni, pensieri, ipotesi, che a volte prendono la forma di un diario di bordo che in realtà non viene scritto – ai suoi dialoghi sempre più inconcludenti con l’ufficiale in seconda, “Menzio”, alle conversazioni dei marinai, uomini rudi che mentre languono in uno stato di sognante benessere, man mano che la loro morte si avvicina acquisiscono intelletto, capacità di ragionamento, sensibilità e persino umana solidarietà, cosicchè, mentre il loro fisico decade, il loro spirito si eleva.
E’ attingendo alla tradizione della letteratura fantastica, alla zoologia fantastica, che Mari riesce a dare a questo materiale quella profondità e quella letterarietà che trasforma il romanzo di mare in una avventura di tipo diverso, un’avventura che si inoltra nel potere della parola e della affabulazione, di allargare la realtà, di farla permanere, o di farsi essa stessa mondo. Perchè i “facitori di fole”, gli esseri che salgono dal profondo e intrattengono con i marinai un rapporto intimo di vicinanza fisica e mentale, che raccontano loro le vite tristi o liete degli uomini annegati nel passato, comunicando attraverso vibrazioni e sfioramenti, e che li attirano nelle profondità del mare per impadronirsi delle loro storie per poi continuare a ripeterle all’infinito, sono una versione metaletteraria delle sirene omeriche. Certo non nell’aspetto – “Mi chiedo a quale specie possa appartenere un pesce così. Le dimensioni sono quelle di un tonnetto giovane, ma la forma ricorda piuttosto un cetaceo, come un capodoglio in miniatura con il muso dell’orca.. La coda invece, pur essendo incomparabilmente più elegante, richiama alla mente quella dei gaudiosi: quanto alle fruste, alle creste, alle frange e agli stessi colori, non c’è nulla nel popol dei pesci che vi assomigli, e solo nel regno dei fiori si posson trovare simili forme e simili tinte.” – sebbene anche in questo caso si instauri un legame erotico tra uomini e animali marini che rende addirittura vitale, sia dal punto di vista fisico che mentale il bisogno di continuare ad ascoltare le storie e di sapere come si concludono.
Questi esseri – dono meraviglioso del mare ma anche mostri pericolosi che distolgono gli uomini dalla vita reale – sono in realtà simboli del valore vitale dell’affabulazione, del bisogno di riempire il tempo a noi concesso di trame, del valore metafisico dell’arte di raccontare, simboli che Mari inserisce nel suo racconto trasformandolo in un racconto al quadrato, in un bellissimo delirio di senso, di immagini e di parole: “E’ anche vero, però, che raccontarsi storie e storie su storie significa essere pazzi. Non è forse pazzia, un’ininterrotta vertigine favolosa, un delirante pascolo di forme che vogliono essere il mondo, che vogliono essere il Paradiso e l’Inferno? Sì, è pazzia, ma d’altronde, che favola è quella che s’affianca docile e inerte a questa nostra vita, che t’avverte prudente: attento, sono una favola, assaggiami e via, passa oltre, io qui peraltro finisco, ritorno la nebbiolina che fui, che favola è questa mi chiedo, che non ne genera altre con la collaborazione del tuo sangue già infetto, del tuo sangue ormai favoloso?”.