Traduzione di Silvia Cecchini
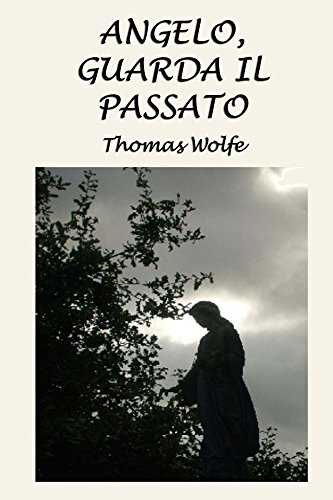
“E non piangeva per se stessa, ma per lui: nell’ora subito dopo la sua nascita ella aveva guardato nei suoi occhi scuri e aveva visto qualcosa che sarebbe rimasto là per sempre, lo sapeva, il pozzo indicibile di una solitudine remota e intangibile: ella sapeva che nel suo utero scuro e pieno di dolore era venuto alla vita uno straniero, nutrito dai contatti perduti con l’eternità, fantasma di se stesso, incubo della sua stessa casa, straniero per sé e per il mondo. O, perduto!”
In un piccolo e prezioso libro costituito da una lunga conversazione tra Thomas Bernhard e Peter Hamm, dal titolo “Una conversazione notturna” (uscito recentemente presso le edizioni “Portatori d’acqua”, tradotto da Elsbeth Gut Bozzetti, curato da Micaela Latini e Mauro Maraschi), il grande autore e drammaturgo austriaco rivela, tra le tante altre cose, che una delle sue prime esperienze di lettura significative è stata il romanzo di Wolfe (“Ma è stato con Thomas Wolfe che mi sono reso autonomo come lettore, è stato lui il primo ad affascinarmi davvero”), da lui definito “grandioso”, l’opera di un autore “incredibilmente vitale, giovane e intelligente […] che sulla carta era un tornado”. Proprio la vitalità sembra essere la qualità maggiormente apprezzata da Bernhard in un’opera letteraria: “La maniera in cui qualcuno è in grado di riversare compiutamente sulla carta ciò che sono un uomo e il suo mondo in termini di vitalità. Senza indebolirla in alcun modo. La maggior parte degli autori non scrive niente di vitale o di vivo”. Il lettore è in grado di cogliere la vitalità di un’opera perché si sente felicemente aggredito e travolto da qualcosa che avverte come assolutamente nuovo e sorprendente, in un certo modo avventuroso, perché si sente partecipe di un’avventura che poco ha a che fare con qualsiasi tipo di trama, ma che attiene invece ai lineamenti di uno stile unico, di un unico modo di avvertire e di soddisfare il proprio bisogno di espressione, di scegliere e gestire i propri tempi, di rivelare, celare, riproporre sotto forme diverse, l’essenziale, che sfugge e attrae e che ha bisogno della scrittura, ma di quell’unico tipo di scrittura.
Wolfe è un tornado e il suo romanzo non potrebbe essere più lontano dalla prosa bernhardiana, dalla musicalità delle sue fughe sintattiche, dalle sue costruzioni razionali che corteggiano l’ossessione e la follia, eppure tra le sue pagine si avverte la stessa energia inesauribile, la stessa incapacità di aderire a modelli precostituiti di sicuro effetto, la stessa intransigenza nei confronti della debolezza di chi scrive per diletto e per ottenere consenso. Sono autori che non scrivono per compiacere il lettore, scrivono perchè non ne possono fare a meno, si potrebbe dire che sono ciò che scrivono, “si riversano sulla carta” per usare l’espressione bernhardiana e proprio per questo in un primo momento lasciano il lettore interdetto e conquistano solo chi possiede la perseveranza e forse almeno un pizzico della stessa vitalità. Ma, quando si rivelano, restano indimenticabili.
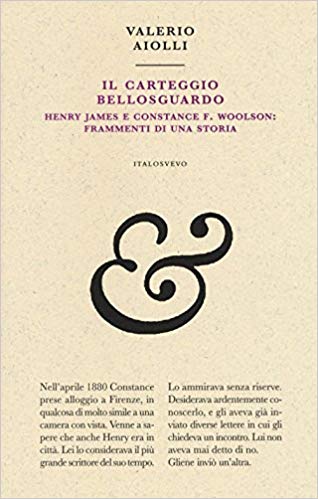
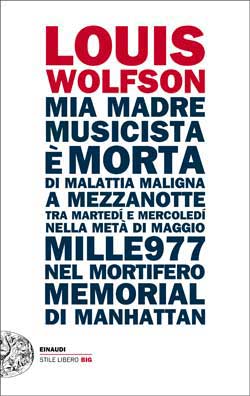
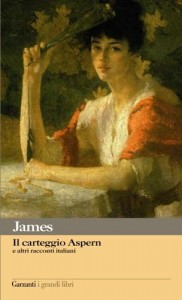
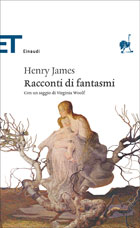 I lettori di Henry James sanno bene che tutto ciò che egli scrive ha in fondo a che fare con i fantasmi, perché la sua tecnica letteraria evita accuratamente di fornire spiegazioni razionali e avviluppa lentamente in luci ed atmosfere colme di tutto ciò che si può tentare di percepire, tutto tranne la rassicurante chiarezza della logica. I suoi racconti sono prodigi dell’immaginazione che prendono forma grazie all’arte del narratore; i suoi racconti sono prodighi di trame che prendono forma e vita, ma una forma rarefatta e indistinta, riservata a chi, per un momento, è in grado di coglierla: un’apparizione insomma. Se questo è vero, allora i fantasmi che compaiono nei racconti compresi nella presente raccolta sono fantasmi al quadrato, le creature più appariscenti di James.
I lettori di Henry James sanno bene che tutto ciò che egli scrive ha in fondo a che fare con i fantasmi, perché la sua tecnica letteraria evita accuratamente di fornire spiegazioni razionali e avviluppa lentamente in luci ed atmosfere colme di tutto ciò che si può tentare di percepire, tutto tranne la rassicurante chiarezza della logica. I suoi racconti sono prodigi dell’immaginazione che prendono forma grazie all’arte del narratore; i suoi racconti sono prodighi di trame che prendono forma e vita, ma una forma rarefatta e indistinta, riservata a chi, per un momento, è in grado di coglierla: un’apparizione insomma. Se questo è vero, allora i fantasmi che compaiono nei racconti compresi nella presente raccolta sono fantasmi al quadrato, le creature più appariscenti di James.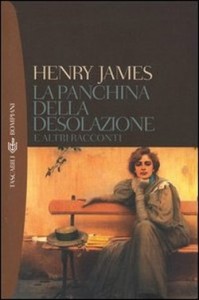 “E’ veramente gloria essere stati messi alla prova, aver avuto la propria piccola forza, aver gustato il proprio piccolo incanto. Quello che conta è aver fatto vibrare qualcuno”.
“E’ veramente gloria essere stati messi alla prova, aver avuto la propria piccola forza, aver gustato il proprio piccolo incanto. Quello che conta è aver fatto vibrare qualcuno”. Un’incursione nella letteratura americana contemporanea, un breve soggiorno in un territorio che non è il mio, l’incontro con una scrittura nitida, cristallina e sorprendentemente onesta. Dieci racconti brevi, nei quali è racchiuso un paesaggio, che diventa immediatamente familiare, ed entro i quali si muovono personaggi che non sembrano aver bisogno di una riga in più per manifestare la loro essenza. Richard Ford mi ha riservato parecchie sorprese, prima fra tutte quella di uno stile che permette al lettore di entrare con facilità nel suo mondo letterario, cosa per nulla semplice né scontata. Ci si accorge presto leggendo questi racconti che i loro incipit, diretti, essenziali, quasi affrettati, hanno lo scopo di preparare il terreno, di disegnare delle coordinate, di delineare il quadro generale di una situazione che, nel corso del racconto, in un modo o nell’altro, subirà un mutamento decisivo e che proprio su questo mutamento l’autore vuole che il lettore si soffermi. Come, d’altra parte, ci si abitua presto ad individuare il punto in cui, in ogni racconto, la penna di Ford rallenta fino alla sospensione, si impadronisce di un piccolo squarcio di realtà, di un particolare in apparenza insignificante, e lo trasforma in qualcosa di prezioso, lirico e persino commovente.
Un’incursione nella letteratura americana contemporanea, un breve soggiorno in un territorio che non è il mio, l’incontro con una scrittura nitida, cristallina e sorprendentemente onesta. Dieci racconti brevi, nei quali è racchiuso un paesaggio, che diventa immediatamente familiare, ed entro i quali si muovono personaggi che non sembrano aver bisogno di una riga in più per manifestare la loro essenza. Richard Ford mi ha riservato parecchie sorprese, prima fra tutte quella di uno stile che permette al lettore di entrare con facilità nel suo mondo letterario, cosa per nulla semplice né scontata. Ci si accorge presto leggendo questi racconti che i loro incipit, diretti, essenziali, quasi affrettati, hanno lo scopo di preparare il terreno, di disegnare delle coordinate, di delineare il quadro generale di una situazione che, nel corso del racconto, in un modo o nell’altro, subirà un mutamento decisivo e che proprio su questo mutamento l’autore vuole che il lettore si soffermi. Come, d’altra parte, ci si abitua presto ad individuare il punto in cui, in ogni racconto, la penna di Ford rallenta fino alla sospensione, si impadronisce di un piccolo squarcio di realtà, di un particolare in apparenza insignificante, e lo trasforma in qualcosa di prezioso, lirico e persino commovente. “Benito Cereno” è il racconto che pone termine al decennio creativo di Melville e che prelude al lungo mutismo letterario che continuerà fino alla sua morte, fatta eccezione per la novella “Billy Budd”, composta qualche mese prima della fine. Solo quattro anni separano “Benito Cereno” da “Moby Dick” e Melville condensa qui, in poche pagine, la ricchezza di uno stile sempre più evocativo, basato su simboli e corrispondenze, nell’intento di sondare, ma anche di trasfigurare, i dati della realtà sensibile. E’ inevitabile leggere questo racconto avendo come pietra di paragone “Moby Dick” o, almeno, ricordandone la peculiare caratteristica, quel suo tono mistico di predicazione sacra, che trasfigura la storia di mare in una lotta epica tra bene e male, anzi, nella lotta tra due potenze contrapposte, fatta di vendetta, accanimento, di morbosità, il tutto sostenuto da uno stile di scrittura che si fa a tratti apocalittico. Dopo “Moby Dick”, le storie di mare di Melville non possono trovare il lettore impreparato, dopo “Moby Dick” è chiaro che l’avventura è sporgersi su un abisso, perché, come dice Michele Mari ne “I demoni e la pasta sfoglia”, “Melville sapeva che non c’è conflitto che non renda uguali al nemico, non c’è abisso in cui si possa guardare impunemente”. E quindi, chi si appresta a leggere “Benito Cereno” non si faccia ingannare dall’incipit, classico esordio che sembra preludere ad un canonico racconto di mare, perfettamente in linea con la tradizione ottocentesca, perché bastano poche pagine e ci si ritrova in piena bonaccia, reale e metaforica.
“Benito Cereno” è il racconto che pone termine al decennio creativo di Melville e che prelude al lungo mutismo letterario che continuerà fino alla sua morte, fatta eccezione per la novella “Billy Budd”, composta qualche mese prima della fine. Solo quattro anni separano “Benito Cereno” da “Moby Dick” e Melville condensa qui, in poche pagine, la ricchezza di uno stile sempre più evocativo, basato su simboli e corrispondenze, nell’intento di sondare, ma anche di trasfigurare, i dati della realtà sensibile. E’ inevitabile leggere questo racconto avendo come pietra di paragone “Moby Dick” o, almeno, ricordandone la peculiare caratteristica, quel suo tono mistico di predicazione sacra, che trasfigura la storia di mare in una lotta epica tra bene e male, anzi, nella lotta tra due potenze contrapposte, fatta di vendetta, accanimento, di morbosità, il tutto sostenuto da uno stile di scrittura che si fa a tratti apocalittico. Dopo “Moby Dick”, le storie di mare di Melville non possono trovare il lettore impreparato, dopo “Moby Dick” è chiaro che l’avventura è sporgersi su un abisso, perché, come dice Michele Mari ne “I demoni e la pasta sfoglia”, “Melville sapeva che non c’è conflitto che non renda uguali al nemico, non c’è abisso in cui si possa guardare impunemente”. E quindi, chi si appresta a leggere “Benito Cereno” non si faccia ingannare dall’incipit, classico esordio che sembra preludere ad un canonico racconto di mare, perfettamente in linea con la tradizione ottocentesca, perché bastano poche pagine e ci si ritrova in piena bonaccia, reale e metaforica. “Lasciate che mi chiami per il momento William Wilson”. Un incipit, una frase che ci porta immediatamente sull’orlo del baratro, ce lo fa intravedere, ci mostra gli esordi della somma inquietudine, del demone più terribile che si nasconde dietro ai paraventi della realtà. Poe lo fa usando con la sua solita grandissima perizia le armi del suo mestiere. Questo signore delle atmosfere, capace di graduare l’incubo, di modellare l’attesa, di suscitarlo con i suoi ritmi. Si può perdere tutto, ma non se stessi; si può provare il dolore dell’abbandono, del disprezzo, della solitudine; si può soffrire nel corpo e nell’anima, ma la sofferenza più grande è la vita priva della certezza della propria identità. Poe ci porta sull’orlo di questo baratro, non poteva farci compiere il passo successivo.
“Lasciate che mi chiami per il momento William Wilson”. Un incipit, una frase che ci porta immediatamente sull’orlo del baratro, ce lo fa intravedere, ci mostra gli esordi della somma inquietudine, del demone più terribile che si nasconde dietro ai paraventi della realtà. Poe lo fa usando con la sua solita grandissima perizia le armi del suo mestiere. Questo signore delle atmosfere, capace di graduare l’incubo, di modellare l’attesa, di suscitarlo con i suoi ritmi. Si può perdere tutto, ma non se stessi; si può provare il dolore dell’abbandono, del disprezzo, della solitudine; si può soffrire nel corpo e nell’anima, ma la sofferenza più grande è la vita priva della certezza della propria identità. Poe ci porta sull’orlo di questo baratro, non poteva farci compiere il passo successivo. E’ lo stesso Hawthorne a dare un consiglio ai suoi lettori: avvicinarsi al suo romanzo “nella limpida, bruna atmosfera crepuscolare in cui fu scritto: se lo aprite alla luce del sole, potrà parervi tale e quale un volume di pagine bianche”. Chissà, forse perché, come afferma alla fine del primo capitolo, “… questo è un racconto di umana debolezza e di umano dolore” e la debolezza e il dolore hanno sempre origini e spiegazioni complesse e, forse, vanno avvertiti emozionalmente più che compresi lucidamente. Resta il fatto che le pagine di questo libro (indipendentemente dall’ora del giorno in cui lo si legge) rimangono impresse nella mente del lettore, come la lettera scarlatta sul petto di Esther Pryme.
E’ lo stesso Hawthorne a dare un consiglio ai suoi lettori: avvicinarsi al suo romanzo “nella limpida, bruna atmosfera crepuscolare in cui fu scritto: se lo aprite alla luce del sole, potrà parervi tale e quale un volume di pagine bianche”. Chissà, forse perché, come afferma alla fine del primo capitolo, “… questo è un racconto di umana debolezza e di umano dolore” e la debolezza e il dolore hanno sempre origini e spiegazioni complesse e, forse, vanno avvertiti emozionalmente più che compresi lucidamente. Resta il fatto che le pagine di questo libro (indipendentemente dall’ora del giorno in cui lo si legge) rimangono impresse nella mente del lettore, come la lettera scarlatta sul petto di Esther Pryme.