ARNO SCHMIDT – “Alessandro, o Della verità” – Einaudi
 “E nell’agorà fanno ressa prestidigitatori truffaldini e pugilatori, tagliaborse, ruffiani, ciarlatani e puttane. E nel migliore dei casi si tratta di poveri deficienti, zerbinotti vanesi e tromboni privi di cervello. E ognuno di costoro è soddisfatto di sè, si atteggia a massima dignità, si inchina con cortesia, gonfia grossolanamente le guance, gesticola con le mani, guata allocchito, schiamazza, strilla. (Hanno un sacco di termini: esperto della vita: è uno, che conosce un numero sufficiente di furfanterie spicciole. – Carattere in sè concluso: ha finalmente disimparato qualsiasi ideale. – Maniere disinvolte: sfacciato e, già da un pezzo, maturo per la forca). Questi sono i piccoli; e i grandi: ogni uomo di Stato, politico, oratore, principe, condottiero, ufficiale, va strozzato senza indugio, prima che trovi il tempo e l’occasione di acquistare il nome di grande a spese dell’umanità. – E chi sono allora i soli grandi? Artisti e scienziati! E basta! E tra costoro il più piccolo onest’uomo è mille volte più grande del grande Serse. – Se gli dei si offrissero di esaudirmi 3 desideri, uno di questi sarebbe l’immediata liberazione della Terra dal genere umano. Nonchè dagli animali (anche essi sono ormai troppo malvagi). Le piante, già meglio (tranne le insettivore). – Il vento si fa più forte”.
“E nell’agorà fanno ressa prestidigitatori truffaldini e pugilatori, tagliaborse, ruffiani, ciarlatani e puttane. E nel migliore dei casi si tratta di poveri deficienti, zerbinotti vanesi e tromboni privi di cervello. E ognuno di costoro è soddisfatto di sè, si atteggia a massima dignità, si inchina con cortesia, gonfia grossolanamente le guance, gesticola con le mani, guata allocchito, schiamazza, strilla. (Hanno un sacco di termini: esperto della vita: è uno, che conosce un numero sufficiente di furfanterie spicciole. – Carattere in sè concluso: ha finalmente disimparato qualsiasi ideale. – Maniere disinvolte: sfacciato e, già da un pezzo, maturo per la forca). Questi sono i piccoli; e i grandi: ogni uomo di Stato, politico, oratore, principe, condottiero, ufficiale, va strozzato senza indugio, prima che trovi il tempo e l’occasione di acquistare il nome di grande a spese dell’umanità. – E chi sono allora i soli grandi? Artisti e scienziati! E basta! E tra costoro il più piccolo onest’uomo è mille volte più grande del grande Serse. – Se gli dei si offrissero di esaudirmi 3 desideri, uno di questi sarebbe l’immediata liberazione della Terra dal genere umano. Nonchè dagli animali (anche essi sono ormai troppo malvagi). Le piante, già meglio (tranne le insettivore). – Il vento si fa più forte”.
 “C’è un vento di anarchia corrosiva che attraversa questi racconti” (Francesco M. Cataluccio)
“C’è un vento di anarchia corrosiva che attraversa questi racconti” (Francesco M. Cataluccio) “Pensare è un atto di disperazione”
“Pensare è un atto di disperazione”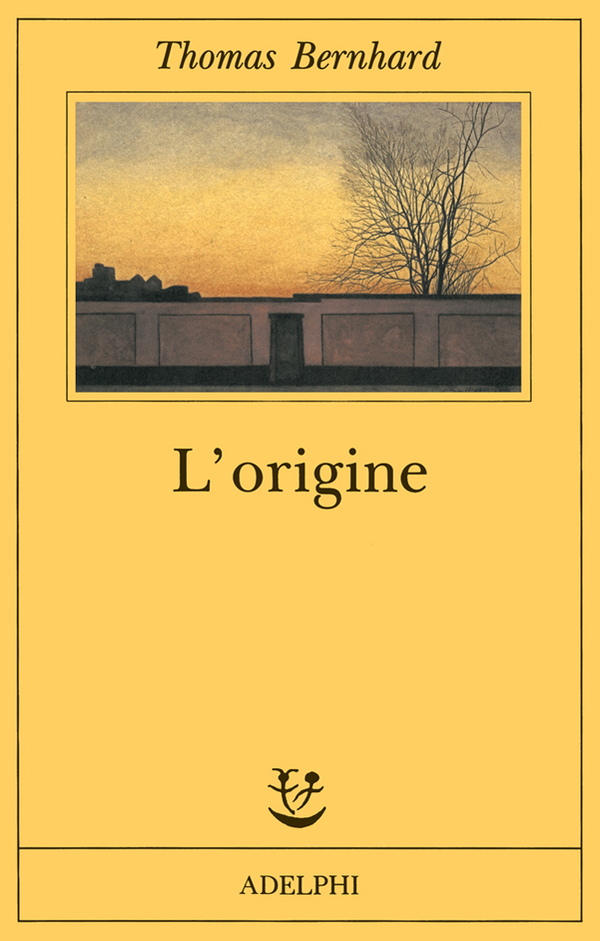
 Considero da sempre i russi inarrivabili narratori, narratori di razza, ma l’intento di Vojnovic di ripercorrere in un romanzo gli ultimi cinquanta anni della storia del suo paese con tutto quello che ciò implica, in termini di avvenimenti, ideologie, mutamenti economici e sociali, trasformazioni culturali mi faceva temere fortemente nella sua riuscita. Invece “Propaganda monumentale” è un bellissimo romanzo e, per me, una sorpresa confortante e la conferma che ancora è viva l’anima dei grandi romanzieri russi. Certo si potrebbe semplicemente attribuire la riuscita del romanzo al fatto che l’autore abbia opportunamente legato e reso unitaria una materia così vasta mediante la figura centrale di Aglaja con la sua incrollabile fede, ma anche vera e propria passione viscerale, per Stalin, poi per la sua memoria tenuta in vita dalla statua che assume un ruolo determinante in tutta la vicenda; oppure mediante la scelta di mantenere come luogo centrale dell’azione, attraverso il lento scorrere del tempo, la deliziosa e immaginaria cittadina di Dolgov, che i lettori vedono lentamente trasformarsi, senza però perdere le sue caratteristiche più peculiari e amabili. Questo fa parte del mestiere, o meglio, dell’arte del narrare.
Considero da sempre i russi inarrivabili narratori, narratori di razza, ma l’intento di Vojnovic di ripercorrere in un romanzo gli ultimi cinquanta anni della storia del suo paese con tutto quello che ciò implica, in termini di avvenimenti, ideologie, mutamenti economici e sociali, trasformazioni culturali mi faceva temere fortemente nella sua riuscita. Invece “Propaganda monumentale” è un bellissimo romanzo e, per me, una sorpresa confortante e la conferma che ancora è viva l’anima dei grandi romanzieri russi. Certo si potrebbe semplicemente attribuire la riuscita del romanzo al fatto che l’autore abbia opportunamente legato e reso unitaria una materia così vasta mediante la figura centrale di Aglaja con la sua incrollabile fede, ma anche vera e propria passione viscerale, per Stalin, poi per la sua memoria tenuta in vita dalla statua che assume un ruolo determinante in tutta la vicenda; oppure mediante la scelta di mantenere come luogo centrale dell’azione, attraverso il lento scorrere del tempo, la deliziosa e immaginaria cittadina di Dolgov, che i lettori vedono lentamente trasformarsi, senza però perdere le sue caratteristiche più peculiari e amabili. Questo fa parte del mestiere, o meglio, dell’arte del narrare. “Verrà il tempo di un popolo mansueto,
“Verrà il tempo di un popolo mansueto, “Ci sono giorni in cui vorrei soltanto andare via e venire a Parigi, sentire come tu afferri le mie mani e mi tocchi con i fiori e di nuovo non sapere da dove vieni e dove vai. Per me tu vieni dall’India o da un paese ancora più remoto, scuro, bruno, per me tu sei il deserto e il mare e tutto quanto è mistero. Ancora non so nulla di te e per questo ho paura per te, non riesco a immaginare che tu debba fare le stesse cose che facciamo qui noi altri, dovrei avere un castello per noi e portarti da me, perchè lì dentro tu possa essere il mio incantato Signore, tappeti molti avremo e musica e inventeremo l’amore”.
“Ci sono giorni in cui vorrei soltanto andare via e venire a Parigi, sentire come tu afferri le mie mani e mi tocchi con i fiori e di nuovo non sapere da dove vieni e dove vai. Per me tu vieni dall’India o da un paese ancora più remoto, scuro, bruno, per me tu sei il deserto e il mare e tutto quanto è mistero. Ancora non so nulla di te e per questo ho paura per te, non riesco a immaginare che tu debba fare le stesse cose che facciamo qui noi altri, dovrei avere un castello per noi e portarti da me, perchè lì dentro tu possa essere il mio incantato Signore, tappeti molti avremo e musica e inventeremo l’amore”. Ora che si è sedimentato nel ricordo della lettura, mi appare chiaro che questo libro di Kovac mi parla con due voci: una è quella dello scrittore che ricerca e rievoca le sue radici attraverso ricordi, visioni, illusioni, interpretazioni a posteriori di eventi e incontri (“con uno stile rapsodico”, “elaborando una poetica balcanica”, come recita la quarta di copertina, che accomuna l’autore a Andric e Kis); l’altra è quella dello scrittore che, sospendendo la narrazione, interviene, approfittando, sembra, dell’attenzione che è riuscito ad ottenere, per rivolgersi direttamente al lettore e per comunicargli quello che evidentemente nel corso degli anni è venuto in lui maturando riguardo alla scrittura e allo scrivere.
Ora che si è sedimentato nel ricordo della lettura, mi appare chiaro che questo libro di Kovac mi parla con due voci: una è quella dello scrittore che ricerca e rievoca le sue radici attraverso ricordi, visioni, illusioni, interpretazioni a posteriori di eventi e incontri (“con uno stile rapsodico”, “elaborando una poetica balcanica”, come recita la quarta di copertina, che accomuna l’autore a Andric e Kis); l’altra è quella dello scrittore che, sospendendo la narrazione, interviene, approfittando, sembra, dell’attenzione che è riuscito ad ottenere, per rivolgersi direttamente al lettore e per comunicargli quello che evidentemente nel corso degli anni è venuto in lui maturando riguardo alla scrittura e allo scrivere. Il Console, questo personaggio inevitabilmente e perdutamente amato dai lettori di Lowry, è il protagonista di una tragedia che si preannuncia nelle prime pagine del libro e che si compie rapidamente nelle ultime. Quello che è richiesto e imposto al lettore da uno stile trascinante e lussureggiante è di seguire il succedersi degli eventi che si snodano lenti, che indugiano, che rallentano fino a fermarsi per dar luogo a splendide divagazioni. Quello che è chiesto al lettore è di condividere lo sguardo ubriaco del Console sul mondo, sulla realtà, uno sguardo di volta in volta lucidissimo o visionario, disperato, rassegnato o, persino, ingenuo. La strada, amarissima, verso la disillusione è costellata da momenti di rara intensità emotiva e lirica.
Il Console, questo personaggio inevitabilmente e perdutamente amato dai lettori di Lowry, è il protagonista di una tragedia che si preannuncia nelle prime pagine del libro e che si compie rapidamente nelle ultime. Quello che è richiesto e imposto al lettore da uno stile trascinante e lussureggiante è di seguire il succedersi degli eventi che si snodano lenti, che indugiano, che rallentano fino a fermarsi per dar luogo a splendide divagazioni. Quello che è chiesto al lettore è di condividere lo sguardo ubriaco del Console sul mondo, sulla realtà, uno sguardo di volta in volta lucidissimo o visionario, disperato, rassegnato o, persino, ingenuo. La strada, amarissima, verso la disillusione è costellata da momenti di rara intensità emotiva e lirica. Zoderer ha scritto un romanzo che ha come protagonista l’estraneità, il senso della non appartenenza, l’isolamento al limite della totale segregazione, che appare tanto più irrimediabile quando viene avvertito in opposizione, in contrasto, alla socialità, alle reti di relazioni, apparentemente facili e “naturali”, in cui gli altri sembrano essere immersi. Zoderer ha scritto un romanzo che è nostalgia di quell’”heimat”, quella casa, quel luogo natìo, quel territorio in cui ci si sente a casa proprio perché vi si è nati, vi si è trascorsa l’infanzia, o vi si parla la lingua degli affetti. La protagonista di “L’italiana” sperimenta lo sradicamento di chi non possiede neppure questa nostalgia ed è in grado solo di capire razionalmente il significato dell’heimat, ma non di sentirlo emozionalmente.
Zoderer ha scritto un romanzo che ha come protagonista l’estraneità, il senso della non appartenenza, l’isolamento al limite della totale segregazione, che appare tanto più irrimediabile quando viene avvertito in opposizione, in contrasto, alla socialità, alle reti di relazioni, apparentemente facili e “naturali”, in cui gli altri sembrano essere immersi. Zoderer ha scritto un romanzo che è nostalgia di quell’”heimat”, quella casa, quel luogo natìo, quel territorio in cui ci si sente a casa proprio perché vi si è nati, vi si è trascorsa l’infanzia, o vi si parla la lingua degli affetti. La protagonista di “L’italiana” sperimenta lo sradicamento di chi non possiede neppure questa nostalgia ed è in grado solo di capire razionalmente il significato dell’heimat, ma non di sentirlo emozionalmente.