Traduzione di Stefano Apostolo e Samir Thabet
Postfazione di Franz Haas
Con questa raccolta di liriche, pubblicata per la prima volta a Salisburgo nel 1957 e uscita in Italia nel 2020 con la traduzione di Stefano Apostolo e Samir Thabet, si risale alle origini della poetica di Bernhard e, a ben vedere, anche a quelle della sua prosa e della sua drammaturgia. E non sono certo quelle origini dallo stesso autore tanto rinnegate al punto da cantarne l’estinzione con il suo ultimo celebre romanzo, quanto quelle destinate ad avere una florida, dolente, caustica e personalissima fioritura in una produzione letteraria di indubbio valore, punto di riferimento e insieme pietra di paragone per i lettori ed estimatori dello scrittore austriaco.
Con questa raccolta un giovane Bernhard ventiseienne si avvia infatti in modo definitivo alla scrittura, anzi, forse si arrende ad essa, cerca le strade sulle quali avventurarsi per misurare la forza di quella parola che inizia ad intravvedere come un destino, scomodo, esigente, ma difficilmente evitabile, ma anche come un’ancora di salvezza a cui aggrapparsi e un modo per sentire di esistere.
La prima impressione per il lettore è quella di trovarsi di fronte a versi che tracciano un movimento, di allontanamento e di riavvicinamento, come se le varie liriche componessero un viaggio verso un altrove e ritorno, con quell’andamento a spirale, quell’alternarsi di freddo rifiuto e di doloroso e camuffato rimpianto che più tardi darà vita all’interiorità dei grandi personaggi bernhardiani e ai loro monologhi. Un equilibrio tra la freddezza più razionale e l’assoluta libertà di una incipiente e lucidissima pazzia.
Così la parola attraversa la terra per giungere all’inferno, a quell’inferno che è talmente prossimo e così facilmente raggiungibile che basta uno sguardo disincantato per scoprirlo attraverso le trame sdrucite della realtà. Terra e inferno che il giovane poeta sembra conoscere intimamente e rifuggire nello stesso tempo, pur sentendosi ad essi legato o destinato.
La lirica, a cui Bernhard in quegli anni si dedica, fino alla pubblicazione nel 1963 di “Frost” (“Gelo”), il suo primo romanzo, costituisce per lo scrittore non solo un mezzo espressivo potente e versatile, ma anche il laboratorio nel quale sperimentare i mezzi idonei ad elaborare quelle atmosfere da “cosmo lacerato” (così le definisce Franz Haas nella Postfazione al volume) che diventeranno presto la sua cifra personale più riconoscibile.
Si tratta forse per il giovane poeta di delineare i confini del proprio mondo e di percorrerlo minuziosamente, tornando più volte sui suoi passi, modulando e rimodulando le note di una personalità solitaria e abbandonata “in paesaggi millenari”, scrive ancora Haas, “freddi e oscuri, nei quali brancola alla ricerca di un padre e di una madre assenti”.
Le stesse tematiche delle liriche, evidenziate in parte dalla suddivisione in cinque sezioni, confermano nel lettore l’impressione di trovarsi immerso in un magma espressivo solo parzialmente differenziato, attraverso il quale l’autore, forse tentato dall’idillio, ma votato comunque alla sua negazione – e quindi alla sua distruzione – lo ricompone, utilizzando però i suoi stessi materiali dispersi e frantumati, delineando quindi una sorta di anti idillio.
Variazione, approfondimento quasi maniacale, ripetizione di immagini, suggestioni e tormenti anticipano nella poesia – nella sua rotta ma pur avvertibile armonia – l’effetto ipnotico di una prosa monologante di cui già si avverte l’eco.
Così l’odio e il rifiuto, tante volte ripetuto con accenti e intensità diversi, per la terra contadina, che Bernhard individua come la propria rinnegata origine, diventano in questi versi il canto di un fuggitivo costretto al ritorno da una sorta di amara condanna, ma anche da un doloroso amore.
Se le sezioni in cui le liriche vengono raggruppate, secondo il filone tematico predominante, sono i passi di un accidentato cammino – di un movimento nello spazio e nelle profondità di un giovane animo tormentato – la prima, dal titolo “Dietro gli alberi c’è un altro mondo”, è indubbiamente collocata in quella terra austriaca contadina che l’autore individua come la patria originaria dei propri antenati e dei propri familiari, quell’heimat che dovrebbe amare, che lo attira e lo respinge nello stesso tempo (“Dietro gli alberi c’è un altro mondo,/ il fiume mi porta i lamenti,/ il fiume mi porta i sogni,/ il fiume tace quando la sera sogno nelle foreste/ del nord…/ Dietro gli alberi c’è un altro mondo,/ che mio padre scambiò per due uccelli,/ che mia madre portò a casa in un cesto,/ che mio fratello perse nel sonno, quando aveva sette anni ed era stanco…”), che genera in lui un profondo disgusto (“Come vidi nel paese questi morti mangiare sulle tavole/ carne rossa con pance gonfie,/ biascicare gli inni della birra,/ la putredine che attraversò strisciando il giardino dell’osteria/ sotto il ruggito inerte della tromba…”) e la consapevolezza crescente della propria estraneità (“Io sono indegno di queste anime, che in nuvole e cespugli/ si parlano della terra in germoglio,/ della musica del cielo morente,/ delle grandi solitudini, scivolando sopra le colline,/ precedendo impaziente gli inverni tempestosi del mondo.”).
Il passo successivo è inevitabilmente nella direzione contraria, verso il cuore pulsante delle città, alla ricerca di una vita totalmente diversa, di altri orizzonti, lontani dalla campagna natia, alla ricerca di quell’altrove che sembra sempre più irraggiungibile. Si realizza anche qui, se è possibile individuare nell’ambito poetico alcuni aspetti tipici di tutta la biografia bernhardiana, quella necessità di cambiare bruscamente direzione che si realizza per esempio nel ragazzino che lascia improvvisamente gli studi per iniziare a lavorare nella cantina, o nel giovane uomo che lascia il sanatorio sfidando i rischi della malattia per provare a vivere.
Le liriche della seconda sezione, dal titolo “Le città incenerite” – incenerite perché ancora segnate dalle distruzioni belliche non ancora del tutto sanate, ma anche perché teatro di una amara disillusione – delineano atmosfere solitarie e desolate in mezzo ad una umanità affaccendata a sopravvivere e al fervore di una vita estranea (“Non abbiamo mai visto le città dietro gli stagni/ e mai udito il lamento delle donne,/ che nelle stanze pulivano i loro vestiti/ e i loro libri dalla polvere dei lunghi anni.”).
“Nella mia capitale” è la lunga lirica dedicata a Vienna, la città che da sola rappresenta il mondo contrapposto all’angusta campagna natìa, dove però il poeta si sente “un perdigiorno”,”uno stalliere”, “un paesano distrutto dai tormenti”: “Ma cosa trovai nella mia capitale?/ La morte con il suo muso di cenere, devastante, sete e fame,/ ben fastidiosa per la mia fame, perché era/ una fame di carne e pane, di volti e gabinetti,/ una fame che balbetta l’infamia di questa città,/ una fame di miseria,/ luccicante da finestra a finestra, generatrice di primavera e gloria putrida/ sotto le scale del paradiso.”.
Parigi è “un mare che ti manda in rovina, un velo/ di tetti, obitori, di fabbriche e gonne di seta,/ un velo di alberi luccicanti e tenere danze vorticose,..” ed è in questa città che Bernhard scrive i versi più drammatici di tutta la raccolta: “Se potessi dire quante volte volevo morire questa notte,/ morire senza salmo e senza madre e padre, morire come la bestia/ che soffoca rannicchiata tra le mura,/ morire come un verme calpestato, senza aiuto,/ morire come il merlo schiacciato dalla ruota della sopraelevata/ [..] mai così tanto dolore, così tanto odore di corpi umani ho respirato prima d’ora.”.
Come ben sottolinea Haas, nulla riesce a vincere quella “luce crepuscolare, quasi mortifera” che pervade le città e che nasconde quel loro fascino tanto decantato per secoli dai poeti. Si tratta di una luce interiore che si riflette sui luoghi in cui Bernhard sembra dirigere la sua perenne fuga da una realtà all’altra, e sulla gente che il suo sguardo acuto e impietoso osserva dalla profondità della propria solitudine.
Questa fuga è allora, anche, una fuga nella poesia, che diventa l’unico rifugio, il luogo in cui amplificare, lasciar risuonare le parole, e perché no, cedere alla retorica, tanto consona a Bernhard, dell’esagerazione, intesa come utilizzo totale, nel nome della letteratura, di ogni accenno, spunto o angolo nascosto del pensiero, fino alla sua completa ed esasperata espressione.
Nel romanzo “Il freddo”, è lo stesso autore a scrivere, riferendosi ad un periodo drammatico della sua giovinezza: “[..] adesso avevo a disposizione questo mezzo per raggiungere i miei fini, e allora con tutte le mie forze mi gettai nella scrittura, abusavo del mondo intero per trasformarlo in versi, quei versi, se pur privi di valore, significavano tutto per me, niente al mondo aveva per me maggiore significato, e io non avevo più niente, non avevo altro che la possibilità di scrivere poesie.”
Anche se l’autore si riferisce qui alle sue prime composizioni poetiche (“centinaia e centinaia di poesie”) e non certo a quelle delle cinque raccolte poi pubblicate, rimane anche nelle liriche della presente questa volontà dell’autore di appropriarsi del mondo, di comprenderlo totalmente all’interno del suo sguardo, severissimo e intransigente, di utilizzarlo per dare forza alle sue invettive e, anche, alle sue invocazioni.
La terza sezione, “La notte che mi trafigge il cuore”, è infatti intima e notturna, esito di un viaggio nella profondità di un io inquieto che si dibatte nella ricerca di un senso, senza cedere mai al sentimentalismo, ma gridando al contrario le sue domande al nulla – “Perché questi giorni, perché il morire,/ perché tutto questo, io non lo amo, non amo l’arbusto/ né i fiori nella bocca dell’asino né l’urlo/ delle mie membra in autunno né la fatica dei contadini,/ e nessuna gloria nel dolore, che mi impose mia madre quando non le rimase altro che morire..” – trovando nella notte l’atmosfera più adatta per nutrire le proprie parole – “Non sai nulla, fratello mio, della notte,/ non sai nulla di questa pena, che mi consumò,/ come la poesia, che portava la mia anima e la sorreggeva,/ non sai nulla di questi mille tramonti, mille specchi/ che mi getteranno nell’abisso.” – ed esprimendo una spiritualità laica e disincantata nei bellissimi “Nove salmi” che hanno la forza di un grido che è insieme protesta e invocazione: “Nera è l’erba, Padre,/ nera è la terra,/ neri sono i miei pensieri,/ perché sono un uomo povero./ Nera è la Terra,/nero è il tramonto del Sole,/ nero è il mio messaggio./ Nero è l’abito che più non mi abbandonerà,/ nere sono le stelle della mia traversata,/ nero è il pensiero del mio morire./ Dove ho trovato questo nero, questo impronunciabile nero?”.
La quarta sezione della raccolta, dal titolo “Morte e timo”, descrive un passo ulteriore in questo tragitto di vertiginosa discesa in un tormentato mondo interiore. Con queste liriche l’autore “inizia a posare le pietre angolari di un paesaggio fatto di morte e di devastazione, in cui la pena e il tormento si rivelano elementi dominanti, capaci, con la loro forza, di attrarre a sé anche il paesaggio. La campagna dei martoriati diventa una campagna martoriata, il dolore dell’io lirico si riversa su tutto quello che incontra, piegandolo alla sua necessità di dar voce al dolore.” (Samir Thabet e Micaela Latini, “La poesia di Thomas Bernhard”). Solo così parole apparentemente peregrine, come morte e timo, utilizzate in accostamenti inediti, danno vita a significati ermetici ma talmente espressivi da parlare alla sensibilità del lettore e, forse, anche al suo profondo bisogno di comprendere il mondo.
Infine, con l’ultima sezione, “Ritorno in un amore”, si chiude un cerchio, si torna al mondo nascosto dietro gli alberi delle prime poesie, il faticoso cammino verso l’altrove non sembra aver trovato vie di fuga percorribili e i titoli stessi delle liriche riportano al mondo contadino – il melo, il villaggio, il profumo dei cespugli, la fontana, il grano, la casa dei genitori, il padre, la madre, il cimitero, la foresta – ma è un mondo ormai chiuso e suggellato dall’ombra della morte che fa capolino a coprire ogni possibile dolcezza con la sua ombra: “La morte mi ha scagliato nel fieno dell’estate./ Ora pende fuori e ride/ e strozza il pero./ Nessuno la scuote giù,/ nessuno squillo di tromba/ la scaccia verso le colline,/ dalle valli vengono quelli che mi uccideranno;/ contadini, venditori, macellai/ e con l’agnello pasquale il parroco/ che si affida a me./ La morte mi ha scagliato nel fieno dell’estate./ Nessuno spezza in due/ la mia gloria e mi lascia libero..”.
Quella che alla fine della lettura rimane impressa, viva, forte e alta, è la voce del lamento di un’anima sola nei confronti di un’esistenza senza prospettive e delle mille vie attraverso le quali esso si declina, con lo scopo, per usare ancora le parole di Thabet e Latini, “di costringere il lettore non già a superarlo, bensì a viverlo e a sopportarlo”. E anche se è ancora lontana la voce tagliente, ironica, irriverente e implacabile del Bernhard prosatore e drammaturgo, già in questi versi se ne possono intuire le origini.
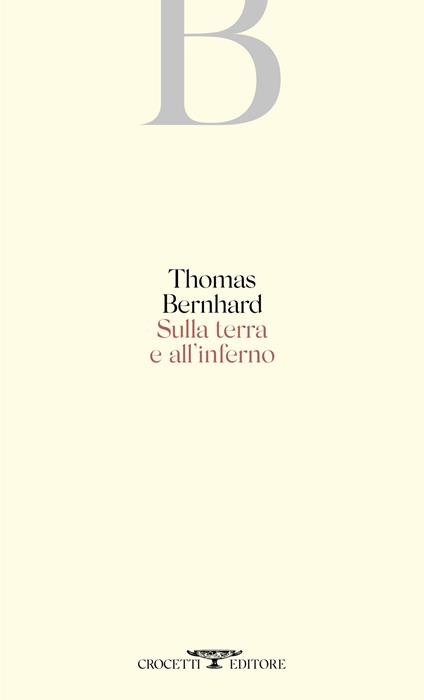
Che bellissima lettura! Che prosa profonda, insieme misurata e completa!
Grazie! Non potevo non omaggiare il giovane Bernhard. Credo di aver letto tutto quello che di questo autore sia stato tradotto in italiano. Spero comunque in qualche altra sorpresa!