JUAN CARLOS ONETTI – La vita breve – Einaudi
“Ognuno è soltanto un momento eventuale”
 Permane, alla fine di questo lungo – e travolgente e sorprendente – romanzo, una vaga nostalgia di stanze chiuse, quasi sempre notturne, con le finestre spalancate su un vento fresco e nero, o serali, con i rumori consueti delle esistenze che si ritirano. Permangono le immagini di innumerevoli oggetti che popolano questi interni, minuziosamente ripresi nelle vaghe sfumature che la luce disegna su di loro. Locali notturni, oppure uffici, camere d’albergo, caffè, ambulatori: una maestria descrittiva che si dipana con una lentezza che si fa spesso sontuosa nel delineare gli ambiti essenziali ai quali si aggrappa una narrazione che prolifera e lievita, a partire da un punto di non ritorno. Perché come si torna indietro dalla fredda constatazione che la vita – qualsiasi vita – è, o diventerà prima o poi, disperata e disperante? E come si continua a vivere con “la sicurezza indimenticabile che non c’è in nessun luogo una donna, un amico, una casa, un libro, nemmeno un vizio, che possano farmi felice”, come constata lucidamente Juan Maria Brausen, il protagonista del libro? Il romanzo di Onetti inizia dunque dove tante opere della più grande letteratura finiscono: dalla constatazione che la vita è fatta di malintesi e che non c’è via d’uscita, che la condizione più naturale per l’uomo è quella del disperato (che sia disperato puro, “incapace di innalzarsi fino all’altezza della sua prova”, oppure disperato debole e impuro, “che proclamerà la propria disperazione sistematicamente e pazientemente […] e sarà sempre in grado di creare il piccolo mondo di cui ha bisogno, sarà sempre disposto a piegarsi, ad assopirsi”, oppure disperato forte, che “sa o è convinto che nessuno potrà consolarlo”, ma che è disposto in qualsiasi momento ad “affrontare la propria disperazione, isolarla, guardarla in faccia”, secondo la onettiana, personalissima teoria della disperazione), perché non si sfugge alla disillusione, alla corruzione della malattia e della vecchiaia, alla scomparsa delle persone care o, peggio, dei sentimenti che un tempo si provavano per loro. Anche se pare che questa consapevolezza sia un dono terribile riservato ad alcuni, perché tanti invece avanzano sicuri “verso il mondo poetico, musicale e plastico del domani”.
Permane, alla fine di questo lungo – e travolgente e sorprendente – romanzo, una vaga nostalgia di stanze chiuse, quasi sempre notturne, con le finestre spalancate su un vento fresco e nero, o serali, con i rumori consueti delle esistenze che si ritirano. Permangono le immagini di innumerevoli oggetti che popolano questi interni, minuziosamente ripresi nelle vaghe sfumature che la luce disegna su di loro. Locali notturni, oppure uffici, camere d’albergo, caffè, ambulatori: una maestria descrittiva che si dipana con una lentezza che si fa spesso sontuosa nel delineare gli ambiti essenziali ai quali si aggrappa una narrazione che prolifera e lievita, a partire da un punto di non ritorno. Perché come si torna indietro dalla fredda constatazione che la vita – qualsiasi vita – è, o diventerà prima o poi, disperata e disperante? E come si continua a vivere con “la sicurezza indimenticabile che non c’è in nessun luogo una donna, un amico, una casa, un libro, nemmeno un vizio, che possano farmi felice”, come constata lucidamente Juan Maria Brausen, il protagonista del libro? Il romanzo di Onetti inizia dunque dove tante opere della più grande letteratura finiscono: dalla constatazione che la vita è fatta di malintesi e che non c’è via d’uscita, che la condizione più naturale per l’uomo è quella del disperato (che sia disperato puro, “incapace di innalzarsi fino all’altezza della sua prova”, oppure disperato debole e impuro, “che proclamerà la propria disperazione sistematicamente e pazientemente […] e sarà sempre in grado di creare il piccolo mondo di cui ha bisogno, sarà sempre disposto a piegarsi, ad assopirsi”, oppure disperato forte, che “sa o è convinto che nessuno potrà consolarlo”, ma che è disposto in qualsiasi momento ad “affrontare la propria disperazione, isolarla, guardarla in faccia”, secondo la onettiana, personalissima teoria della disperazione), perché non si sfugge alla disillusione, alla corruzione della malattia e della vecchiaia, alla scomparsa delle persone care o, peggio, dei sentimenti che un tempo si provavano per loro. Anche se pare che questa consapevolezza sia un dono terribile riservato ad alcuni, perché tanti invece avanzano sicuri “verso il mondo poetico, musicale e plastico del domani”.
 Rileggo spesso le liriche della Bachmann e, tra quelle contenute nella raccolta “Invocazione all’Orsa Maggiore”, ancora più spesso i “Lieder auf der Flucht”, i “Canti lungo la fuga”. Principalmente per la consapevolezza che non esiste la possibilità di dichiarare finita, terminata, la lettura della poesia, quando è grande poesia, e poi, probabilmente, anche per convincermi che sia veramente esistita una simile voce poetica, una simile voce poetica femminile. Fuga, “Flucht”, è un termine che ricorre spesso nel lessico poetico della Bachmann; i suoi versi sottendono spesso un movimento, un allontanamento o, al massimo, delle soste precarie e momentanee, già consapevoli della propria transitorietà. Forse rileggo così spesso questi “Canti” perché, nel mio immaginario, sono quelli che meglio rappresentano il soggetto poetico che li ha generati, la sua anima così complessa e contraddittoria, ritrosa ma anche votata all’espressione di sé. Perché la Bachmann sembra costantemente negarsi, ma anche concedersi, sembra esistere di un’esistenza perentoria ed esigente, nelle brevi soste di una vita interiore da fuggitiva.
Rileggo spesso le liriche della Bachmann e, tra quelle contenute nella raccolta “Invocazione all’Orsa Maggiore”, ancora più spesso i “Lieder auf der Flucht”, i “Canti lungo la fuga”. Principalmente per la consapevolezza che non esiste la possibilità di dichiarare finita, terminata, la lettura della poesia, quando è grande poesia, e poi, probabilmente, anche per convincermi che sia veramente esistita una simile voce poetica, una simile voce poetica femminile. Fuga, “Flucht”, è un termine che ricorre spesso nel lessico poetico della Bachmann; i suoi versi sottendono spesso un movimento, un allontanamento o, al massimo, delle soste precarie e momentanee, già consapevoli della propria transitorietà. Forse rileggo così spesso questi “Canti” perché, nel mio immaginario, sono quelli che meglio rappresentano il soggetto poetico che li ha generati, la sua anima così complessa e contraddittoria, ritrosa ma anche votata all’espressione di sé. Perché la Bachmann sembra costantemente negarsi, ma anche concedersi, sembra esistere di un’esistenza perentoria ed esigente, nelle brevi soste di una vita interiore da fuggitiva.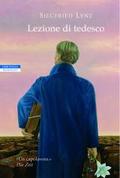 “Lezione di tedesco”, pubblicato in Germania nel 1968, è l’ultima opera presentata nella miscellanea “Il romanzo tedesco del Novecento” (la prima è “I Buddenbrook” di Thomas Mann, 1901), il volume pubblicato da Einaudi nel 1973 e redatto a cura di Giuliano Baioni, Giuseppe Bevilacqua, Cesare Cases e Claudio Magris, al fine di rendere omaggio a Ladislao Mittner, in occasione del suo settantesimo compleanno. Omaggio e attestazione di stima nei confronti di colui che viene considerato il nostro massimo germanista, l’autore di quella summa che è la sua “Storia della letteratura tedesca”. I saggi che costituiscono la raccolta, alcuni scritti dagli stessi curatori (G. Baioni si occupa de “Il castello” di Kafka, C. Cases de “La promessa” di Durrenmatt, G. Bevilacqua de “I turbamenti del giovane Torless” di Musil e C. Magris de “La marcia di Radetzky” di Roth e di “Perturbamento” di Bernhard, curiosamente tradotto “Perturbazione”), ma, per la maggior parte, affidati ad altri studiosi, italiani o tedeschi, culturalmente o spiritualmente vicini al festeggiato, presentano e analizzano i più importanti romanzi del Novecento tedesco, ordinati cronologicamente in base alla data della loro prima pubblicazione.
“Lezione di tedesco”, pubblicato in Germania nel 1968, è l’ultima opera presentata nella miscellanea “Il romanzo tedesco del Novecento” (la prima è “I Buddenbrook” di Thomas Mann, 1901), il volume pubblicato da Einaudi nel 1973 e redatto a cura di Giuliano Baioni, Giuseppe Bevilacqua, Cesare Cases e Claudio Magris, al fine di rendere omaggio a Ladislao Mittner, in occasione del suo settantesimo compleanno. Omaggio e attestazione di stima nei confronti di colui che viene considerato il nostro massimo germanista, l’autore di quella summa che è la sua “Storia della letteratura tedesca”. I saggi che costituiscono la raccolta, alcuni scritti dagli stessi curatori (G. Baioni si occupa de “Il castello” di Kafka, C. Cases de “La promessa” di Durrenmatt, G. Bevilacqua de “I turbamenti del giovane Torless” di Musil e C. Magris de “La marcia di Radetzky” di Roth e di “Perturbamento” di Bernhard, curiosamente tradotto “Perturbazione”), ma, per la maggior parte, affidati ad altri studiosi, italiani o tedeschi, culturalmente o spiritualmente vicini al festeggiato, presentano e analizzano i più importanti romanzi del Novecento tedesco, ordinati cronologicamente in base alla data della loro prima pubblicazione. “Chi canterà, se io non ci sono, la melodia delle case e delle strade, il tardo bagliore del sole sui merli delle torri, la pensosità delle cariatidi, chi intonerà il canto sommesso delle vecchie venditrici di ciambelle nel parco, i destini delle sponde del fiume e la maestà dei loro ponti?”
“Chi canterà, se io non ci sono, la melodia delle case e delle strade, il tardo bagliore del sole sui merli delle torri, la pensosità delle cariatidi, chi intonerà il canto sommesso delle vecchie venditrici di ciambelle nel parco, i destini delle sponde del fiume e la maestà dei loro ponti?”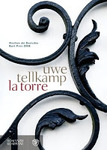 “Cercando, il fiume sembrava tendersi nella notte che principiava, la pelle si sgualciva e crepitava; pareva voler precedere il vento che si alzava in città, quando il traffico sui ponti era ridotto a poche auto e sporadici tram, il vento proveniente dal mare che circondava l’Unione Sovietica, l’Impero Rosso, l’Arcipelago, venato inframmezzato pervaso da arterie vene capillari del fiume alimentato dal mare, nella notte, il fiume che portava i rumori e i pensieri alla superficie scintillante, il riso, la serietà e l’allegria nella crescente oscurità…”
“Cercando, il fiume sembrava tendersi nella notte che principiava, la pelle si sgualciva e crepitava; pareva voler precedere il vento che si alzava in città, quando il traffico sui ponti era ridotto a poche auto e sporadici tram, il vento proveniente dal mare che circondava l’Unione Sovietica, l’Impero Rosso, l’Arcipelago, venato inframmezzato pervaso da arterie vene capillari del fiume alimentato dal mare, nella notte, il fiume che portava i rumori e i pensieri alla superficie scintillante, il riso, la serietà e l’allegria nella crescente oscurità…” Il 26 maggio 1828, lunedì di Pentecoste, in una piazza di Norimberga, avviene un fatto strano e inquietante, destinato a suscitare una morbosa curiosità, prima tra gli abitanti della città, e poi in tutto il Regno di Baviera, a generare una quantità di ipotesi interpretative da parte di uomini di legge e di cultura, e a tramutarsi in seguito in fertile fonte di ispirazione per molti scrittori, diventando un caso la cui eco è giunta fino alla nostra epoca (è del 1974 il film “L’enigma di Kaspar Hauser”, scritto e diretto da Werner Herzog). In pieno pomeriggio, in quella piazza, compare dal nulla un ragazzo dall’apparente età di sedici anni, vestito con abiti contadini. Il ragazzo si muove con un portamento da ubriaco, non riesce a stare diritto e fatica a muovere i piedi che appaiono feriti e ulcerati. Si guarda intorno, spaesato e meravigliato, come se vedesse il mondo per la prima volta, con gli occhi socchiusi per proteggersi dalla luce. Piange ed è affamato, ma rifiuta con orrore e ribrezzo cibi e bevande, tranne il pane nero e l’acqua. Si esprime con pianti, grida di dolore e suoni incomprensibili, pronunciando un’unica frase di senso compiuto, che ripete in modo ossessivo, come un ritornello: “Diventare cavaliere, come mio padre”. Così compare dal nulla Kaspar Hauser, l’enigma vivente destinato a diventare tanto popolare da essere chiamato “il Fanciullo d’Europa”, e al nulla ritorna in modo altrettanto misterioso, nel 1833, quando viene pugnalato a morte da uno sconosciuto nella cittadina bavarese di Ansbach, dove è sepolto. Sulla sua lapide si legge: “Qui riposa Kaspar Hauser, enigma del suo tempo. Ignota la sua origine, misteriosa la sua morte”.
Il 26 maggio 1828, lunedì di Pentecoste, in una piazza di Norimberga, avviene un fatto strano e inquietante, destinato a suscitare una morbosa curiosità, prima tra gli abitanti della città, e poi in tutto il Regno di Baviera, a generare una quantità di ipotesi interpretative da parte di uomini di legge e di cultura, e a tramutarsi in seguito in fertile fonte di ispirazione per molti scrittori, diventando un caso la cui eco è giunta fino alla nostra epoca (è del 1974 il film “L’enigma di Kaspar Hauser”, scritto e diretto da Werner Herzog). In pieno pomeriggio, in quella piazza, compare dal nulla un ragazzo dall’apparente età di sedici anni, vestito con abiti contadini. Il ragazzo si muove con un portamento da ubriaco, non riesce a stare diritto e fatica a muovere i piedi che appaiono feriti e ulcerati. Si guarda intorno, spaesato e meravigliato, come se vedesse il mondo per la prima volta, con gli occhi socchiusi per proteggersi dalla luce. Piange ed è affamato, ma rifiuta con orrore e ribrezzo cibi e bevande, tranne il pane nero e l’acqua. Si esprime con pianti, grida di dolore e suoni incomprensibili, pronunciando un’unica frase di senso compiuto, che ripete in modo ossessivo, come un ritornello: “Diventare cavaliere, come mio padre”. Così compare dal nulla Kaspar Hauser, l’enigma vivente destinato a diventare tanto popolare da essere chiamato “il Fanciullo d’Europa”, e al nulla ritorna in modo altrettanto misterioso, nel 1833, quando viene pugnalato a morte da uno sconosciuto nella cittadina bavarese di Ansbach, dove è sepolto. Sulla sua lapide si legge: “Qui riposa Kaspar Hauser, enigma del suo tempo. Ignota la sua origine, misteriosa la sua morte”. “La difficoltà di scrivere sulla filosofia di Wittgenstein, e soprattutto sulla sua poesia, infatti secondo il mio punto di vista si tratta nel caso di Wittgenstein di un intelletto (cervello) poetico, e dunque di un cervello filosofico, ma non di un filosofo, è la difficoltà più grande che vi sia. E’ come se io dovessi scrivere qualcosa (proposizioni) su me stesso, e questo non può essere […]. La questione è se io posso scrivere su Wittgenstein un attimo senza distruggere lui (Wittgenstein) o me stesso (Bernhard) […]. Wittgenstein è una domanda alla quale io non posso rispondere… Così io non scrivo su Wittgenstein non perché non posso, bensì perché io non posso rispondergli”.
“La difficoltà di scrivere sulla filosofia di Wittgenstein, e soprattutto sulla sua poesia, infatti secondo il mio punto di vista si tratta nel caso di Wittgenstein di un intelletto (cervello) poetico, e dunque di un cervello filosofico, ma non di un filosofo, è la difficoltà più grande che vi sia. E’ come se io dovessi scrivere qualcosa (proposizioni) su me stesso, e questo non può essere […]. La questione è se io posso scrivere su Wittgenstein un attimo senza distruggere lui (Wittgenstein) o me stesso (Bernhard) […]. Wittgenstein è una domanda alla quale io non posso rispondere… Così io non scrivo su Wittgenstein non perché non posso, bensì perché io non posso rispondergli”. “Era un ciclo di sei poesie che affluirono e s’avventarono tutte nello stesso momento, esistettero, prima di esse non esisteva nulla; allorchè lo stato crepuscolare fu al suo termine, restai vuoto, affamato, barcollante e me ne uscii in silenzio dal grande sfacelo”.
“Era un ciclo di sei poesie che affluirono e s’avventarono tutte nello stesso momento, esistettero, prima di esse non esisteva nulla; allorchè lo stato crepuscolare fu al suo termine, restai vuoto, affamato, barcollante e me ne uscii in silenzio dal grande sfacelo”. “Chi ammira con gli occhi la bellezza/ è già consegnato alla morte” (August Von Platen)
“Chi ammira con gli occhi la bellezza/ è già consegnato alla morte” (August Von Platen)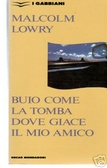 Si legge questo libro come tributo al Console di “Sotto il vulcano”, come un pegno pagato alla nostalgia che il protagonista del romanzo più famoso di Lowry, ma anche le atmosfere e i luoghi in cui si aggira quell’indimenticabile “divagatore alcolizzato” lasciano nel lettore. C’è un legame talmente stretto tra i due romanzi, che non è quasi possibile comprendere e apprezzare questo “Buio come la tomba dove giace il mio amico”, così colmo di allusioni, ricordi e riferimenti all’opera precedente, prescindendo dalla sua conoscenza o, addirittura, in molti casi, dalla sua puntuale consultazione. Eppure non si tratta di una semplice continuazione; d’altra parte Lowry può essere definito in molti modi, ma sicuramente è uno scrittore tutt’altro che semplice. Il suo fascino risiede tra le pieghe di una complessità che continuamente interroga il lettore. Una complessità che investe prima di tutto la natura della sua intera produzione. Come spiega Alex R. Falzon nella Postfazione alla presente edizione, il programma letterario di Lowry si basa su un metodo di lavoro eccentrico, originale e, forse, eccessivamente ambizioso. Tutte le sue opere contribuiscono alla realizzazione di un unico, immenso progetto, un vero e proprio ciclo, di cui ogni romanzo o racconto costituisce un tassello, indispensabile per la costruzione del disegno finale, dal titolo “Il viaggio che non ha fine”.
Si legge questo libro come tributo al Console di “Sotto il vulcano”, come un pegno pagato alla nostalgia che il protagonista del romanzo più famoso di Lowry, ma anche le atmosfere e i luoghi in cui si aggira quell’indimenticabile “divagatore alcolizzato” lasciano nel lettore. C’è un legame talmente stretto tra i due romanzi, che non è quasi possibile comprendere e apprezzare questo “Buio come la tomba dove giace il mio amico”, così colmo di allusioni, ricordi e riferimenti all’opera precedente, prescindendo dalla sua conoscenza o, addirittura, in molti casi, dalla sua puntuale consultazione. Eppure non si tratta di una semplice continuazione; d’altra parte Lowry può essere definito in molti modi, ma sicuramente è uno scrittore tutt’altro che semplice. Il suo fascino risiede tra le pieghe di una complessità che continuamente interroga il lettore. Una complessità che investe prima di tutto la natura della sua intera produzione. Come spiega Alex R. Falzon nella Postfazione alla presente edizione, il programma letterario di Lowry si basa su un metodo di lavoro eccentrico, originale e, forse, eccessivamente ambizioso. Tutte le sue opere contribuiscono alla realizzazione di un unico, immenso progetto, un vero e proprio ciclo, di cui ogni romanzo o racconto costituisce un tassello, indispensabile per la costruzione del disegno finale, dal titolo “Il viaggio che non ha fine”.