ERNST WEISS – La prova del fuoco – SILVY edizioni
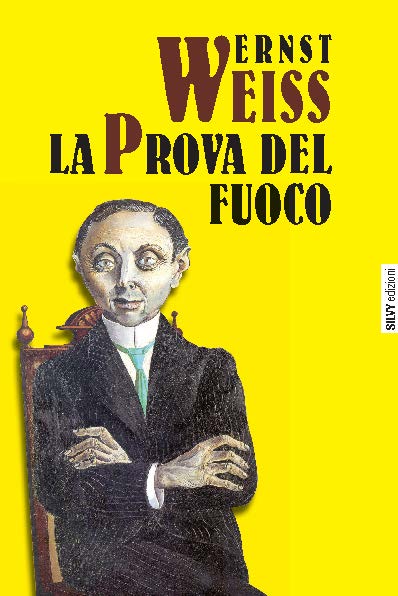 “La prova del fuoco” di Ernst Weiss è un libro che stupisce, interroga, ferisce e crea un disagio che procede di pari passo con una progressiva e infine convinta ammirazione. Un libro che sottopone lo stesso lettore ad una prova rigorosa e severa. Non esistono in queste pagine cedimenti o sconti, né per il protagonista, né per lo scrittore, né, tantomeno, per il lettore. “Tutta questa letteratura è assalto al limite”: così Kafka scriveva nei suoi “Diari” nel 1922, riferendosi alla produzione letteraria della sua generazione di scrittori ebreo tedeschi praghesi. E non credo che si possa dare di questo romanzo una definizione più calzante. Queste pagine sono un assalto al limite, una cavalcata verso l’indicibile, un’energica spallata ad ogni codificata regola della narrazione. Già leggendo la prima pagina – lo splendido incipit che emoziona per la sua lucidità, per il suo essere refrattario ad ogni trucco psicologico o sentimentale, per la sua eloquenza intellettuale – mi chiedevo dove la mia esperienza di lettrice avesse incontrato una sensazione di desolante spaesamento paragonabile a quella costruita da Weiss, una simile sensazione di assoluta abdicazione, un simile assalto al limite ultimo che è, forse, quello dell’identità. “Non so chi ero, non so chi sono. Non so chi sia l’uomo che scrive questo resoconto e definisce tutto ciò che segue realtà, non sogno”.
“La prova del fuoco” di Ernst Weiss è un libro che stupisce, interroga, ferisce e crea un disagio che procede di pari passo con una progressiva e infine convinta ammirazione. Un libro che sottopone lo stesso lettore ad una prova rigorosa e severa. Non esistono in queste pagine cedimenti o sconti, né per il protagonista, né per lo scrittore, né, tantomeno, per il lettore. “Tutta questa letteratura è assalto al limite”: così Kafka scriveva nei suoi “Diari” nel 1922, riferendosi alla produzione letteraria della sua generazione di scrittori ebreo tedeschi praghesi. E non credo che si possa dare di questo romanzo una definizione più calzante. Queste pagine sono un assalto al limite, una cavalcata verso l’indicibile, un’energica spallata ad ogni codificata regola della narrazione. Già leggendo la prima pagina – lo splendido incipit che emoziona per la sua lucidità, per il suo essere refrattario ad ogni trucco psicologico o sentimentale, per la sua eloquenza intellettuale – mi chiedevo dove la mia esperienza di lettrice avesse incontrato una sensazione di desolante spaesamento paragonabile a quella costruita da Weiss, una simile sensazione di assoluta abdicazione, un simile assalto al limite ultimo che è, forse, quello dell’identità. “Non so chi ero, non so chi sono. Non so chi sia l’uomo che scrive questo resoconto e definisce tutto ciò che segue realtà, non sogno”.
 “Da chi, da che cosa sono dunque posseduto?, mi chiesi ancora aprendo la finestra.”
“Da chi, da che cosa sono dunque posseduto?, mi chiesi ancora aprendo la finestra.”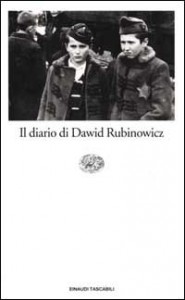 “Siamo preparati a tutto a braccia aperte”
“Siamo preparati a tutto a braccia aperte”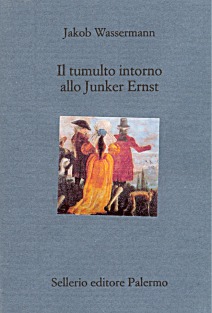 Essere ebreo, povero e tedesco, e vivere gli anni della propria maturazione intellettuale nel difficilissimo periodo del primo dopoguerra, assistere con lucida consapevolezza alla inarrestabile ascesa politica del nazismo, spegnersi infine un anno dopo la nomina di Hitler a cancelliere del Reich, prevedendo i cupi scenari che si andavano preparando per la Germania e per il mondo e portando con sé il dolore di non aver potuto pubblicare il suo ultimo romanzo nella sua patria, perché nessuna casa editrice tedesca era disposta ad accettare l’opera di un autore di origine ebraica. Questa è stata la sorte di uno scrittore, nonostante tutto, molto prolifico, apprezzato e amato da tanti grandi intellettuali a lui contemporanei, ma di lui molto più noti. Suo amico, estimatore e nume tutelare, Thomas Mann, affida ad una sorta di necrologio , lo scritto “Un saluto a Jakob Wassermann”, non solo l’espressione dei suoi sentimenti per l’amico, ma anche una indicazione di lettura, semplice ed efficace, il punto di vista da cui partire per apprezzare la sua opera: “Chi o che cosa è Jakob Wassermann? Un narratore. Egli è innanzitutto nient’altro che questo. Un favoleggiatore di sangue e d’istinto, nessun altro tra noi è come lui. Talvolta gli ho detto, scherzando, che potrebbe starsene seduto, a gambe incrociate, sulla riva degli Schiavoni, o in qualche mercato orientale, e narrare – narrare – e la gente starebbe attorno a lui ad ascoltarlo, con gli occhi sgranati e la bocca spalancata”. Ebbene, credo che nessuna delle opere di Wassermann corrisponda maggiormente – per struttura, ambientazione, personaggi – all’osservazione di Thomas Mann, del romanzo “Il tumulto intorno allo Junker Ernst”.
Essere ebreo, povero e tedesco, e vivere gli anni della propria maturazione intellettuale nel difficilissimo periodo del primo dopoguerra, assistere con lucida consapevolezza alla inarrestabile ascesa politica del nazismo, spegnersi infine un anno dopo la nomina di Hitler a cancelliere del Reich, prevedendo i cupi scenari che si andavano preparando per la Germania e per il mondo e portando con sé il dolore di non aver potuto pubblicare il suo ultimo romanzo nella sua patria, perché nessuna casa editrice tedesca era disposta ad accettare l’opera di un autore di origine ebraica. Questa è stata la sorte di uno scrittore, nonostante tutto, molto prolifico, apprezzato e amato da tanti grandi intellettuali a lui contemporanei, ma di lui molto più noti. Suo amico, estimatore e nume tutelare, Thomas Mann, affida ad una sorta di necrologio , lo scritto “Un saluto a Jakob Wassermann”, non solo l’espressione dei suoi sentimenti per l’amico, ma anche una indicazione di lettura, semplice ed efficace, il punto di vista da cui partire per apprezzare la sua opera: “Chi o che cosa è Jakob Wassermann? Un narratore. Egli è innanzitutto nient’altro che questo. Un favoleggiatore di sangue e d’istinto, nessun altro tra noi è come lui. Talvolta gli ho detto, scherzando, che potrebbe starsene seduto, a gambe incrociate, sulla riva degli Schiavoni, o in qualche mercato orientale, e narrare – narrare – e la gente starebbe attorno a lui ad ascoltarlo, con gli occhi sgranati e la bocca spalancata”. Ebbene, credo che nessuna delle opere di Wassermann corrisponda maggiormente – per struttura, ambientazione, personaggi – all’osservazione di Thomas Mann, del romanzo “Il tumulto intorno allo Junker Ernst”.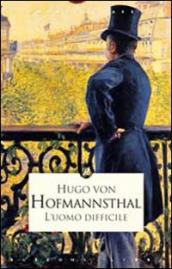
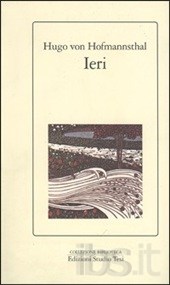 “E non si muta forse in metafora ogni cosa
“E non si muta forse in metafora ogni cosa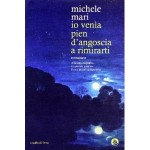 “Orazio, quando tu guardi la candida Luna, come puoi dire che non sia Ella a guardare te?”
“Orazio, quando tu guardi la candida Luna, come puoi dire che non sia Ella a guardare te?”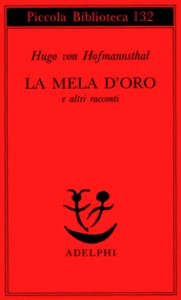 “Eppure non aveva mai il pensiero che osservassero lui di persona, lui che passava in quel punto a capo chino, o si inginocchiava presso un garofano per legarlo con un filo di rafia, o si curvava sotto i rami; ma gli pareva che guardassero l’intera sua vita, la sostanza più profonda del suo essere, quella sua incomprensibile insufficienza umana”.
“Eppure non aveva mai il pensiero che osservassero lui di persona, lui che passava in quel punto a capo chino, o si inginocchiava presso un garofano per legarlo con un filo di rafia, o si curvava sotto i rami; ma gli pareva che guardassero l’intera sua vita, la sostanza più profonda del suo essere, quella sua incomprensibile insufficienza umana”.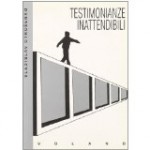 “Tutto sarà scritto. E tutto sarà scritto così come deve essere scritto”
“Tutto sarà scritto. E tutto sarà scritto così come deve essere scritto”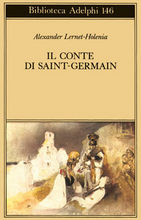 “Adesso invece, se pure [le ombre dei morti] potessero ritornare e davvero ritornassero, non sarebbero più un conforto per noi. Perfino le ombre più care si aggirerebbero sconsolate in questo tempo profanato – o basta già invecchiare per rimanere profanati noi pure? Anzi forse, se ci scorgessero, si deciderebbero anch’esse, piangendo e gemendo, a fare quel che il tempo già fa: distruggerci”.
“Adesso invece, se pure [le ombre dei morti] potessero ritornare e davvero ritornassero, non sarebbero più un conforto per noi. Perfino le ombre più care si aggirerebbero sconsolate in questo tempo profanato – o basta già invecchiare per rimanere profanati noi pure? Anzi forse, se ci scorgessero, si deciderebbero anch’esse, piangendo e gemendo, a fare quel che il tempo già fa: distruggerci”.