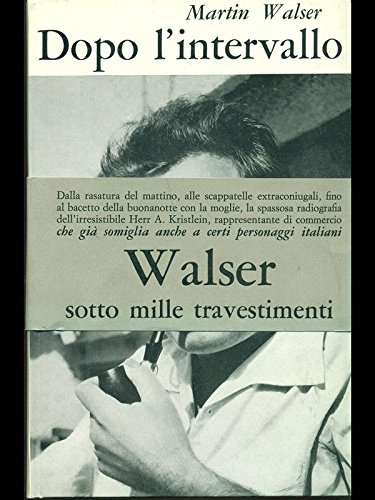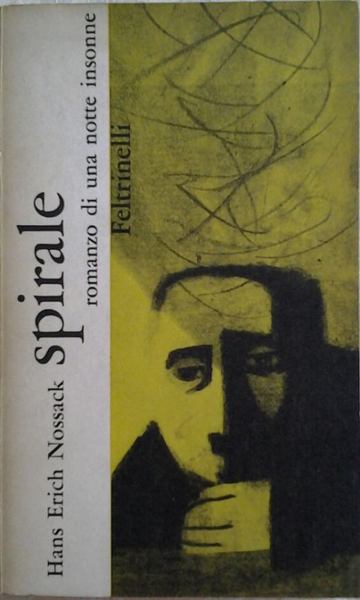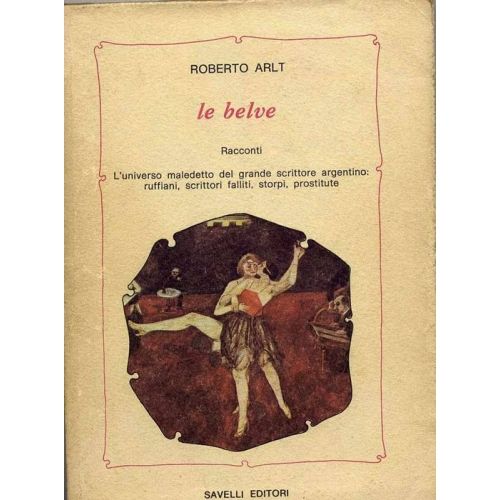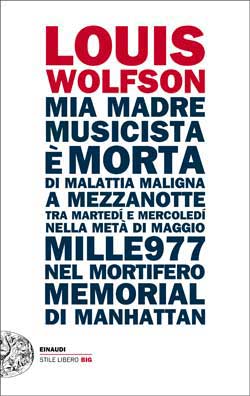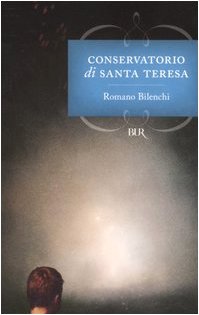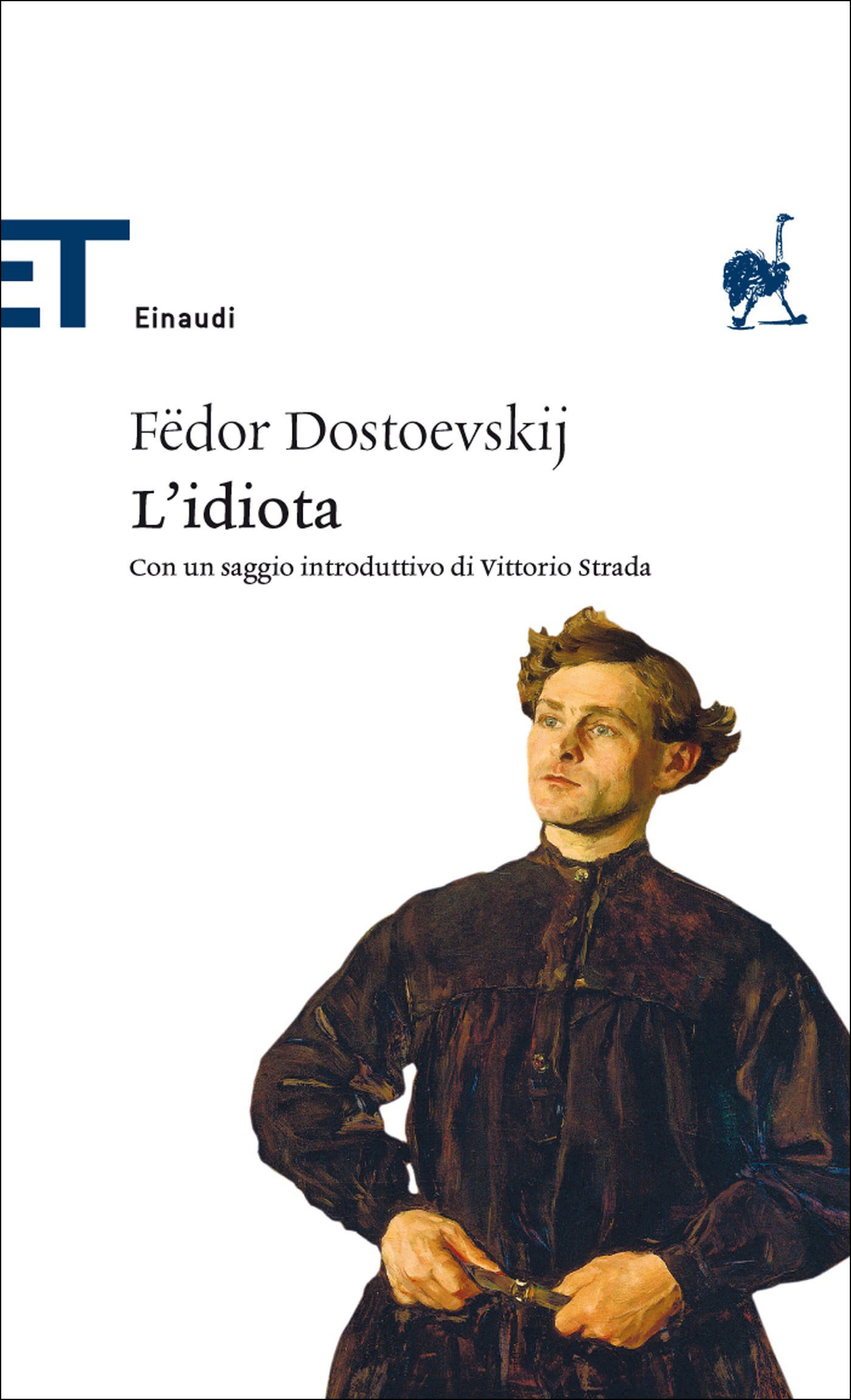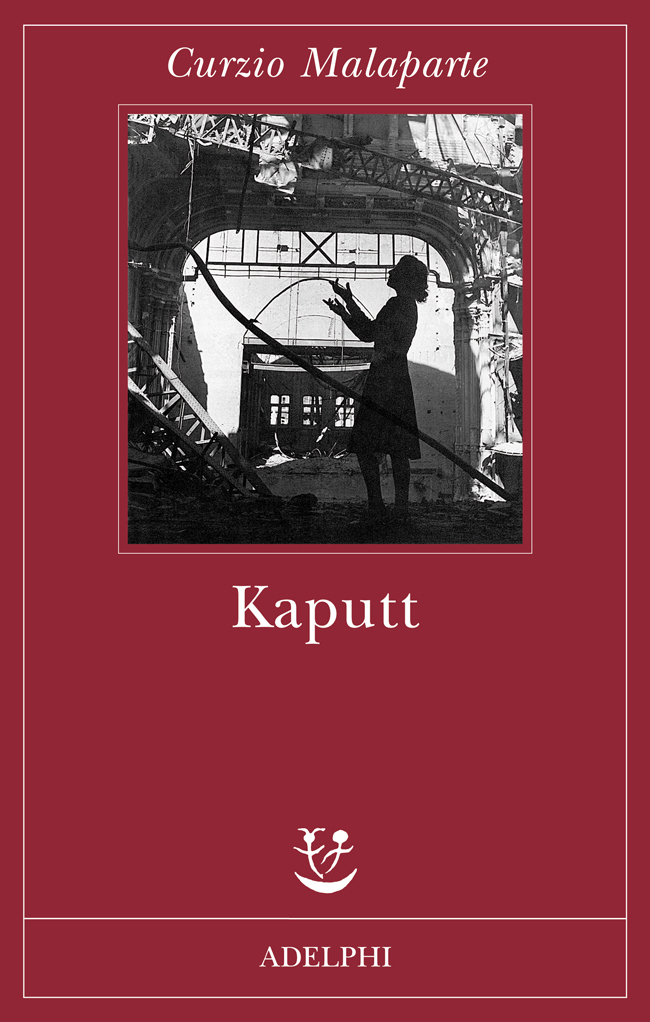MAURIZIO SALABELLE – La famiglia che perse tempo – Quodlibet
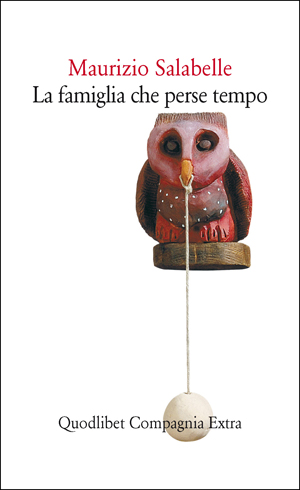 “Abbiamo solo cambiato casa trasferendoci dirimpetto, – sentenziò durante una cena nella quale eravamo tutti annoiati – eppure, come se si fosse verificato un rivolgimento tellurico, vediamo tutto secondo un altro punto di vista. Ciò dovrebbe indurci a riflettere, farci rendere conto dell’assoluta relatività di ogni visione del mondo”.
“Abbiamo solo cambiato casa trasferendoci dirimpetto, – sentenziò durante una cena nella quale eravamo tutti annoiati – eppure, come se si fosse verificato un rivolgimento tellurico, vediamo tutto secondo un altro punto di vista. Ciò dovrebbe indurci a riflettere, farci rendere conto dell’assoluta relatività di ogni visione del mondo”.
Con questo romanzo vede la luce la creatura letteraria di Salabelle, un essere talmente disarmato e disarmante da suscitare fin da subito una disperata affezione nel lettore che, pagina dopo pagina, si ritrova in bilico tra lo sconcerto per la sua inconcludente inettitudine, la risata per la irresistibile comicità delle situazioni che lo vedono coinvolto e l’irrimediabile pena, con tanto di stretta al cuore, per quella sua esibita incapacità di districarsi tra le inezie del quotidiano, per quello stupito candore con cui osserva il mondo. E considerando quel suo essere uno zero, uno zero spaccato, una nullità, come non pensare agli antieroi di Robert Walser, all’aria delle “regioni inferiori” che essi respirano, alla dismissione, alla resa, al loro chiamarsi fuori dalla lotta per la sopravvivenza, per il riconoscimento sociale, l’apprezzamento, il prestigio, per la realizzazione di sé; come non avvertire l’impressione liberatoria di una atmosfera straniante e allucinata, ma appena di un passo fuori dalla mischia, di una dimensione insomma insieme vagamente familiare e del tutto inedita e stupefacente?