MARIO BENEDETTI – La tregua – nottetempo
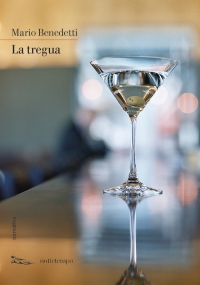 “Poi, all’improvviso, ho avuto coscienza che quel momento, quel frammento di quotidianità, era il grado massimo del benessere, la Felicità. Mai ero stato tanto pienamente felice come in quel momento, tuttavia avevo la dolorosa sensazione che mai più lo sarei stato, almeno con quella forza, con quell’intensità. L’apice è così, esattamente così. Come se non bastasse, sono certo che l’apice duri solo un secondo, un breve istante, la durata di un lampo, e non si ha diritto a proroghe”.
“Poi, all’improvviso, ho avuto coscienza che quel momento, quel frammento di quotidianità, era il grado massimo del benessere, la Felicità. Mai ero stato tanto pienamente felice come in quel momento, tuttavia avevo la dolorosa sensazione che mai più lo sarei stato, almeno con quella forza, con quell’intensità. L’apice è così, esattamente così. Come se non bastasse, sono certo che l’apice duri solo un secondo, un breve istante, la durata di un lampo, e non si ha diritto a proroghe”.
Quello che leggiamo in queste pagine è il diario di un anno, di un lungo e brevissimo anno, un tempo su cui l’amore ha impresso il suo sigillo, che è insieme medaglia e ferita, segno distintivo di straordinaria eccezionalità e dolore che scava nella carne e che rende miracolosamente anche l’anima un organo vivo e corporeo che respira e palpita, soffre e sanguina. Il diario di un ultimo amore, uno di quelli che “più degli altri strazia”, perché “lo va nutrendo crudele il ricordare” e, ancora di più, forse, la lucida consapevolezza della sua irripetibilità, e non ha importanza se questa è meramente legata allo scorrere del tempo, al suo farsi giorno per giorno più breve, o alla semplice convinzione che nella quotidianità l’evento miracoloso, quando è veramente tale, quando sollecita il tempo e agisce come intensificatore di attimi, se accade, è per sua natura unico.
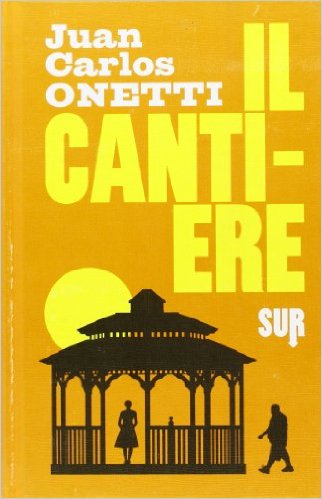
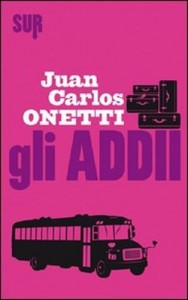
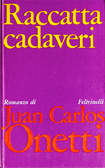
 Per questa notte languida e feroce – che si adagia sensuale su strade e vicoli della città con le sue nubi arrotondate e invade pelle e sguardi; e che interrompe i sogni e risveglia i sensi assopiti con le lame acute delle sue luci gialle – per questa notte avvolta su se stessa, che rimescola le carte e i giochi – così che nei suoi mille angoli la vittima sa di essere un carnefice e il torturatore volge al passato i suoi occhi da segugio e ripercorre i passi della sua ingiusta solitudine.
Per questa notte languida e feroce – che si adagia sensuale su strade e vicoli della città con le sue nubi arrotondate e invade pelle e sguardi; e che interrompe i sogni e risveglia i sensi assopiti con le lame acute delle sue luci gialle – per questa notte avvolta su se stessa, che rimescola le carte e i giochi – così che nei suoi mille angoli la vittima sa di essere un carnefice e il torturatore volge al passato i suoi occhi da segugio e ripercorre i passi della sua ingiusta solitudine. Permane, alla fine di questo lungo – e travolgente e sorprendente – romanzo, una vaga nostalgia di stanze chiuse, quasi sempre notturne, con le finestre spalancate su un vento fresco e nero, o serali, con i rumori consueti delle esistenze che si ritirano. Permangono le immagini di innumerevoli oggetti che popolano questi interni, minuziosamente ripresi nelle vaghe sfumature che la luce disegna su di loro. Locali notturni, oppure uffici, camere d’albergo, caffè, ambulatori: una maestria descrittiva che si dipana con una lentezza che si fa spesso sontuosa nel delineare gli ambiti essenziali ai quali si aggrappa una narrazione che prolifera e lievita, a partire da un punto di non ritorno. Perché come si torna indietro dalla fredda constatazione che la vita – qualsiasi vita – è, o diventerà prima o poi, disperata e disperante? E come si continua a vivere con “la sicurezza indimenticabile che non c’è in nessun luogo una donna, un amico, una casa, un libro, nemmeno un vizio, che possano farmi felice”, come constata lucidamente Juan Maria Brausen, il protagonista del libro? Il romanzo di Onetti inizia dunque dove tante opere della più grande letteratura finiscono: dalla constatazione che la vita è fatta di malintesi e che non c’è via d’uscita, che la condizione più naturale per l’uomo è quella del disperato (che sia disperato puro, “incapace di innalzarsi fino all’altezza della sua prova”, oppure disperato debole e impuro, “che proclamerà la propria disperazione sistematicamente e pazientemente […] e sarà sempre in grado di creare il piccolo mondo di cui ha bisogno, sarà sempre disposto a piegarsi, ad assopirsi”, oppure disperato forte, che “sa o è convinto che nessuno potrà consolarlo”, ma che è disposto in qualsiasi momento ad “affrontare la propria disperazione, isolarla, guardarla in faccia”, secondo la onettiana, personalissima teoria della disperazione), perché non si sfugge alla disillusione, alla corruzione della malattia e della vecchiaia, alla scomparsa delle persone care o, peggio, dei sentimenti che un tempo si provavano per loro. Anche se pare che questa consapevolezza sia un dono terribile riservato ad alcuni, perché tanti invece avanzano sicuri “verso il mondo poetico, musicale e plastico del domani”.
Permane, alla fine di questo lungo – e travolgente e sorprendente – romanzo, una vaga nostalgia di stanze chiuse, quasi sempre notturne, con le finestre spalancate su un vento fresco e nero, o serali, con i rumori consueti delle esistenze che si ritirano. Permangono le immagini di innumerevoli oggetti che popolano questi interni, minuziosamente ripresi nelle vaghe sfumature che la luce disegna su di loro. Locali notturni, oppure uffici, camere d’albergo, caffè, ambulatori: una maestria descrittiva che si dipana con una lentezza che si fa spesso sontuosa nel delineare gli ambiti essenziali ai quali si aggrappa una narrazione che prolifera e lievita, a partire da un punto di non ritorno. Perché come si torna indietro dalla fredda constatazione che la vita – qualsiasi vita – è, o diventerà prima o poi, disperata e disperante? E come si continua a vivere con “la sicurezza indimenticabile che non c’è in nessun luogo una donna, un amico, una casa, un libro, nemmeno un vizio, che possano farmi felice”, come constata lucidamente Juan Maria Brausen, il protagonista del libro? Il romanzo di Onetti inizia dunque dove tante opere della più grande letteratura finiscono: dalla constatazione che la vita è fatta di malintesi e che non c’è via d’uscita, che la condizione più naturale per l’uomo è quella del disperato (che sia disperato puro, “incapace di innalzarsi fino all’altezza della sua prova”, oppure disperato debole e impuro, “che proclamerà la propria disperazione sistematicamente e pazientemente […] e sarà sempre in grado di creare il piccolo mondo di cui ha bisogno, sarà sempre disposto a piegarsi, ad assopirsi”, oppure disperato forte, che “sa o è convinto che nessuno potrà consolarlo”, ma che è disposto in qualsiasi momento ad “affrontare la propria disperazione, isolarla, guardarla in faccia”, secondo la onettiana, personalissima teoria della disperazione), perché non si sfugge alla disillusione, alla corruzione della malattia e della vecchiaia, alla scomparsa delle persone care o, peggio, dei sentimenti che un tempo si provavano per loro. Anche se pare che questa consapevolezza sia un dono terribile riservato ad alcuni, perché tanti invece avanzano sicuri “verso il mondo poetico, musicale e plastico del domani”. “Tu non hai bisogno, a volte, di una grande solitudine?”
“Tu non hai bisogno, a volte, di una grande solitudine?”