INGEBORG BACHMANN – Non conosco mondo migliore – Guanda
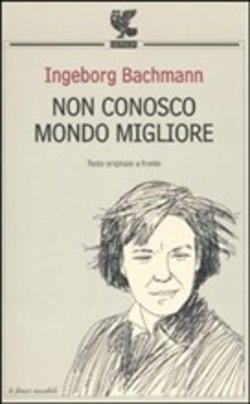 “… non vedete amici/ non lo vedete/ che dappertutto/ incomincio a scavare la mia/ mia tomba,/ anche in questa carta/ incido il mio nome e/ penso che non vorrei riposare/ ancora, che non riposerò/ mai, che/ persiste questo ferro/ nel corpo, questo pugno sul/ cranio, questa frusta/ sulla schiena…”
“… non vedete amici/ non lo vedete/ che dappertutto/ incomincio a scavare la mia/ mia tomba,/ anche in questa carta/ incido il mio nome e/ penso che non vorrei riposare/ ancora, che non riposerò/ mai, che/ persiste questo ferro/ nel corpo, questo pugno sul/ cranio, questa frusta/ sulla schiena…”
La storia editoriale di questa raccolta poetica è l’esito di una consapevole violazione della volontà della poetessa che non aveva destinato alla pubblicazione i testi che la compongono, una violazione perpetrata per amore, per ammirazione, per la caparbia volontà di non privare i lettori di accenti poetici – forse non del tutto rifiniti, in alcuni casi ancora in fieri, in altri già prorompenti e sospesi come grida, o gementi come sussurri – di una maturità, dolente e ferita, ma splendida nella sua capacità di domare e asservire il ritmo, di controllarlo per condurlo alla rottura ed alla esplosione, di costringere le parole ad una verità forse crudele, ma finalmente autentica, sempre sorprendente e viva, anche quando corteggia la morte. Una violazione perpetrata da Isolde Moser e da Heinz Bachmann, i fratelli della poetessa, incoraggiati in questa loro opera, di ricerca, raccolta, ricostruzione commossa a quasi trent’anni dalla morte della sorella, tra gli altri, da Hans Holler, l’autore de “La follia dell’assoluto”, un libro che è molto più di una biografia e che si configura come una vera e propria guida alla scoperta della iniziazione, della costruzione e della progressiva crescita di un intero mondo intellettuale e poetico, della formazione e dello sviluppo di quella acuta e intelligente sensibilità che ha lasciato la sua impronta anche in ognuno di questi versi, perentori, interlocutori, visionari, sofferenti fino alle soglie del pianto, drammatici e lucidi nel decantare il desiderio di autodistruzione.
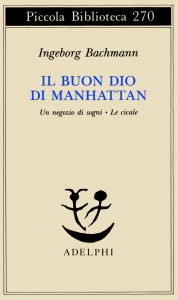
 “Ho scoperto di non appartenere più a nessun paese, non ho più nostalgia di nessun posto, una volta era diverso, una volta credevo di avere un cuore e di appartenere all’Austria. Ma tutto passa prima o poi, il cuore vien meno e una certa mentalità va perduta, solo che sento in me qualcosa che sanguina, e non so cos’è”.
“Ho scoperto di non appartenere più a nessun paese, non ho più nostalgia di nessun posto, una volta era diverso, una volta credevo di avere un cuore e di appartenere all’Austria. Ma tutto passa prima o poi, il cuore vien meno e una certa mentalità va perduta, solo che sento in me qualcosa che sanguina, e non so cos’è”.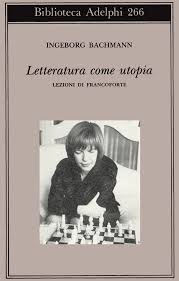 “Ferito di realtà e in cerca di realtà, consegna la propria esistenza alla lingua” (Paul Celan)
“Ferito di realtà e in cerca di realtà, consegna la propria esistenza alla lingua” (Paul Celan) Rileggo spesso le liriche della Bachmann e, tra quelle contenute nella raccolta “Invocazione all’Orsa Maggiore”, ancora più spesso i “Lieder auf der Flucht”, i “Canti lungo la fuga”. Principalmente per la consapevolezza che non esiste la possibilità di dichiarare finita, terminata, la lettura della poesia, quando è grande poesia, e poi, probabilmente, anche per convincermi che sia veramente esistita una simile voce poetica, una simile voce poetica femminile. Fuga, “Flucht”, è un termine che ricorre spesso nel lessico poetico della Bachmann; i suoi versi sottendono spesso un movimento, un allontanamento o, al massimo, delle soste precarie e momentanee, già consapevoli della propria transitorietà. Forse rileggo così spesso questi “Canti” perché, nel mio immaginario, sono quelli che meglio rappresentano il soggetto poetico che li ha generati, la sua anima così complessa e contraddittoria, ritrosa ma anche votata all’espressione di sé. Perché la Bachmann sembra costantemente negarsi, ma anche concedersi, sembra esistere di un’esistenza perentoria ed esigente, nelle brevi soste di una vita interiore da fuggitiva.
Rileggo spesso le liriche della Bachmann e, tra quelle contenute nella raccolta “Invocazione all’Orsa Maggiore”, ancora più spesso i “Lieder auf der Flucht”, i “Canti lungo la fuga”. Principalmente per la consapevolezza che non esiste la possibilità di dichiarare finita, terminata, la lettura della poesia, quando è grande poesia, e poi, probabilmente, anche per convincermi che sia veramente esistita una simile voce poetica, una simile voce poetica femminile. Fuga, “Flucht”, è un termine che ricorre spesso nel lessico poetico della Bachmann; i suoi versi sottendono spesso un movimento, un allontanamento o, al massimo, delle soste precarie e momentanee, già consapevoli della propria transitorietà. Forse rileggo così spesso questi “Canti” perché, nel mio immaginario, sono quelli che meglio rappresentano il soggetto poetico che li ha generati, la sua anima così complessa e contraddittoria, ritrosa ma anche votata all’espressione di sé. Perché la Bachmann sembra costantemente negarsi, ma anche concedersi, sembra esistere di un’esistenza perentoria ed esigente, nelle brevi soste di una vita interiore da fuggitiva. “Ci sono giorni in cui vorrei soltanto andare via e venire a Parigi, sentire come tu afferri le mie mani e mi tocchi con i fiori e di nuovo non sapere da dove vieni e dove vai. Per me tu vieni dall’India o da un paese ancora più remoto, scuro, bruno, per me tu sei il deserto e il mare e tutto quanto è mistero. Ancora non so nulla di te e per questo ho paura per te, non riesco a immaginare che tu debba fare le stesse cose che facciamo qui noi altri, dovrei avere un castello per noi e portarti da me, perchè lì dentro tu possa essere il mio incantato Signore, tappeti molti avremo e musica e inventeremo l’amore”.
“Ci sono giorni in cui vorrei soltanto andare via e venire a Parigi, sentire come tu afferri le mie mani e mi tocchi con i fiori e di nuovo non sapere da dove vieni e dove vai. Per me tu vieni dall’India o da un paese ancora più remoto, scuro, bruno, per me tu sei il deserto e il mare e tutto quanto è mistero. Ancora non so nulla di te e per questo ho paura per te, non riesco a immaginare che tu debba fare le stesse cose che facciamo qui noi altri, dovrei avere un castello per noi e portarti da me, perchè lì dentro tu possa essere il mio incantato Signore, tappeti molti avremo e musica e inventeremo l’amore”.