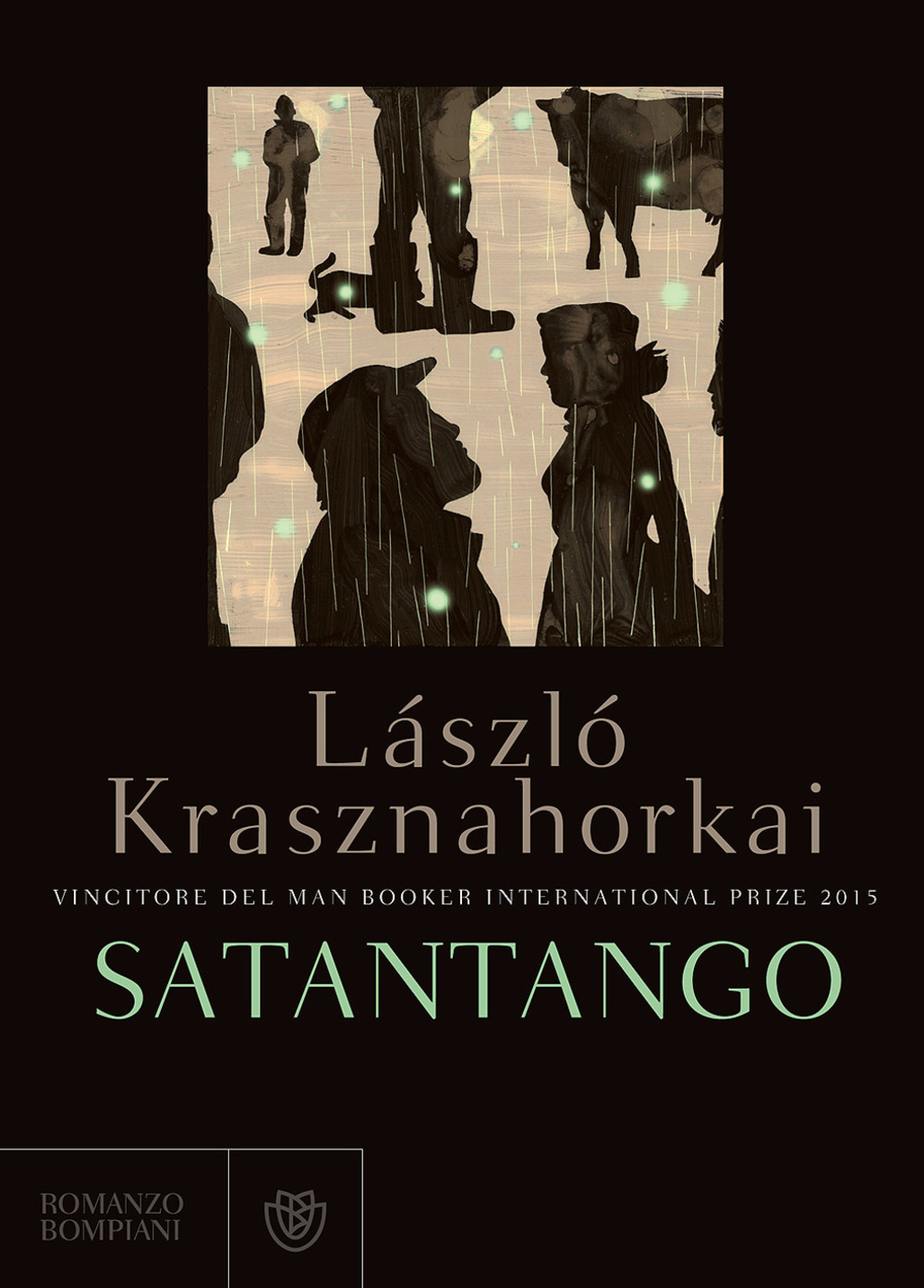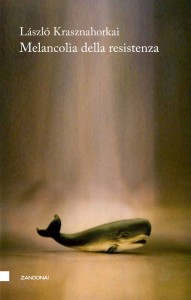LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI – Satantango – Bompiani
“Cullati dai suoni vellutati della fisarmonica, i ragni della kocsma si lanciarono al loro ultimo attacco. Fecero calare leggere reti sopra le bottiglie, i bicchieri, le tazze, i posacenere, circondarono le gambe dei tavoli e delle sedie, dopo di che – con alcuni lievissimi fili segreti – congiunsero tra loro quelle reti, come se per loro fosse importante percepire ogni minimo movimento, ogni più piccolo fremito, nascosti nelle loro tane oscure e insvelate, finchè quella loro rete misteriosa, perfetta e quasi invisibile, rimaneva inviolata. Intrecciarono i visi degli addormentati, i loro piedi e le loro mani, poi velocissimi corsero a nascondersi nei loro rifugi, per poter ricominciare quel criptico lavorio in attesa del fremito di uno di quei fili tenui come un soffio”.
Così termina la prima parte di “Satantango” e anche il capitolo dedicato a quel tango “satanico” da cui ha origine il titolo musicale, misterioso e anche vagamente inquietante del romanzo, capitolo centrale nell’economia della narrazione, perché prelude ad una svolta, pone termine ad una lunga attesa, celebrando una sorta di rito pagano, dionisiaco si potrebbe dire, perché l’alcool e il ritmo lento e suadente della fisarmonica induce tutti i presenti – il gruppo di protagonisti di questo romanzo corale – ad abbandonare i propri freni inibitori e a lasciarsi trasportare dalla travolgente e nostalgica melodia. E nessuno fa più caso al fatto che la danza calpesti il pavimento lurido di una bettola circondata dal nulla, che i cavalieri siano uomini abbruttiti dalla fatica di una vita precaria e senza speranza, che le dame siano donne squallide e volgari e che tutti indifferentemente siano sotto l’effetto dei litri di pálinka (il tradizionale liquore ungherese) ingurgitati con ingordigia e disperazione.