THOMAS BERNHARD – “Piazza degli eroi” – Garzanti
Traduzione di Rolando Zorzi
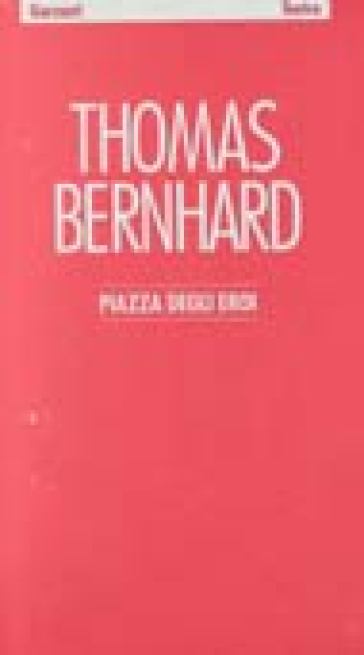
“E’ tutto in via di estinzione”
Prima di tutto qualche data, per cogliere appieno l’importanza di “Piazza degli eroi” (“Heldenplatz”) all’interno della produzione teatrale, ma anche più genericamente letteraria, bernhardiana. L’opera viene pubblicata nel 1988 e rappresentata per la prima volta al Burgtheater di Vienna il 4 novembre dello stesso anno, per la regia di Claus Peymann. L’ultimo romanzo di Bernhard, “Estinzione” era stato pubblicato due anni prima, nel 1986. Il 12 febbraio 1989 Bernhard muore. Siamo quindi giunti con questo dramma alla conclusione della parabola teatrale del suo autore, ovvero, come ben sottolinea Eugenio Bernardi, al punto “massimo di quella provocazione cui mirava da sempre il suo teatro”. Esattamente come, sul piano della narrativa, “Estinzione” rappresenta il tentativo, attuato mediante le raffinate armi letterarie a cui questo autore ha abituato i suoi lettori, di cancellare, di estinguere, uno per uno, i temi portanti della sua architettura artistica. Bernhard conclude quindi portando al massimo grado possibile la sua arte della provocazione e della esagerazione, consapevole che, esagerando la realtà, può renderla insopportabile e, quindi, distruggerla. Ci si può chiedere se fosse consapevole dell’avvicinarsi della fine, ma la sua stessa biografia ci dice che Bernhard ha sempre vissuto sapendo di portare con sé la propria morte, di allevare dentro di sé la propria malattia mortale e quindi questa è, in definitiva, una domanda inutile.
 A lezione da un maestro
A lezione da un maestro “Vidal pensò che nella vita arriva sicuramente un momento in cui una persona, qualunque cosa faccia, annoia soltanto. Resta allora solo un modo per recuperare il prestigio: morire”.
“Vidal pensò che nella vita arriva sicuramente un momento in cui una persona, qualunque cosa faccia, annoia soltanto. Resta allora solo un modo per recuperare il prestigio: morire”. “Tu non hai bisogno, a volte, di una grande solitudine?”
“Tu non hai bisogno, a volte, di una grande solitudine?”
 “Lo so.
“Lo so. Un’incursione nella letteratura americana contemporanea, un breve soggiorno in un territorio che non è il mio, l’incontro con una scrittura nitida, cristallina e sorprendentemente onesta. Dieci racconti brevi, nei quali è racchiuso un paesaggio, che diventa immediatamente familiare, ed entro i quali si muovono personaggi che non sembrano aver bisogno di una riga in più per manifestare la loro essenza. Richard Ford mi ha riservato parecchie sorprese, prima fra tutte quella di uno stile che permette al lettore di entrare con facilità nel suo mondo letterario, cosa per nulla semplice né scontata. Ci si accorge presto leggendo questi racconti che i loro incipit, diretti, essenziali, quasi affrettati, hanno lo scopo di preparare il terreno, di disegnare delle coordinate, di delineare il quadro generale di una situazione che, nel corso del racconto, in un modo o nell’altro, subirà un mutamento decisivo e che proprio su questo mutamento l’autore vuole che il lettore si soffermi. Come, d’altra parte, ci si abitua presto ad individuare il punto in cui, in ogni racconto, la penna di Ford rallenta fino alla sospensione, si impadronisce di un piccolo squarcio di realtà, di un particolare in apparenza insignificante, e lo trasforma in qualcosa di prezioso, lirico e persino commovente.
Un’incursione nella letteratura americana contemporanea, un breve soggiorno in un territorio che non è il mio, l’incontro con una scrittura nitida, cristallina e sorprendentemente onesta. Dieci racconti brevi, nei quali è racchiuso un paesaggio, che diventa immediatamente familiare, ed entro i quali si muovono personaggi che non sembrano aver bisogno di una riga in più per manifestare la loro essenza. Richard Ford mi ha riservato parecchie sorprese, prima fra tutte quella di uno stile che permette al lettore di entrare con facilità nel suo mondo letterario, cosa per nulla semplice né scontata. Ci si accorge presto leggendo questi racconti che i loro incipit, diretti, essenziali, quasi affrettati, hanno lo scopo di preparare il terreno, di disegnare delle coordinate, di delineare il quadro generale di una situazione che, nel corso del racconto, in un modo o nell’altro, subirà un mutamento decisivo e che proprio su questo mutamento l’autore vuole che il lettore si soffermi. Come, d’altra parte, ci si abitua presto ad individuare il punto in cui, in ogni racconto, la penna di Ford rallenta fino alla sospensione, si impadronisce di un piccolo squarcio di realtà, di un particolare in apparenza insignificante, e lo trasforma in qualcosa di prezioso, lirico e persino commovente. “Benito Cereno” è il racconto che pone termine al decennio creativo di Melville e che prelude al lungo mutismo letterario che continuerà fino alla sua morte, fatta eccezione per la novella “Billy Budd”, composta qualche mese prima della fine. Solo quattro anni separano “Benito Cereno” da “Moby Dick” e Melville condensa qui, in poche pagine, la ricchezza di uno stile sempre più evocativo, basato su simboli e corrispondenze, nell’intento di sondare, ma anche di trasfigurare, i dati della realtà sensibile. E’ inevitabile leggere questo racconto avendo come pietra di paragone “Moby Dick” o, almeno, ricordandone la peculiare caratteristica, quel suo tono mistico di predicazione sacra, che trasfigura la storia di mare in una lotta epica tra bene e male, anzi, nella lotta tra due potenze contrapposte, fatta di vendetta, accanimento, di morbosità, il tutto sostenuto da uno stile di scrittura che si fa a tratti apocalittico. Dopo “Moby Dick”, le storie di mare di Melville non possono trovare il lettore impreparato, dopo “Moby Dick” è chiaro che l’avventura è sporgersi su un abisso, perché, come dice Michele Mari ne “I demoni e la pasta sfoglia”, “Melville sapeva che non c’è conflitto che non renda uguali al nemico, non c’è abisso in cui si possa guardare impunemente”. E quindi, chi si appresta a leggere “Benito Cereno” non si faccia ingannare dall’incipit, classico esordio che sembra preludere ad un canonico racconto di mare, perfettamente in linea con la tradizione ottocentesca, perché bastano poche pagine e ci si ritrova in piena bonaccia, reale e metaforica.
“Benito Cereno” è il racconto che pone termine al decennio creativo di Melville e che prelude al lungo mutismo letterario che continuerà fino alla sua morte, fatta eccezione per la novella “Billy Budd”, composta qualche mese prima della fine. Solo quattro anni separano “Benito Cereno” da “Moby Dick” e Melville condensa qui, in poche pagine, la ricchezza di uno stile sempre più evocativo, basato su simboli e corrispondenze, nell’intento di sondare, ma anche di trasfigurare, i dati della realtà sensibile. E’ inevitabile leggere questo racconto avendo come pietra di paragone “Moby Dick” o, almeno, ricordandone la peculiare caratteristica, quel suo tono mistico di predicazione sacra, che trasfigura la storia di mare in una lotta epica tra bene e male, anzi, nella lotta tra due potenze contrapposte, fatta di vendetta, accanimento, di morbosità, il tutto sostenuto da uno stile di scrittura che si fa a tratti apocalittico. Dopo “Moby Dick”, le storie di mare di Melville non possono trovare il lettore impreparato, dopo “Moby Dick” è chiaro che l’avventura è sporgersi su un abisso, perché, come dice Michele Mari ne “I demoni e la pasta sfoglia”, “Melville sapeva che non c’è conflitto che non renda uguali al nemico, non c’è abisso in cui si possa guardare impunemente”. E quindi, chi si appresta a leggere “Benito Cereno” non si faccia ingannare dall’incipit, classico esordio che sembra preludere ad un canonico racconto di mare, perfettamente in linea con la tradizione ottocentesca, perché bastano poche pagine e ci si ritrova in piena bonaccia, reale e metaforica. Nato nel 1897 e morto nel 1976, Lernet-Holenia ha avuto l’opportunità di essere consapevole testimone del tramonto dell’impero e della nascita del mito asburgico, di quella sua sopravvivenza nella memoria, nel ricordo e nella nostalgia che ha regalato alla letteratura mitteleuropea tante opere di inestimabile valore. La fine di un mondo ha il potere di racchiudere in sé, quasi miracolosamente illuminato, reso tangibile nella sua essenza, depurato da ogni orpello esteriore, ciò di cui era costituito, di fissare per sempre i suoi lineamenti, di renderli immediatamente riconoscibili. Non stupisce quindi il fatto di ritrovare tutto ciò nel romanzo “Lo stendardo”, opera del 1934, perché, come afferma Magris nel suo ricchissimo e fondamentale saggio “Il mito absburgico nella letteratura austriaca moderna”, “Il mito asburgico, lungi dal morire con la fine dell’Impero, sembra anzi avere iniziato con questa la sua più suggestiva e interessante stagione”, d’altra parte il mito non si nutre certo di una realtà oggettiva, ma di memoria e di nostalgia, affidate alla parola. La grande tradizione della narrativa austriaca del Novecento appare permeata, definita e, addirittura sconvolta da una trasformazione così radicale di tutta una civiltà, dal passaggio dalla sicurezza e dall’ordine, alla scoperta del disordine del mondo.
Nato nel 1897 e morto nel 1976, Lernet-Holenia ha avuto l’opportunità di essere consapevole testimone del tramonto dell’impero e della nascita del mito asburgico, di quella sua sopravvivenza nella memoria, nel ricordo e nella nostalgia che ha regalato alla letteratura mitteleuropea tante opere di inestimabile valore. La fine di un mondo ha il potere di racchiudere in sé, quasi miracolosamente illuminato, reso tangibile nella sua essenza, depurato da ogni orpello esteriore, ciò di cui era costituito, di fissare per sempre i suoi lineamenti, di renderli immediatamente riconoscibili. Non stupisce quindi il fatto di ritrovare tutto ciò nel romanzo “Lo stendardo”, opera del 1934, perché, come afferma Magris nel suo ricchissimo e fondamentale saggio “Il mito absburgico nella letteratura austriaca moderna”, “Il mito asburgico, lungi dal morire con la fine dell’Impero, sembra anzi avere iniziato con questa la sua più suggestiva e interessante stagione”, d’altra parte il mito non si nutre certo di una realtà oggettiva, ma di memoria e di nostalgia, affidate alla parola. La grande tradizione della narrativa austriaca del Novecento appare permeata, definita e, addirittura sconvolta da una trasformazione così radicale di tutta una civiltà, dal passaggio dalla sicurezza e dall’ordine, alla scoperta del disordine del mondo. “Dulcamara per Deml e Weiner”
“Dulcamara per Deml e Weiner”