ROMANO BILENCHI – Conservatorio di Santa Teresa – BUR
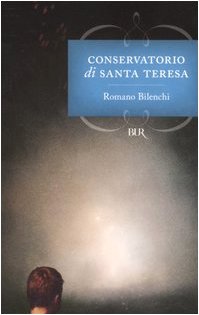 “Anche Santa Teresa con i suoi cortili silenziosi sfumava dolcemente nel suo ricordo. Immaginò di essersi definitivamente staccato da tutte le vicende che avevano formato la sua vita fino ad allora. Credette che senza di lui tutte quelle persone, gli alberi, gli stessi edifici nei quali viveva e che gli erano familiari avrebbero vissuto un’esistenza migliore e più libera”.
“Anche Santa Teresa con i suoi cortili silenziosi sfumava dolcemente nel suo ricordo. Immaginò di essersi definitivamente staccato da tutte le vicende che avevano formato la sua vita fino ad allora. Credette che senza di lui tutte quelle persone, gli alberi, gli stessi edifici nei quali viveva e che gli erano familiari avrebbero vissuto un’esistenza migliore e più libera”.
“Conservatorio di Santa Teresa” è un libro denso, densissimo; ogni suo capitolo possiede un peso specifico tale che lo rende illusoriamente ben più esteso dei tempi narrativi che lo delimitano e indispensabile nell’economia del romanzo, per quell’accumularsi di avventure della percezione che – al di là dell’intreccio – ne costituiscono la sostanza. Avventure della percezione e non della crescita, perché ciò che rende avvincente questo romanzo – che pure ripercorre il passaggio dall’infanzia all’adolescenza del giovane protagonista – non sono gli accadimenti, ma il continuo, ininterrotto accumularsi di sensazioni, le infinite e mutevoli reazioni che, con una intensità e una frequenza esasperante ma al contempo affascinante, il contatto con il mondo esterno provoca nell’animo del protagonista, componendo nella sua memoria interiore, straordinariamente recettiva, un disegno sempre più complesso, confuso e contraddittorio. Bilenchi costringe il lettore a seguire questo percorso che è denso di scarti improvvisi, colpi di scena, soluzioni impreviste, di tutto ciò che si potrebbe definire avventura, se non fosse tutto chiuso all’interno di un’anima – e un’anima bambina – che è una sorta di tabula rasa che va rapidamente accumulando tutto ciò che dovrebbe servirle a farsi un’idea coerente e rassicurante del mondo, ma che in realtà contribuisce ad una sempre più raffinata esperienza di una irriducibile estraneità.

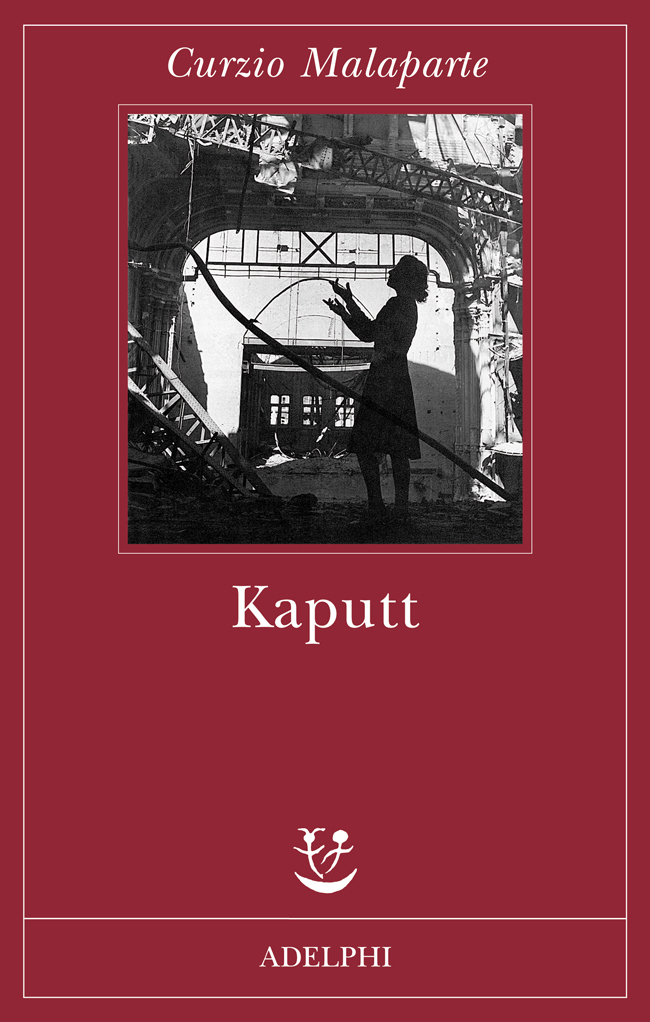
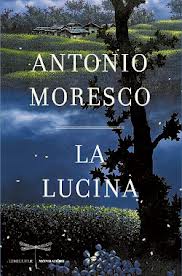
 “Al fondo di ogni creazione c’è la nobile illusione di salvare il mondo. Ma chissà che l’arte non possa avere una funzione medicatrice? In termini banali, chissà che non possa esserci d’aiuto, non possa darci la salvezza procurando sulla nostra scabra pelle di fantocci meccanici una ferita di gioia?” (da “L’arte può salvarci con ferite di gioia. Angelo Maria Ripellino studioso e poeta”, intervista a cura di Corrado Bologna, in “Il nostro tempo”)
“Al fondo di ogni creazione c’è la nobile illusione di salvare il mondo. Ma chissà che l’arte non possa avere una funzione medicatrice? In termini banali, chissà che non possa esserci d’aiuto, non possa darci la salvezza procurando sulla nostra scabra pelle di fantocci meccanici una ferita di gioia?” (da “L’arte può salvarci con ferite di gioia. Angelo Maria Ripellino studioso e poeta”, intervista a cura di Corrado Bologna, in “Il nostro tempo”) “C’è, esiste una persona al mondo, in tutto il mondo popolato di miliardi di corpi della vostra stessa specie, che affronterebbe la morte per voi? Siete vissuti almeno per poter dire a voi stessi di avere avuto in cambio questo? E, quanto a voi, esiste per voi una persona per cui dareste la vita, se fosse lei a trovarsi in una situazione simile?”
“C’è, esiste una persona al mondo, in tutto il mondo popolato di miliardi di corpi della vostra stessa specie, che affronterebbe la morte per voi? Siete vissuti almeno per poter dire a voi stessi di avere avuto in cambio questo? E, quanto a voi, esiste per voi una persona per cui dareste la vita, se fosse lei a trovarsi in una situazione simile?” Avevo un appuntamento con Patrizia Runfola, dovevo incontrarla nella sua Praga; avevo stabilito da tempo questo nostro incontro che mi era sembrato inevitabile già leggendo di lei in “Alfabeti” di Claudio Magris. Non si può evitare di inseguire gli scritti di chi “ha il senso – morale, sensuale e doloroso – della grandezza”. Le parole di Magris su di lei e sulla sua opera, apparse sul Corriere della Sera del 21/04/2000, costituiscono sia la Prefazione alla sua raccolta di racconti “Lezioni di tenebra”, che il suo necrologio, perché la Runfola è morta nel 1999 a quarantotto anni, lasciando nei suoi scritti una traccia persistente di “regale e impavida leggerezza”. Una traccia che il lettore non può evitare di seguire perché costituisce un percorso invitante, una strada ideale da percorrere a ritroso, per giungere al centro esatto di una creatività che sopravvive al suo creatore. “Solo quando le parole abbandonano la mia anima e muoiono sui fogli per continuare a vivere negli sguardi di coloro che un giorno ne ascolteranno la musica lontana, solo allora avverto un magnifico sollievo”, scrive la Runfola all’inizio di una delle sue Lezioni. Ma si dà il caso che il centro esatto di questa anima, l’immagine della sua fantasia e della sua scrittura sia Praga, “con le sue torri, le sue pietre, le sue ombre e la sua stratificata profondità del tempo”.
Avevo un appuntamento con Patrizia Runfola, dovevo incontrarla nella sua Praga; avevo stabilito da tempo questo nostro incontro che mi era sembrato inevitabile già leggendo di lei in “Alfabeti” di Claudio Magris. Non si può evitare di inseguire gli scritti di chi “ha il senso – morale, sensuale e doloroso – della grandezza”. Le parole di Magris su di lei e sulla sua opera, apparse sul Corriere della Sera del 21/04/2000, costituiscono sia la Prefazione alla sua raccolta di racconti “Lezioni di tenebra”, che il suo necrologio, perché la Runfola è morta nel 1999 a quarantotto anni, lasciando nei suoi scritti una traccia persistente di “regale e impavida leggerezza”. Una traccia che il lettore non può evitare di seguire perché costituisce un percorso invitante, una strada ideale da percorrere a ritroso, per giungere al centro esatto di una creatività che sopravvive al suo creatore. “Solo quando le parole abbandonano la mia anima e muoiono sui fogli per continuare a vivere negli sguardi di coloro che un giorno ne ascolteranno la musica lontana, solo allora avverto un magnifico sollievo”, scrive la Runfola all’inizio di una delle sue Lezioni. Ma si dà il caso che il centro esatto di questa anima, l’immagine della sua fantasia e della sua scrittura sia Praga, “con le sue torri, le sue pietre, le sue ombre e la sua stratificata profondità del tempo”. Tutto ciò che viene nutrito è per sua natura destinato a crescere, che si tratti di un organismo vivente, oppure di una passione, o di una ossessione. E queste ultime ancora di più, dovendo rispondere esclusivamente alle proprie leggi interne, e non dovendo sottostare ad alcun limite di spazio e di tempo. Una passione così totalizzante da diventare ossessione, una volta cresciuta e diventata adulta può, in determinate condizioni, dare i suoi frutti. A mio parere è questa l’origine del romanzo che lo stesso Mari definisce “come una vendicativa resa dei conti con una giovinezza interamente dedicata alla letteratura”, oltre che, in modo assertivo, totalizzante, ma anche emozionante, “il libro della mia vita”. Non entro nel merito delle differenze tra questa nuova versione e quella uscita in prima edizione nel 1989, abbondantemente spiegate e motivate dall’autore nella Nota al testo; mi basta sapere che tutte le correzioni sono state “a togliere” e che quindi “l’attuale versione, in ogni sua oltranza di lingua e di stile, era già tutta nella primissima”.
Tutto ciò che viene nutrito è per sua natura destinato a crescere, che si tratti di un organismo vivente, oppure di una passione, o di una ossessione. E queste ultime ancora di più, dovendo rispondere esclusivamente alle proprie leggi interne, e non dovendo sottostare ad alcun limite di spazio e di tempo. Una passione così totalizzante da diventare ossessione, una volta cresciuta e diventata adulta può, in determinate condizioni, dare i suoi frutti. A mio parere è questa l’origine del romanzo che lo stesso Mari definisce “come una vendicativa resa dei conti con una giovinezza interamente dedicata alla letteratura”, oltre che, in modo assertivo, totalizzante, ma anche emozionante, “il libro della mia vita”. Non entro nel merito delle differenze tra questa nuova versione e quella uscita in prima edizione nel 1989, abbondantemente spiegate e motivate dall’autore nella Nota al testo; mi basta sapere che tutte le correzioni sono state “a togliere” e che quindi “l’attuale versione, in ogni sua oltranza di lingua e di stile, era già tutta nella primissima”. “Sono solo, completamente solo. Come si è infinitamente soli, all’inizio! Sono solo come mai è stato nessun altro scrittore di questa specie. Sono lo scrittore di un pianeta e di un mondo che non c’è più, di una specie che non c’è più, che non c’è ancora”
“Sono solo, completamente solo. Come si è infinitamente soli, all’inizio! Sono solo come mai è stato nessun altro scrittore di questa specie. Sono lo scrittore di un pianeta e di un mondo che non c’è più, di una specie che non c’è più, che non c’è ancora”